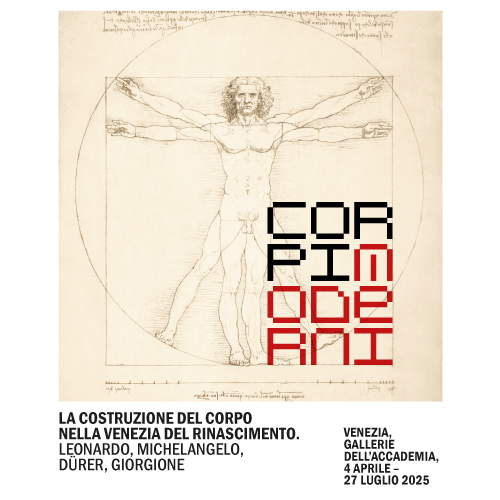Bologna mette a confronto le due Atalante di Guido Reni. Com'è la mostra della Pinacoteca Nazionale
Dovrebbero esserci le code in via delle Belle Arti, dinnanzi all’ingresso della Pinacoteca Nazionale di Bologna, che per tre mesi ha concesso facoltà alla città, all’Italia, a tutti, d’ammirare esposte una accanto all’altra le due versioni dell’Atalanta e Ippomene di Guido Reni, quella del Prado di Madrid e quella del Museo di Capodimonte di Napoli, riunite nel contesto d’una mostra (La favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti, a cura di Giulia Iseppi, Raffaella Morselli e Maria Luisa Pacelli) tesa a esplorare gl’intrecci tra pittura e poesia nella Bologna del primo Seicento, e per di più con importanti scoperte e ricche novità. Dovrebbero esserci le code, ma tanti probabilmente neppure sanno di questo eccezionale raffronto che in Italia manca da quasi quarant’anni e che in tutto il mondo sarebbe annunciato tra squilli, fanfare e tempeste di comunicati e pubblicità: non è stato così, anzi. Davanti ai due grandi dipinti capita anche di stare soli per molti minuti. Scelta consapevole, quella di far passare tutto in sordina (benché per nulla condivisibile, anche perché la mostra, al di là del suo momento clou, è ben costruita, apprezzabile, colma di spunti nuovi, e financo adatta a un pubblico largo), oppure conseguenza d’una comunicazione quanto meno rivedibile? Su come sia stata comunicata questa mostra converrà tornare in un secondo momento: per adesso, ci si può concentrare su di una rassegna che s’inserisce nel quadro d’un crescente interesse per Guido Reni, testimoniato dalle tante mostre che in tempi recentissimi gli son state dedicate, oltre che dalla sua sempre più insistente presenza sul mercato (si possono menzionare a tal proposito la Giuditta appena acquistata dallo Stato per la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, oppure le sue opere che hanno animato le recenti edizioni della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze e di Modenantiquaria).
La mostra della Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce per presentare al visitatore un’idea ovviamente nota agli esperti d’arte del Seicento (sebbene per larga parte ancora da studiare, come le stesse scoperte della mostra attestano), ma forse poco familiare al grande pubblico: molti dei dipinti che ammiriamo nei musei, nelle gallerie, nelle sale dei grandi collezionisti del passato, o dei quali abbiamo appreso sui libri di storia dell’arte, sono da leggere anche come prodotti d’un “fenomeno culturale”, come lo definiscono le curatrici, che non mancò di condizionare le scelte di tanti artisti, ovvero la percezione che le arti visive e la poesia fossero sorelle. Anzi: “care gemelle”, secondo Giovan Battista Marino. È la stessa idea che anima la concomitante rassegna sulla Poesia e pittura nel Seicento alla Galleria Borghese (che ha aperto al pubblico pochi giorni dopo quella della Pinacoteca Nazionale): a Roma, il focus è tuttavia su Marino, considerato tanto nelle sue vesti di poeta, quanto in quelle di teorico, se vogliamo, col quale si può dire non soltanto totalmente superato lo storico complesso d’inferiorità che l’arte aveva sempre sofferto nei confronti delle lettere, ma lo si potrebbe considerare in certa misura ribaltato, dacché nel Seicento, al contrario, è spesso la poesia a seguire la pittura, a cercar d’esprimere con le parole quello che l’immediatezza delle immagini suggeriva agli occhi del poeta. A Bologna, l’esposizione si trova a esplorare, sondare, ripercorrere le diramazioni che questo fertilissimo humus culturale ha seguito in città.
Al pubblico vien subito fornito un adeguato, coinvolgente contesto: siamo nel secondo centro più grande e popoloso dello Stato Pontificio, siamo nella città dei Carracci, di Ulisse Aldrovandi, nella città dove lettere, arti e scienze fioriscono anche per effetto della presenza dello Studium, l’università cittadina, la più antica d’Europa, oltre che dei numerosi atelier degli artisti e, fatto nuovo, delle accademie di pittori e letterati dove vengono elaborate le nuove idee, dove viene continuamente celebrato il matrimonio tra poesia e pittura, unione che nessuno, ormai, si sogna più di mettere in discussione, tant’è che il primo dipinto che s’incontra in mostra è una sorta di manifesto.



Se nella mostra della Galleria Borghese questa sorta di ruolo programmatico era affidato alla Pittura e Poesia di Francesco Furini, opera del 1626, a Bologna s’ammira un dipinto animato dallo stesso principio, l’Allegoria delle tre arti (e cioè pittura, poesia e musica) di Giovanni Andrea Sirani, di quasi quarant’anni più recente, ma non per questo meno interessante, anzi: lo scarto di quattro decennî tra le prime manifestazioni dipinte del legame tra pittura e poesia e l’opera esposta alla Pinacoteca Nazionale è semmai testimone di quanto duraturo sia stato il fenomeno indagato dalla mostra (certo: volendo, se ne potrebbero individuare le propaggini fino ai giorni nostri, ma all’epoca l’intreccio tra arte e poesia era non soltanto al centro del dibattito culturale, ma era modello dominante, e tale sarebbe stato fino al Settecento inoltrato). Colonna della mostra felsinea parrebbe esser tuttavia un elemento cruciale per comprendere i rapporti tra arte e pittura nel Seicento, ovvero la considerazione di cui, all’epoca, godeva il mestiere del pittore: è una declinazione del tema ch’è stata lambita dalla mostra della Galleria Borghese e che però qui a Bologna assume, almeno per il pubblico, una fisionomia ancor più definita, e sicuramente più immediata. Si potrebbe però prender l’argomento ancor più alla larga: cosa voleva dire essere un pittore nella Bologna del primo Seicento? Chi frequentavano, all’epoca, i Carracci, i Reni, i Sirani, i loro colleghi? Quale il ruolo dell’artista nella società? Si comincia a percepire netta l’idea che l’artista fosse una sorta d’intellettuale in grado di collaborare coi letterati per risvegliare dal torpore le menti: l’Accademia dei Gelati, sul cui stemma campeggiava una selva d’alberi rinsecchiti dal freddo (i “gelati”), sorta nel 1588 per iniziativa del medico Melchiorre Zoppio, s’era proposta lo scopo di favorire il disgelo delle menti ghiacciate dall’ignoranza, dapprima col solo mezzo della poesia, e poi in via sempre più pervasiva, attraverso l’avvio di ricerche antiquarie, la promozione di discussioni filosofiche, il patrocinio d’iniziative di più larga portata (le rappresentazioni teatrali, per esempio), e la traduzione delle idee in opere d’arte. Simili cenacoli non potevano prescindere dalla partecipazione degli artisti, il cui pennello poteva dar forma d’immagini alle idee (“esprimere perfettissime idee”, avrebbe scritto l’accademico Ercole Agostino Berrò in un suo discorso, lodando peraltro Guido Reni come il massimo esempio di perfezione): il pittore viene ormai non soltanto percepito come un amico dei poeti ma, anzi, vien considerato una sorta d’intellettuale autonomo, che può partecipare in via indipendente al dibattito culturale apportando le proprie idee, le proprie conoscenze. In occasione dei funerali di Agostino Carracci, nel 1602 (in mostra le incisioni che riproducono le scenografie approntate per l’occasione: vi parteciparono molti dei maggiori artisti bolognesi del tempo, sotto la regia d’un allora venticinquenne Guido Reni), venne data alle stampe una pubblicazione in cui gl’Incamminati, ovvero i membri dell’accademia fondata dai Carracci, raccoglievano testi e poesie prodotte in onore dell’artista appena scomparso, e nell’introduzione, redatta dall’accademico Benedetto Morello, si poteva leggere che gli artisti “non solo mostrano di valer nel disegno loro studio principale, ma si scuoprono più che mezanamente indententi e dell’architetture, e della scoltura, e danno saggio d’haver cognitione delle historie e favole; anzi con nuovi pensieri, non pur poetici, ma filosofici, danno a vedere di non esser privi della cognition delle scienze, e discipline più nobili e peregrine, il tutto sempre accompagnando con istupendo giudicio nell’applicarlo, e con avvedimento raro nel disponerlo et ordinarlo, et insomma mostrandosi tali che danno speranza di progresso felicissimo, se non manifesta chiarezza di compito valore”.
Così venivano percepiti i pittori nella Bologna d’inizio Seicento. E in questa fitta trama di rispondenze tra arti e lettere, una posizione tutt’altro che marginale era quella dei collezionisti, ch’erano in contatto coi poeti, erano loro stessi poeti, frequentavano i cenacoli letterarî, spesso divenivano membri delle accademie, erano degli habitué delle botteghe dei pittori, dei quali non di rado diventavano amici: significativo il caso di Cesare Rinaldi, che era grande amico di Agostino Carracci, al punto da esser da lui effigiato in uno splendido ritratto in cui il fine collezionista, anch’egli peraltro poeta, è raffigurato mentre tiene in mano un orologio da taschino (“da saccoccia”, si sarebbe detto all’epoca) ed è immerso in uno studio in cui compaiono tutti gli oggetti della sua singolare Wunderkammer dedicata, anch’essa, all’unione di poesia, pittura e musica (ecco dunque comparire opere d’arte, un liuto, i libri, e più in generale gli strumenti delle tre arti). Altro collezionista di rilievo fu il più giovane Andrea Barbazzi (o Barbazza), proprietario d’una vasta quadreria che includeva sicuramente la Iole di Ludovico Carracci, altra protagonista della rassegna, in prestito dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia. È attorno a Barbazzi che si concentrano le più significative novità della rassegna: Giulia Iseppi, durante il suo dottorato, ha infatti rinvenuto, nella biblioteca dell’Harry Ransom Center dell’Università di Austin, in Texas, un manoscritto che consente d’illuminare di nuova luce la figura di questo poeta, collezionista, amico di tanti pittori (e specialmente di Guido Reni), e anche di legare a lui uno, o forse due, dipinti che la mostra presenta al pubblico. Il manoscritto contiene una raccolta di oltre trecento poesie di Barbazzi, inedite: erano state radunate dall’autore, com’era uso fare al tempo, in vista d’una pubblicazione dopo la sua scomparsa. Non era raro che i poeti componessero antologie di tutta la loro produzione pensando a una loro uscita a stampa postuma: tuttavia, per qualche ragione, i fogli messi assieme da Barbazzi, scritti in bella grafia (circostanza che avvalora l’ipotesi d’una loro preparazione per la stampa) non raggiunsero mai la tipografia. Per secoli, le poesie di Barbazzi son state dunque dimenticate, condannate all’oblio, rimaste confinate dapprima, con tutta probabilità, nell’archivio dell’Accademia dei Gelati, di cui Barbazzi era membro, e poi circolate sempre privatamente, fino ad arrivare, nel Novecento, a una libreria di Bologna che nel 1968, per cessata attività, decise di dismettere tutto il suo patrimonio librario tramite una vendita all’asta. Fu in quella circostanza che il manoscritto venne acquistato, assieme ad altro materiale, dall’Harry Ransom Center di Austin, in un momento in cui diversi centri studî americani di recente costituzione avvertivano la necessità di crearsi biblioteche di valore, e di conseguenza acquistavano in blocco lotti che venivano reperiti, senza troppe difficoltà, sul mercato italiano. Ad ogni modo, quel che conta è che questa sintesi della produzione letteraria di Barbazzi sia stata ritrovata: si tratta per la più parte di poesie ecfrastiche, riferite alle opere d’arte che il poeta aveva nella sua stessa collezione, a quei dipinti che lui aveva in casa, che poteva vedere tutti i giorni. Scorrere dunque i fogli del manoscritto è un po’ come aver sotto mano l’inventario della raccolta di Barbazzi. Identificare la Iole di Ludovico Carracci non è stato compito così arduo, ha ammesso Giulia Iseppi: l’eroina della mitologia greca, nota per aver soggiogato Ercole al punto da costringerlo a vestire abiti femminili mentre lei indossava la pelle del leone Nemeo e teneva la sua clava, è protagonista d’una lirica intitolata Jole ridente con la pelle del leone di Lodovico Carracci che ben s’attaglia a quell’immagine sinora priva di storia, e che possiamo dunque adesso ricondurre alla raccolta di Barbazzi grazie al suo commento in versi (“La bellissima Jole / Che così viva appar ne’ tuoi colori / Coprir del bianco seno hor più non vuole / Con sotil velo gli animati averi / Ma della spoglia del Leon Nemeo / La clava impogna, / Per maggior trofeo / Fastosetta deride / Con la conocchia il filatore Alcide, / Oh, qual vasto si accresce al tuo penello / Jole in Alcide, Alcide in Jole è bello”).
È invece al momento solo un’ipotesi l’identificazione d’un ritratto che aveva sin qui suscitato lunghe discussioni tra la critica in merito all’identità del soggetto, finora mai accertata: è il cosiddetto Ritratto di gonfaloniere di Artemisia Gentileschi, esposto accanto alla Iole perché, e questa è l’ipotesi presentata al pubblico in mostra, potrebbe trattarsi d’un ritratto di Andrea Barbazzi. Nel manoscritto compare infatti la descrizione di un “Ritratto dell’autore di mano di Artemisia romana”, che non descrive il quadro ma, come quasi sempre avveniva, si contentava d’evocarlo (“Pingi qui il mio volto / Appaga, pur rivela, il tuo desio / Che se finito è il tuo cor nel mio / Potrai ben anco esercitar la destra / Con finita Arte maestra; / Ma, se brami ch’io viva, a me simile / Cangia l’usato stile, / Come verace, et immortal colore / Da morte al volto se le desti al core”). Nel 1622, anno in cui Artemisia dipinse l’opera, firmandola e datandola, Andrea Barbazza si trovava a Roma, negli anni in cui Roma era governata da un bolognese, papa Gregorio XV, al secolo Alessandro Ludovisi, protagonista dell’altra importante mostra romana di quest’inverno, quella delle Scuderie del Quirinale, dedicata proprio al papato Ludovisi. Tra i bolognesi che, in quel frangente, s’erano trasferiti a Roma, s’annoverano tanto Andrea Barbazza quanto Guido Reni (i due erano molto amici, anzi: Barbazzi si considerava un sorta di domestico del pittore, e la stessa percezione di sé aveva Cesare Rinaldi, altro amico di Guido). Non è dunque da escludere che, in quell’occasione, Barbazzi abbia commissionato ad Artemisia un eventuale ritratto. Rimangono da chiarire alcuni nodi: perché il soggetto ha gli attributi dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, per esempio, mentre invece sul gonfalone pontificio l’aggancio potrebbe essere l’elezione di Barbazzi al Collegio degli Anziani di Bologna nel 1607, carica che gli consentiva d’effigiarsi proprio col gonfalone.





Dopo una sezione ch’elenca i successi d’alcuni pittori bolognesi che frequentarono i circoli romani, mostrando alcuni dei loro più raffinati capolavori. da leggere sempre in rapporto alla poesia del tempo (sfilano un Amor vincit omnia di Gian Giacomo Sementi, il cui lavoro fu spesso richiesto da poeti come gli stessi Marino e Barbazza, e poi una Giuditta di Lavinia Fontana, altra pittrice lodata dai poeti bolognesi come Giulio Cesare Croce e Ridolfo Campeggi, e ancora la Lucrezia romana di Guido Reni di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna), ecco giungere il confronto tra le due versioni dell’Atalanta e Ippomene di Guido Reni, esposte a fianco della Strage degli innocenti cui Marino dedicò una sua lirica, contenuta nella celebre Galeria (“Che fai Guido, che fai? / La man, che forme angeliche dipinse, / Tratta or opre sanguigne? / Non vedi tu, che mentre il sanguinoso / Stuol de’ fanciulli ravivando vai / Nova morte gli dai? / O ne la crudeltate anco pietoso / Fabro gentil, ben sai, / Ch’ancor tragico caso è caro oggetto, / E che spesso l’horror va col diletto”). L’ultima volta, le due opere sono state esposte assieme nel 2023 a Madrid, in occasione della grande mostra che il Prado dedicò quell’anno a Guido Reni, ma il pubblico italiano non vedeva i due quadroni assieme dal 1988, anno della completa monografica curata, proprio alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, da Andrea Emiliani: una mostra talmente importante d’aver poi viaggiato a Los Angeles e a Fort Worth.
Stesso disegno, diversa stesura cromatica: più luminoso il dipinto di Madrid, più cupo e con un chiaroscuro più insistito il dipinto di Capodimonte, circostanza che potrebbe portare a considerare la versione napoletana precedente, seppur di poco, rispetto a quella spagnola in ragione della sua maggior vicinanza alle opere del periodo romano degli anni Dieci di Guido Reni (l’attuale mostra, tuttavia, suggerisce la stessa cronologia, e dunque un’esecuzione concomitante, al 1622-1623). L’Atalanta e Ippomene, manifesto del bello ideale di Guido Reni, è un dipinto su cui tanto s’è scritto, e le cui origini letterarie sono già state chiarite, in virtù dell’esistenza d’un passaggio, nell’Adone di Marino, composto negli stessi anni in cui Guido dipingeva il suo capolavoro, dedicato al mito d’Atalanta e Ippomene (“Per l’arringo mortal, nova Atalanta / l’anima peregrina, e semplicetta, / corre veloce, e con spedita pianta / del gran viaggio al termine s’affretta. / Ma spesso il corso suo stornar si vanta / il senso adulator, ch’a sé l’alletta / con l’oggetto piacevole e giocondo / di questo pomo d’or, che nome ha mondo”). Quello che non si sa del dipinto è chi lo abbia commissionato: pare quasi che la storia antica del dipinto sia andata dimenticata, non fosse per quei versi di Marino che inducono a ricondurre la genesi dal dipinto al milieu culturale della Bologna, e forse ancor più della Roma, d’inizio Seicento.
Le notizie inventariali relative alle due opere sono molto tarde: è menzionata un’Atalanta e Ippomene di Guido Reni a fine Seicento nelle collezioni dei Gonzaga, e non è neppure dato sapere di quale versione si tratti (sempre ammesso che quelle di Napoli e Madrid siano le uniche due effettivamente prodotte dalla mano di Guido), e poi sappiamo che, sempre nel Seicento, un nobile genovese al servizio della corona spagnola, Giovanni Francesco Serra di Cassano, aveva tra le mani un’Atalanta e Ippomene di Guido Reni poi confluita nelle raccolte dei re di Spagna: è l’opera oggi conservata al Prado. Del dipinto napoletano si conosce ancor meno, dacché compare soltanto agl’inizî del XIX secolo in una collezione milanese, per poi giungere nelle raccolte borboniche. L’idea suggerita da Giulia Iseppi è che per cercare il committente (o meglio: i committenti) dell’Atalanta e Ippomene occorra cercare tra gli ambienti letterarî d’inizio Seicento, e nella fattispecie nell’Accademia dei Desiosi, fondata dal cardinale torinese Maurizio di Savoia (chissà, peraltro, che non possa anche aver brigato per far ottenere il riconoscimento dell’Ordine Mauriziano ad Andrea Barbazza). L’Accademia dei Desiosi riuniva sicuramente Giovan Battista Marino, diversi alti prelati che gravitavano attorno a Gregorio XV, alcuni allievi di Guido Reni, forse lo stesso Guido Reni. Nel 1626, l’Accademia produsse una sorta di diario dove si parlava anche della “favola di Atalanta”, circostanza che, ha spiegato Giulia Iseppi, ha fornito il titolo della mostra: quella di Atalanta e Ippomene era una storia (anzi, una “favola”) poco frequentata dai pittori del tempo, ma nota ai letterati e molto frequentata dagli accademici coi quali avevano familiarità tanto Guido Reni quanto Giovan Battista Marino. Di conseguenza, il nome dei committenti dell’Atalanta e Ippomene è forse da cercare in quei prelati che disponevano di grosse sale dov’esporre dipinti dalle dimensioni tanto ragguardevoli, e che al contempo potevano comprendere appieno, all’insegna di quel raffinato umanesimo cristiano uso a rileggere in chiave contemporanea i miti greci e romani, il significato del dipinto di Guido Reni: il bolognese Ludovico Ludovisi, il mantovano Ferdinando Gonzaga ch’era peraltro grande amico di Barbazzi, lo stesso Maurizio di Savoia. Un dipinto forse nato per uno di questi prelati e divenuto poi oggetto del desiderio di qualche altro suo “collega”, al punto da condurre Guido a dipingerne un’altra versione. E poi forse altre ancora.



Eccola, dunque, la Bologna d’inizio Seicento, la Bologna dei poeti e dei pittori i cui rapporti non s’esaurivano, come s’è visto, sulla carta o sulla tela. La mostra della Pinacoteca Nazionale aiuta a diradare le nebbie su queste connessioni che non si limitavano solo all’ambito professionale. I poeti non vanno visti come le fonti d’ispirazione dei pittori. O viceversa. Le relazioni che li univano eran più strette e più duttili: c’erano rapporti d’amicizia, rapporti di servizio reciproco, rapporti d’intermediazione che coinvolgevano collezionisti, committenti, altri letterati, altri poeti. Rapporti che s’esprimevano in quelle accademie, in quei circoli che vanno considerati alla stregua di centri di potere culturale alternativo rispetto ai centri del sapere ufficiale, rispetto alle università. La favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti è dunque una mostra d’elevato valore scientifico che aggiunge pagine significative, importanti, fondamentali alla storia dell’arte italiana del Seicento.
Una mostra costruita in maniera esemplare, di dimensioni contenute e quindi utile a evitare un consumo frettoloso e, al contrario, adatta a favorire dense e ripetute immersioni, fornita d’un allestimento corretto, elegante e curato nei dettagli (ci sono anche coinvolgenti “docce sonore” che riproducono audio con letture dei componimenti legati ai dipinti, seppur con voci rivedibili, per usare un eufemismo), e dotata anche d’un laboratorio didattico aperto a tutti, coinvolgente, nel quale si corre il serio rischio di passare più tempo che in mostra. Non sapremo mai quanti visitatori si sono effettivamente recati alla Pinacoteca per quest’occasione, perché non c’è bigliettazione separata (si potrà soltanto capire se i flussi hanno conosciuto degli aumenti nei tre mesi d’apertura della mostra), ma almeno a livello mediatico par di vedere che La favola di Atalanta non abbia ottenuto grande risalto. Una mostra così ben progettata, così colma di novità, così scientificamente valida, solidamente fondata sulle scoperte di Giulia Iseppi, studiosa giovanissima, avrebbe meritato molta più attenzione. Peccato.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).