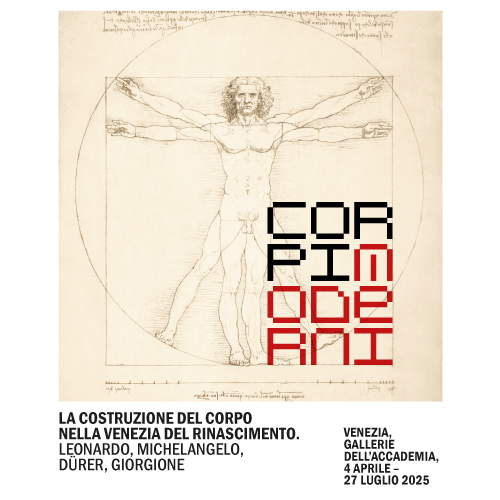Se il Van Gogh televisivo è quello di Alberto Angela, allora che differenza c'è coi reality?
Partiamo dal quadro d’insieme: anni di studi, di mostre, di libri, di articoli, di attività varie ed eventuali per accoppare tutti gli stereotipi su Vincent van Gogh, per trasmettere al pubblico l’idea che la figura di Van Gogh fosse leggermente più complessa rispetto a quella del genio pazzoide dotato di anima sensibile che nessuno capiva, per restituire un’ombra di dignità all’artista più banalizzato della storia, al sempreverde delle mostre di cassetta, all’idolo di milioni di telespettatori che sui social mettono i cuoricini alle sue opere quando il loro influencer di fiducia gliele fa vedere, ma se ce l’avessero avuto come vicino di casa avrebbero già chiamato i vigili, presentato un’istanza al consiglio di circoscrizione, allertato le telecamere di Rete4. Anni di lavoro che cominciavano a dare i suoi frutti: l’ultima ondata di mostre su Van Gogh che abbiamo avuto in Italia (quella di Roma, quella di Milano e quella di Trieste) volgeva in questa direzione. E poi arriva lui: Alberto Angela, col suo Van Gogh da prima serata. Come l’amico dispettoso che soffia sul castello di carte. Malgrado le rassicurazioni della vigilia, con tanto d’iperbole (“le lettere forse più interessanti dei quadri”), il programma di Angela non s’è scostato di mezza virgola da tutte quelle convenzioni che lo stesso bardo della divulgazione s’era più o meno esplicitamente ripromesso d’aggirare.
Più di due ore per raccontare il romanzo della vita di Van Gogh, partendo dalla fine e andando a ritroso. Dell’intero campionario, Alberto Angela non ci risparmia niente: l’orecchio tagliato, la famiglia che non lo capisce, l’attaccamento al fratello, il ricovero alla clinica, i metodi dei dottori per tenerlo buono eccetera eccetera. Arte? Se n’è vista molto poca. In compenso, Angela ci ha fatto vedere utili mostre immersive, fondamentali immagini di girasoli proiettate sulle pareti delle cave di Les-Baux-de-Provence, irrinunciabili animazioni che facevano volare i corvi sopra i campi di grano dipinti da Van Gogh. E poi, tra un Angela che passeggia e gesticola sulle arcate del Pont du Gard e un Recalcati che, in collegamento dalla mostra immersiva, ci offre le sue analisi del quadro clinico di Van Gogh, ecco le scene di una fiction su Van Gogh che andò in onda sulla tv olandese nel 2013 e che occupano una buona parte, forse una metà, del programma di Angela. E la complessità della figura di Van Gogh? Le sue letture? La sua cultura? I suoi rapporti con gli altri artisti nella Francia di fine Ottocento? Il motivo per cui la sua arte è così importante? Niente: mica si vorrà far annoiare il telespettatore, ché poi quello cambia e si mette a guardare il reality su Canale5, e poi chi li sente gli indignati che sono già in fibrillazione e fremono dalla voglia di scrivere editoriali e post sul pubblico scostumato e ignorante che preferisce Temptation Island alla cultura.
Volendo allora riprendere il paragone che ha animato le discussioni della nostra estate, c’è semmai da domandarsi che differenza ci sia tra Temptation Island e questo Van Gogh, trito e soporifero. Il problema non sono gli errori (per esempio Van Gogh che comincia a dipingere a Nuenen, il mulino di Gennep “tra le primissime opere”, la cognata che prima di fare qualsiasi altra cosa pubblica le lettere dei due fratelli), non sono le banalizzazioni estreme (Van Gogh che si trasferisce in Provenza per cercare la campagna e disintossicarsi, Van Gogh che litiga con Gauguin per un dipinto che non gli piaceva), non sono le mostre immersive, non sono le immagini della fiction della tv olandese. Il problema è che non ci si schioda dal biografismo, non ci s’allontana manco per mezzo secondo dall’aneddotica. Il problema è che Van Gogh, trattato così, diventa a sua volta un reality. Se in prima serata dobbiamo sorbirci due ore di romanzo della vita di Van Gogh, allora non si faceva prima a trasmettere direttamente la fiction olandese, che peraltro, facendo la tara alle necessarie parti romanzate, sembrava pure interessante? Tanto valeva vedere due ore di film.

Certo, dirà il lettore incapace d’accettare l’idea che un reality trash sia meglio di un documentario su Van Gogh: sarà pure il romanzo della sua vita, sarà pure una banalizzazione estrema, sarà pure che di arte non se n’è vista, sarà pure che abbiamo dovuto inghiottire controvoglia le riprese dalla mostra immersiva o le ridicole animazioni dei corvi che volavano sui campi di grano ma, dice, almeno Van Gogh sarà arrivato a qualcuno. Quasi tre milioni di telespettatori, in fondo, hanno visto il documentario di Alberto Angela. Ma chi è che non conosce questo Van Gogh? Il documentario non ha proposto letture nuove, letture interessanti. Anzi, ha rinverdito gli stereotipi. E poi, a che scopo? La mostra di Roma di due anni fa s’è chiusa con quasi seicentomila visitatori. E dicasi quasi seicentomila, quando una grande mostra difficilmente supera i duecentomila (e sarebbe comunque una mostra visitatissima). Nella classifica dei best-seller di Feltrinelli dell’ultimo mese, al primo posto ci sono le Lettere a Theo. Non si contano più i film. Quelli che già vanno a vedere le mostre di Van Gogh allora sono già nel registro delle persone informate sui fatti. Gli altri due milioni e spiccioli, dopo aver visto le miniere immersive della Provenza e i corvi che si animano sui campi di grano, hanno spento la tv dopo aver visto un romanzo sotto forma di documentario. Con le mostre immersive e le animazioni. Ma che concetto abbiamo del pubblico?
La vera sfida, allora, non è quella di portare Van Gogh in prima serata. O, come nelle prossime puntate, portarci Londra, Istanbul e Lucrezia Borgia. Piace a tutti vincere facile (pure a me, ché l’unica volta che ho fatto qualcosa in un teatro ci ho portato Johanna Bonger, la cognata di Van Gogh). Certo, dirà il lettore che alle entrate pubblicitarie della Rai ci tiene: se in prima serata, al posto di Van Gogh, Londra, Istanbul e Lucrezia Borgia, ci metti Guido Reni, Albissola, Piacenza e Plautilla Nelli, allora i tre milioni di telespettatori te li sogni, non ti guarda nessuno. Ma come? L’estate scorsa siamo finiti sotto un diluvio di critiche alla Rai per aver sospeso Noos (programma che avevo peraltro elogiato e ottimo esempio di divulgazione in prima serata, detto per chi si sta già preparando a rivolgermi accuse di critiche ad Angelam o rodimenti assortiti), non si contavano più gli appelli al servizio pubblico che deve fare il servizio pubblico e che deve fottersene degli ascolti perché la Rai non deve seguire logiche da televisione commerciale, perché l’obiettivo è fare qualcosa di utile per il pubblico e non rincorrere gli ascolti, e quindi accogliamo il Van Gogh televisivo perché sennò Guido Reni non lo guarda nessuno? E allora, se dobbiamo metterla in termini di utilità per i telespettatori, è più servizio pubblico il romanzo di Van Gogh o sarebbe più servizio pubblico far sapere al telespettatore che se spegne la tv e mette il naso fuori di casa può vedere di tutto, e che non è neppure necessario abitare a Roma, a Milano, a Firenze o a Napoli per meravigliarsi? Per il telespettatore di Celle Ligure è più utile la miniera immersiva della Provenza o è più utile sapere che a un paio di fermate di treno da casa sua ci sono luoghi dove si sono scritte pagine fondamentali dell’arte mondiale degli anni Cinquanta e Sessanta? Per il telespettatore di San Rocco al Porto è più utile l’animazione del corvo che vola sul campo di grano o è più utile sapere che con un quarto d’ora di bicicletta da casa sua può vedere il Guercino, può vedere i fasti farnesiani, e può vedere pure un Botticelli, se proprio gli piace l’artista bestseller? Certo, diranno i pretoriani di Alberto Angela: chi vuole informarsi su Albissola, su Piacenza, su Guido Reni, su Plautilla Nelli ha Raiplay, ha i programmi in seconda serata. Ecco: siamo sicuri che sia una buona idea confinare tutto quello che non è Van Gogh, Pompei e Caravaggio su Raiplay o in seconda serata? Se è così, allora tra il reality di Van Gogh e il reality trash, anzi guardare Temptation Island. È meno noioso e, per certi versi, anche più interessante. Tanto poi per la cultura c’è Raiplay o c’è la seconda serata.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).