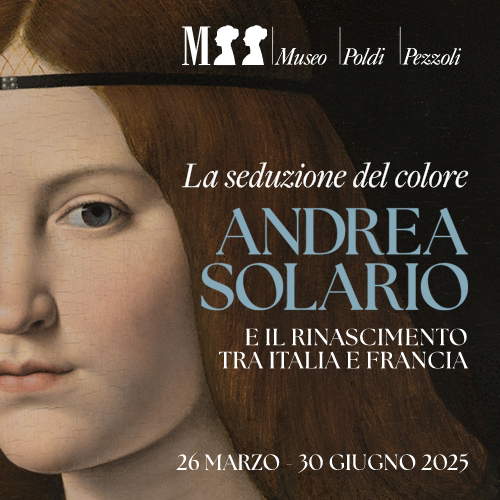“La sfida del Ministero? Far crescere i musei minori”. Parla Alessandra Guerrini (Musei Liguria)
“La sfida è far crescere i musei minori, farne i poli sui territori del Sistema Museale Nazionale”. È questo, secondo Alessandra Guerrini, a capo della nuova Direzione regionale Musei nazionali Liguria, l’obiettivo principale dell’ultima riorganizzazione del Ministero della Cultura che ha portato alla nascita delle nuove Direzioni regionali dei Musei nazionali (DrMn). E per raggiungerlo la marcia in più, rispetto alle analoghe intenzioni che accompagnarono oltre dieci anni fa, in era Franceschini, la creazione degli allora poli museali, dovrebbe essere assicurata dall’autonomia finanziaria che viene riconosciuta per la prima volta. Quest’ultima rappresenta, in un certo senso, anche un “test” per misurare il livello di capacità di responsabilità amministrativa dei dirigenti. Se da una parte, infatti, il vantaggio di trattenere e reimpiegare gli incassi dell’attività di gestione dei beni, come biglietti d’ingresso, canoni concessori, vari servizi a pagamento, ecc., permette di velocizzare le procedure relative alla contabilità o di entrata di fondi dai privati; dall’altra la gestione tramite bilancio comporta una grande complessità.
Come per gli altri direttori fin qui sentiti, Fabrizio Sudano per la Calabria, Valentina Uras per la Sardegna e Filippo Demma per la Basilicata, anche Guerrini non conosce le motivazioni (non c’è “alcun documento programmatico al riguardo”) che hanno portato alla distinzione tra direzioni regionali che restano indipendenti, dedicate a una intera regione, come Campania, Lazio e Lombardia, e direzioni che fanno capo ad altrettanti istituti autonomi, come in Umbria, Puglia ed Emilia Romagna. Si procede per ipotesi. Per Guerrini, “la logica generale è quella di creare reti più piccole e più gestibili”, che condividano anche il personale (carente), per cui sarebbe utile “l’apporto delle Regioni per sostenerle”. A proposito, la nuova ennesima ridenominazione dei “poli” con l’aggiunta di “nazionali” è servita anche ad evitare il fraintendimento per cui le Direzioni museali sono delle articolazioni statali su base regionale, e non appunto degli istituti delle Regioni. Laddove l’utilizzo della parola “nazionali”, e non “statali”, è evidentemente intenzionale, dato che i due termini, sebbene spesso usati in maniera intercambiabile, hanno significati differenti.
In questo scenario la Liguria parte in vantaggio, dato che era già collegata al museo autonomo della regione nella figura di un unico direttore. Della DrMn Liguria fanno parte tredici siti, tra musei, gallerie, castelli e siti archeologici, dal Palazzo Reale di Genova alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola; dal Museo Preistorico dei “Balzi Rossi” e area archeologica di Ventimiglia (Imperia) al Museo archeologico nazionale e parco archeologico di Luni (La Spezia); dalla Fortezza di Castruccio Castracani e Fortezza Firmafede, entrambe a Sarzana (La Spezia) al Castello di San Terenzo (La Spezia). Ottica di rete, dunque, anche se il confronto tra direttori, come emerso nelle precedenti interviste (ma anche in quelle dell’inchiesta sui musei autonomi), è lasciato per lo più alle iniziative informali dei singoli.

SM. Tra le novità introdotte nel 2014 dalla riforma Franceschini i “poli museali regionali” si sono rivelati da subito i punti deboli della riorganizzazione ministeriale. Secondo Lei quali sono state le criticità di quelle strutture?
AG. Si trattava di strutture costruite per essere uguali ma nella realtà molto diverse; alcune, nelle regioni più grandi e più ricche di patrimonio, mettevano insieme decine e decine di musei, altre invece, in regioni più piccole o meno ricche, riunivano più ragionevolmente un piccolo gruppo di musei sparsi sul territorio. Tutti i poli comunque mettevano insieme beni diversissimi fra loro, dalla pieve in cima al colle al grande castello, dalla piccola area archeologica nella campagna fino a musei medi, grandi o grandissimi come il Cenacolo. Beni che erano stati gestiti fino a quel momento dalle tre diverse Soprintendenze specialistiche e che quindi venivano da sistemi gestionali e culture d’istituto spesso diverse e da armonizzare. La memoria di un’istituzione è lunga e una modifica di questo tipo ha richiesto anni per essere metabolizzata. Aggiungiamo che, mentre i musei autonomi hanno ricevuto importanti dotazioni finanziarie per il loro funzionamento, questo non è avvenuto per i poli regionali, ricchi di musei preziosi che formano il tessuto diffuso dell’Italia, ma non in grado di sostenersi.
È poi cambiato qualcosa nel 2019 con le “direzioni regionali musei”, oltre la nuova dicitura?
Nella sostanza direi di no.
Qual è la ragione per cui è stata introdotta adesso una diversificazione tra direzioni coincidenti con una Regione e altre aggregate ad istituti autonomi? E in cosa consiste la differenza?
Premesso che non mi risulta che sia stato reso pubblico alcun documento programmatico al riguardo, e che quindi si procede per deduzione, le DrMn coincidono ancora con il territorio delle Regioni, solo che alcune contengono tutti i musei dello Stato, altre invece contengono solo quelli “residui” dopo che altri sono stati accorpati a uno o più musei autonomi. Nel caso della Liguria (e di Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche e Molise) la DRM, che li contiene tutti, era già collegata al museo autonomo della regione nella figura di un unico direttore. Aggregarle quindi attraverso un bilancio unico è stato più semplice della maggior parte delle altre modifiche previste nell’attuale riforma. La logica generale, secondo me ampiamente condivisibile, è quella di creare reti più piccole e più gestibili. Per leggere le differenze all’interno delle varie aggregazioni bisognerebbe analizzarle in profondità, ma c’è un dato comune importantissimo, l’autonomia di bilancio, che consente di programmare molto meglio la spesa e quindi il lavoro.






Le aggregazioni, poi, avvengono esclusivamente con musei o parchi di livello dirigenziale non generale. C’è una ragione per cui le DrMn non sono state abbinate agli istituti autonomi “più forti” di prima fascia?
Salvo casi particolari, ci sarebbe un salto di scala troppo grande tra un museo di prima fascia e quelli diffusi sul territorio. Già quello tra il museo autonomo di seconda fascia e il singolo bene di scala minore spesso è notevole. La sfida, in questo momento, è far crescere i musei minori, farne i poli sui territori del Sistema Museale Nazionale, aprirli sempre più e farli vivere per i cittadini svolgendo anche il compito di diversificare il turismo. Non dimentichiamo che spesso non c’è personale statale in luoghi talvolta molto periferici, e spesso tenerli aperti non è facile. Ha più senso, in molti casi, che il museo molto periferico si colleghi con i musei locali, costituendo anche in questo modo delle piccole reti (e in questo senso sarebbe fondamentale l’apporto delle Regioni per sostenerle). Anche perché i musei di prima fascia molto spesso vengono dal collezionismo dinastico, mentre i musei del territorio possono avere storie ben diverse.
Gli accorpamenti saranno utili anche a generare economie di scala, con la condivisione di servizi, strumentazioni, competenze professionali?
Certamente sì, anche se questo percorso virtuoso nelle regioni di cui si diceva prima, tra cui c’è la Liguria, era certamente già attivo prima. Ad esempio, noi abbiamo usato le risorse ben maggiori del Museo autonomo (Palazzo Reale di Genova) per fare una mostra che portava a Genova e all’attenzione nazionale la storia di Luni, il sito più importante della DRM.
In quest’ottica di rete (se effettiva) sono previsti momenti di scambio, come tavoli tecnici convocati con una certa regolarità, tra voi direttori per confrontare le diverse esperienze? Replicare quelle riuscite, risolvere problemi comuni o condividere modelli e progettualità?
Ultimamente ci sono stati momenti di confronto soprattutto sui temi della spesa PNRR che ci coinvolge tutti ed è molto complessa. Per il resto, ci sentiamo frequentemente tra di noi in modo informale.
Cosa pensa che cambierà con la nuova autonomia rispetto al passato? In particolare, dal punto di vista finanziario.
Con l’autonomia di bilancio cambia la programmazione della spesa, che diventa molto più agile, e si può distribuire sull’intero anno, anziché da aprile-maggio ai primi di dicembre, come avviene con i sistemi tradizionali di contabilità di Stato. Ricevere contributi e sponsorizzazioni, o riutilizzare gli introiti, è molto più semplice, anche se la gestione tramite bilancio ha ovviamente anche una grande complessità. Rimane il fatto che la grande spinta data in questi anni ai musei autonomi li ha fatti crescere moltissimo sotto tutti i punti di vista: non solo sono aumentati i visitatori, ma anche tutta la produzione culturale che avviene all’interno dei musei nelle più varie forme. Perché anche i musei minori crescano con la stessa spinta è necessario che essi vengano dotati finanziariamente in modo più significativo di quanto fatto finora, e per tutti gli aspetti del loro funzionamento, perché la dotazione iniziale faccia poi da volano alla crescita e quindi almeno in parte all’autosostentamento. Tuttavia, questi sono tempi difficili per i bilanci pubblici, e non sappiamo quanto questa speranza possa concretizzarsi.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Silvia Mazza
Storica dell’arte e giornalista, scrive su “Il Giornale dell’Arte”, “Il Giornale dell’Architettura” e “The Art Newspaper”. Le sue inchieste sono state citate dal “Corriere della Sera” e dal compianto Folco Quilici nel suo ultimo libro Tutt'attorno la Sicilia: Un'avventura di mare (Utet, Torino 2017). Come opinionista specializzata interviene spesso sulla stampa siciliana (“Gazzetta del Sud”, “Il Giornale di Sicilia”, “La Sicilia”, etc.). Dal 2006 al 2012 è stata corrispondente per il quotidiano “America Oggi” (New Jersey), titolare della rubrica di “Arte e Cultura” del magazine domenicale “Oggi 7”. Con un diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna, ha una formazione specifica nel campo della conservazione del patrimonio culturale (Carta del Rischio).