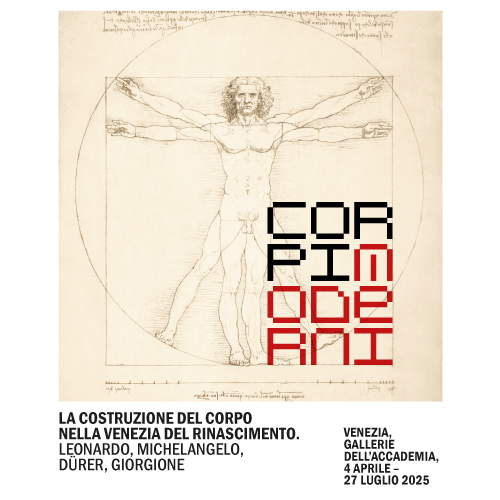I traumi di Urbania e del suo Palazzo Ducale
Urbania serba tra le mura del suo Palazzo Ducale la poesia di Federico Barocci. I più entrano qui per vedere da vicino la Madonna delle nuvole, la bella tela che a lui viene attribuita e che si svela alla fine d’un percorso tortuoso tra le sale di questo palazzo rinascimentale a picco sul Metauro, fratello minore di quello che sta qualche chilometro più verso il mare, a Urbino. Il museo allestito nelle sale del Palazzo Ducale di Urbania tiene il meglio per l’ultima sala, la più nascosta, gemma nel cuore dell’edificio, alla quale s’arriva dopo un itinerario tra la storia della ceramica, le fotografie del vecchio allestimento del museo civico, le incisioni di Leonardo Castellani che hanno raccontato i paesaggi della valle del Metauro, i dipinti provenienti dal territorio, le sale dedicate al vasaio Cipriano Piccolpasso che, si scopre, è uno dei numi tutelari di queste terre, autore d’un trattato, ci dicono i pannelli, “fondamentale per la conoscenza dell’arte ceramica metaurense del Rinascimento”. La Madonna delle nuvole è la meta che si vede alla fine del viaggio, è il premio per chi non ha avuto tema d’affrontare il freddo gelido delle sale dove d’inverno le temperature sfidano la resistenza del visitatore più temprato, per chi ha camminato su tutte le moquette che coprono parte dei pavimenti in cotto delle sale, per chi s’è soffermato su tutti gli spezzoni della storia d’Urbania che il Museo Civico allestito nelle sale di Palazzo Ducale racconta ai suoi visitatori. Spezzoni, perché poco è rimasto. Ma queste sale racchiudono una storia mesta, una storia di traumi che si celano dietro i muri scialbati delle sale, dentro le nicchie, sotto alle nuvole della dolce Madonna baroccesca. Traumi della storia che sono scivolati via, lungo l’acqua del Metauro che scorre sotto le torri del palazzo, nell’aria pulita delle montagne che circondano la sua valle, verso il Montefeltro, verso l’Alpe della Luna. Traumi che però ancora mostrano i loro segni, sul palazzo e sulla città.
Quando la Madonna delle nuvole usciva dalla bottega di Federico Barocci, Urbania non si chiamava ancora Urbania: si chiamava Casteldurante ed era uno dei centri più vivaci del ducato d’Urbino, fulcro d’una produzione di ceramica che, con quaranta forni attivi, riforniva l’intera Europa. Tutte le corti europee del Rinascimento volevano le ceramiche di Casteldurante. Anche se, verso il finire del Cinquecento, l’arte dei vasai, che fino a quel tempo era stata ricca e prospera, aveva cominciato a subire qualche rovescio. L’ultimo duca d’Urbino, Francesco Maria II Della Rovere, s’era impegnato a lungo e con solerzia per mantenere alto il livello di produzione, e sotto il suo ducato le botteghe dei ceramisti di Casteldurante erano ancora in piena attività. Ma nel Seicento la ceramica di Casteldurante s’avviava a diventare un’attività meno fiorente rispetto a com’era stata il secolo prima. E nel Settecento era entrata definitivamente in crisi. Oggi, la tradizione è tenuta ancora in piedi dalle botteghe che operano sotto la tutela dell’associazione che riunisce le città italiane della ceramica, ma girando per le vie del borgo quasi non si direbbe che quest’attività abbia retto per lungo tempo l’economia d’uno dei centri più importanti del ducato di Urbino, luogo dove lo stesso Francesco Maria II amava soggiornare per periodi anche piuttosto lunghi. La preferì financo alla stessa Urbino, e ci aveva persino trasferito la corte e la sua enorme biblioteca. I duchi comunque ci tenevano, a Casteldurante. Chi va al Palazzo Ducale d’Urbino, faccia caso alla grande iscrizione con la quale, nel cortile d’onore, Federico da Montefeltro si presenta all’ospite: “Federicus, Urbini Dux, Montisferetri ac Durantis comes”. Federico, duca di Urbino, conte di Montefeltro e Casteldurante.
Quando, il 29 aprile del 1581, Michel de Montaigne passò da queste parti durante il suo viaggio in Italia, gli abitanti di Casteldurante stavano festeggiando la nascita del figlio primogenito di Isabella della Rovere, sorella di Francesco Maria II. Quella cittadina non gli aveva fatto grande impressione, tant’è che nel suo diario di viaggio le dedica poche righe. E di Francesco Maria parla soltanto nelle pagine dedicate a Urbino. Il duca però aveva grandi progetti per il palazzo di Casteldurante. Si trovava meglio di là dalle colline, Casteldurante gli piaceva di più. E volle che la sua enorme raccolta di libri venisse radunata qui: quindicimila volumi, una mole di materiale che oggi farebbe sorridere, ma per quel tempo era una biblioteca immensa. Una delle più grandi, originali, aggiornate biblioteche d’Europa, una biblioteca che radunava tutto il sapere dell’epoca, in tutte le materie. Nel 1607, Francesco Maria II fece costruire anche un edificio, la Libraria Nuova, accanto al Palazzo Ducale, per ospitare la sua raccolta di libri. Possiamo immaginare che ne andasse particolarmente fiero.



Vuole la leggenda che il duca tenesse la Madonna delle nuvole in camera sua, sopra alla testata del suo letto. Lo diceva, nell’Ottocento, un erudito del posto, Giuseppe Raffaelli. Al di là della leggenda, ovviamente priva di fondamento, sappiamo tuttavia che il duca procurò molto lavoro a Barocci, che del resto non si spostò praticamente mai da Urbino per tutta la sua carriera. Barocci dipinse anche il ritratto del duca, quello ch’è oggi conservato agli Uffizi. Della Madonna delle nuvole, invece, non conosciamo la genesi, e a dire il vero non sappiamo neppure con certezza chi sia il suo autore. Si pensa possa esser legata a una commissione ch’era giunta da Madrid: i Della Rovere tenevano molto ai loro rapporti con la Spagna, e Francesco Maria II non s’era sottratto a una consuetudine della sua famiglia. Ovvero, le buone relazioni diplomatiche coi re spagnoli: anche i dipinti che da Urbino partivano alla volta di Madrid vanno considerati come strumenti diplomatici. Nella sala che conserva la Madonna delle nuvole è custodita anche la replica del crocifisso, con tanto d’immagine del Palazzo Ducale di Urbino ai piedi del Cristo, che il duca donò nel 1604 a Filippo III, e che oggi è al Prado. Tra il 1588 il 1592 sono invece attestate quattro rate per un grosso pagamento destinato a regolare un dipinto raffigurante una Madonna, oggi ritenuto perduto: si pensa che la Madonna delle nuvole possa essere un rimaneggiamento dell’invenzione che Barocci aveva messo a punto per quella commissione destinata alla Spagna. C’è poi chi ritiene che la Madonna delle nuvole di Urbania non sia opera del maestro, ma di un non meglio precisato collaboratore della sua bottega. Se è così, occorre immaginarsi un allievo sensibilissimo, abile come Barocci a tradurre un’idea del maestro nella delicatezza, nella morbidezza, nella dolcezza di una Madonna commovente, toccante, che con grazia s’appoggia al suo trono di nubi, con gesto dolce e materno mostra il Bambino stando però attenta che non cada, reggendolo con le mani, con eleganza accenna un sorriso rivolgendo i suoi occhi al riguardante. Un allievo così talentuoso da non aver ancora trovato un nome, da non aver trovato ancora riscontri puntuali tra gli artisti che conosciamo. Un anonimo baroccesco capace di dipingere una delle Madonne più belle del Cinquecento. O, quantomeno, capace di replicare in maniera pressoché totalmente fedele un originale del maestro che oggi non possiamo vedere. Ci sono, del resto, i disegni che possono testimoniare oltre ogni dubbio che l’invenzione si deve a Federico Barocci. Già agl’inizi del secolo scorso Lionello Venturi diceva che qualcuno, vedendo il quadro della Madonna delle nuvole riprodotto in fotografia, potrebbe rifiutare d’accettarne l’attribuzione, dal momento che l’opera s’allontana dalle “forme consuete” di Federico Barocci. Eppure, Venturi diceva che “davanti all’originale si ricrederanno, perché i colori sono tipici del Barocci e le forme sono spiegabili per un influsso di Raffaello più intenso che su qualsiasi altra opera del Barocci”. E diceva che la bellezza che “traspare attraverso le ridipinture e le grinze della tela” non consente di attribuire il quadro a uno scolaro: “più di chiunque altro ci mostra il Barocci in colloquio con Raffaello”. Andrea Emiliani, concorde con Venturi sull’attribuzione a Barocci, prendeva la Madonna delle Nuvole come modello di “levità cromatica severa”, come esempio d’una “costruzione di grazia popolare che si rimette […] alla immediatezza della comunicazione, addensata certo nello sguardo dolcemente malinconico e quasi presago”. Di recente, a riaffermare l’autografia baroccesca s’è esposto John Spike. Contro Barocci, invece, già nel 1955 arrivava il parere di Harald Olsen: “la composizione è di Barocci, ma il dipinto di sicuro no”. Sulla scorta di Olsen, di recente Massimo Moretti ha riaffermato i classici argomenti contro l’autografia: “gli incarnati del volto e della mano della Vergine e la stesura pittorica sono privi dei soffusi e sapienti passaggi cromatici del maestro”. Chi è allora l’autore? Chi poteva essere in grado di tradurre in maniera così somigliante all’originale un’idea di Federico Barocci? La Madonna delle nuvole è di Federico Barocci? È invece interamente frutto d’un suo collaboratore? O il maestro partecipò all’esecuzione? Il tempo ha offuscato un suo possibile intervento diretto? Domande che per ora rimangono senza risposte sicure. Sicuro è che però quest’opera non sarebbe nata senza l’idea primigenia del maestro.
In antico, l’opera era conservata nella chiesa dei Chierici Minori, la chiesa dell’Ospedale di Urbania, dove si trova anche la tomba dell’ultimo duca d’Urbino, ed è probabile che a quella chiesa fosse destinata, dato che lo stesso edificio di culto venne edificato per volontà di Francesco Maria II (ammettendo però l’autografia barroccesca, sussiste incompatibilità di date: il maestro scomparve cinque anni prima che la chiesa fosse costruita, dunque occorrerebbe immaginare, nel caso, che l’opera sia stata realizzata in precedenza, e poi donata alla chiesa). E lì la Madonna delle nuvole è rimasta fino poco tempo fa, fino al febbraio del 2012, quando il soffitto della chiesa crollò per effetto d’una nevicata, abbondante oltre l’ordinario. Per fortuna, tre mesi prima l’opera era stata spostata nei depositi del Museo Civico, in preparazione d’una mostra. Curiosamente, il nome Madonna delle nuvole è moderno, attestato per la prima volta nel 1975. Prima, l’opera era sempre stata chiamata Madonna della neve, dal nome col quale i durantini chiamavano la sua chiesa. E la neve s’è posata sul destino dell’opera.




Possiamo esser ragionevolmente certi del fatto che non ci fosse la Madonna delle nuvole a vegliare su Francesco Maria II quando l’ultimo duca d’Urbino si spense qui, nella sua camera, nel Palazzo Ducale di Urbania, il 28 aprile del 1631. Senza eredi: tutto il ducato passava automaticamente allo Stato della Chiesa. E non erano passati neanche cinque anni che il borgo già cambiava nome in onore del suo nuovo padrone: cinque anni dopo la devoluzione del ducato allo Stato Pontificio, papa Urbano VIII elevava Casteldurante al rango di città e la rendeva sede vescovile. E in suo onore, Casteldurante, era il 1636, diventava Urbania. Era cancellata la memoria di quel prelato provenzale, Guglielmo Durante, nome italianizzato di Guillaume Durand, che l’aveva fondata nel 1284 per accogliere i superstiti del sacco di Castel delle Ripe, borgo poco più a monte ch’era stato distrutto nel 1277 dai ghibellini di Urbino. È per questa ragione che il tessuto urbano del borgo ci appare così regolare: è una città di fondazione, e Guglielmo Durante l’aveva pianificata a tavolino, in mezzo al pianoro che accompagna il corso del Metauro verso il mare prima che arrivino le colline che lo separano da Urbino. Tre secoli e mezzo dopo moriva la Casteldurante ch’era stata quasi una capitale, negli ultimi anni del ducato d’Urbino. Nasceva l’Urbania destinata a diventare una delle tante, anonime province dello Stato della Chiesa.
Questo scadimento, questo declassamento nella lontana periferia “dovette essere per Casteldurante”, ha scritto lo studioso Valerio Mezzolani, “un evento traumatico come forse per nessun altro dei centri dell’Urbinate”. Nel giro di neanche centocinquant’anni, quasi tutte le residenze ducali del territorio erano andate in rovina. L’affronto più grave rimonta però al 1667. Francesco Maria II aveva redatto un lascito in favore dei padri caracciolini di Casteldurante, affinché si prendessero cura dei suoi libri: ciò nondimeno, quell’anno papa Alessandro VII volle far trasferire quasi tutti i volumi della Libraria Nuova a Roma, per rimpinguare gli scaffali della biblioteca dello Studium Urbis, l’Università di Roma. La Biblioteca Alessandrina, come si chiama tuttora (e tuttora conserva la sua vocazione di biblioteca universitaria), era stata fondata il 20 aprile di quell’anno e aveva bisogno di libri. Il papa Chigi ritenne dunque che fosse utile allo scopo l’intero spoglio della biblioteca durantina. Il delegato pontificio Marco Antonio Buratti aveva consentito che a Urbania rimanessero cinquecento libri, dei quindicimila che c’erano in origine, “a beneficio della città” (quanta grazia!). Il papa aveva aperto, sì, all’uso pubblico una raccolta per la quale il lascito di Francesco Maria II non aveva previsto una forma di condivisione con la comunità. Ma aveva strappato via da Urbania il suo patrimonio più prezioso. Oggi, a Palazzo Ducale rimangono pochi libri, e i due grandi, rari globi di Gerardo Mercatore, che Francesco Maria II ricevette in dono e che si salvarono dalla spoliazione: sono tra gli oggetti più preziosi del museo.
Il trauma più recente ha una data e un’ora precise: 23 gennaio 1944, ore 12:42. Giornata chiara, di sole. I B17 dell’aviazione americana bombardano il centro di Urbania, e lo devastano. Le vittime sono 250, i feriti 515, su una popolazione di seimila abitanti: un abitante su sette ha subito conseguenze sulla propria pelle, letteralmente. Quasi raso al suolo il centro storico, l’ala cinquecentesca di Palazzo Ducale ridotta in macerie, la chiesa dello Spirito Santo cancellata, enormi i danni al patrimonio edilizio pubblico e privato. Un bombardamento senza senso, perché Urbania era lontana dal fronte di guerra, non ospitava alcun presidio militare, non c’erano soldati, non era uno snodo logistico, non ci passavano vie di comunicazione importanti. Rimane ancor oggi un massacro privo di spiegazioni. Probabile che si trattasse d’un errore, che gli aerei americani volessero colpire Poggibonsi, in Toscana, dov’era attestato uno stanziamento di soldati tedeschi. Non lo sappiamo con certezza. E forse non si saprà mai perché quel giorno Urbania dovette pagare un prezzo così alto.




Il Palazzo Ducale, dal suo canto, già da tempo aveva smesso d’essere una residenza nobiliare, una sede istituzionale, un centro politico. Con la devoluzione, l’edificio era entrato nell’amministrazione della Camera Apostolica, e gli arredi e le raccolte, altro trauma, avevano seguito il destino delle collezioni ducali, finite in gran parte a Firenze, a seguito del matrimonio tra Vittoria della Rovere, nipote di Francesco Maria II e ultima discendente della famiglia, e Ferdinando II de’ Medici. Era rimasto, in sostanza, un contenitore vuoto. Poi, nel Settecento, la Camera Apostolica concesse l’uso del palazzo alla nobile famiglia Albani, che impiantò qui una fabbrica di ceramica rimasta attiva fino al 1892. L’attività comunque non s’arrestò, perché anche nei decennî successivi il Palazzo Ducale continuò a ospitare piccoli laboratorî di ceramica, almeno fino agli anni Cinquanta, epoca in cui cominciò a strutturarsi, nelle sale del palazzo, il Museo Civico di Urbania. Poi, nel 1980, il Palazzo Ducale è diventato proprietà del Comune di Urbania.
I traumi di Urbania, sì, sono scritti sugl’intonaci del Palazzo Ducale, dentro le sue sale, nel tessuto urbano della città, dove la nuova chiesa dello Spirito Santo, costruita dopo la guerra, è oggi tempio votivo, sacrario dedicato alle vittime del bombardamento. E il suo Palazzo Ducale è tornato a vivere, perché non è soltanto un museo. È sede della biblioteca civica, ricca di sessantamila volumi e di un cospicuo fondo antico. Ci sono gli archivi storici. C’è un centro culturale polivalente, c’è una sala convegni, alcune stanze ospitano una scuola di musica, ci sono anche alcuni servizî culturali che il Comune offre ai suoi cittadini. E vengono ancora organizzati dei laboratorî di ceramica. Nelle cantine è stato anche allestito un piccolo museo dedicato alla civiltà rurale di queste terre. Urbania, come tutte le città operose, guarda in avanti.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).