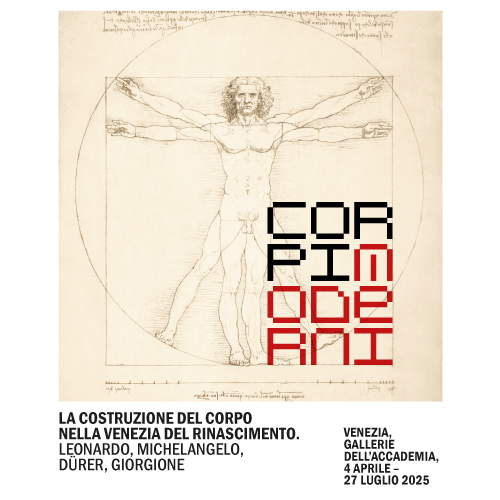Artemisia Gentileschi a Genova, una mostra sgangherata tra biografismo e show inopportuni
Ha suscitato gran sorpresa il recentissimo exploit di Costantino D’Orazio come curatore di mostre d’arte antica: il noto saggista, storico dell’arte contemporanea, divulgatore e personaggio televisivo da anni sugli scudi, a lungo impegnato in un’attività curatoriale che ha riguardato esclusivamente l’arte contemporanea, s’è trovato improvvisamente a inanellare, simultaneamente, la curatela di ben quattro mostre d’arte antica. Più nel dettaglio, negli ultimi cinque mesi D’Orazio s’è presentato come curatore d’una mostra di ceramiche dipinte a Ragusa, della mostra su Artemisia Gentileschi a Genova, di quella sulla natura morta ad Asti, e di un’esposizione sull’amore con opere dal Cinque al Settecento a Terni, tutte aperte tra luglio e novembre di quest’anno. Naturalmente non c’è nessun problema se a quasi cinquant’anni ci si reinventa curatori di mostre d’arte antica, e non sussistono problemi neppure se una delle principali istituzioni culturali del paese, ovvero il Palazzo Ducale di Genova, decide d’affidare la mostra di punta della stagione a un curatore che viene da un altro ambito: se il progetto è solido, se la selezione è di qualità, se il percorso tiene, se la squadra messa assieme dal curatore è composta da esperti dell’argomento, allora sulla carta la mostra dovrebbe riuscire bene anche se per chi cura il progetto si tratta di un’esperienza sostanzialmente nuova. Non è però questo il caso di Artemisia Gentileschi: coraggio e passione, l’esposizione che le sale di Palazzo Ducale a Genova offrono al proprio pubblico fino al prossimo aprile.
Nei giorni scorsi, la mostra è stata travolta da durissime polemiche (e, nelle settimane prima, anche la rassegna di Asti aveva incassato critiche aspre: c’è da dire che cominciare la propria carriera di curatore d’arte antica con due mostre attaccate su quattro non è proprio il massimo), per via del modo in cui il percorso presenta la violenza subita da Artemisia Gentileschi per mano di Agostino Tassi. Ma non è questo il solo problema della rassegna genovese, che in un’ipotetica classifica delle peggiori mostre dell’anno forse riuscirebbe a guadagnarsi il primo posto: nonostante un comitato scientifico che include esperti come Vittorio Sgarbi, Anna Orlando e Riccardo Lattuada, nonostante la presenza di alcune opere mai esposte prima al pubblico, nonostante alcuni prestiti importanti, ci si troverà a visitare una mostra che non regge, spesso incoerente, che dà l’impressione d’esser stata arrangiata senza particolare cura. Artemisia Gentileschi: coraggio e passione sembra costruita come si costruirebbe un mediocre docufilm televisivo: un percorso impostato in buona parte sul biografismo spiccio e sull’aneddotica, un itinerario di visita noioso, contorto e con troppe digressioni inutili, un progetto divulgativo banale, confuso e sensazionalistico, che reitera i soliti cliché sulla vicenda di Artemisia Gentileschi aggiungendo poco non soltanto rispetto alle mostre del passato, ma anche rispetto alla vasta mole di libri, film e documentarî che sono stati prodotti sulla pittrice secentesca. E uno dei primi cliché è proprio quello della donna violata che “soltanto grazie al suo talento” riesce a “scrollarsi di dosso i pregiudizi”: questa, sostanzialmente, l’immagine di Artemisia Gentileschi che si ricava dalla mostra. Ora, sembra opportuno ricordare che una biografia di Artemisia scritta dall’erudito Cristofano Bronzini (il documento è stato recentemente pubblicato dalla studiosa Sheila Barker), all’incirca tra il 1615 e il 1620 a Firenze, e dunque probabilmente sotto supervisione della stessa pittrice (Bronzini, autore d’un’opera Della dignità e nobiltà delle donne, ebbe infatti modo di conoscere di persona diverse artiste), non fa il minimo cenno allo stupro patito dall’artista, e forse non soltanto perché doveva apparire sconveniente raccontare quella storia in un testo che presentava una sorta di idealizzazione di Artemisia, ma sicuramente anche perché la stessa Artemisia avrebbe voluto apparire come una giovane dotata di talento per la pittura e la cui fisionomia artistica fosse paragonabile a quella d’una Sofonisba Anguissola o d’una Lavinia Fontana, due artiste dai trascorsi decisamente meno burrascosi rispetto a quelli della sfortunata collega. E anche Baldinucci, nelle sue Notizie dei professori del disegno, la chiama “virtuosa donna”: così, probabilmente, avrebbe voluto esser ricordata.
Altro cliché, l’idea che Artemisia Gentileschi, per citare il pannello che introduce il pubblico alla mostra, abbia “contribuito in maniera profonda al rinnovamento della pittura, sulle orme di Caravaggio”: in realtà dovrebbe essere ormai dato per acclarato che, per quanto talentuosa possa esser stata Artemisia, e per quanto originali possano essere stati alcuni suoi apici (non molti, e il più importante di questi, la Giuditta di Napoli e Firenze, non è presente in mostra), la sua eccezionalità indiscutibile è legata soprattutto alla riconoscibilità pubblica che riuscì a guadagnarsi al suo tempo e all’approccio che aveva nei riguardi del lavoro, secondo le ragioni ben illustrate da Elizabeth Cropper nel suo saggio incluso nel catalogo della mostra che nel 2013 il Metropolitan di New York dedicò ad Artemisia e a suo padre Orazio, ma anche secondo l’ottima ricostruzione che Yuri Primarosa fornisce nel suo saggio nel catalogo della mostra di Genova (il contributo di Primarosa è una delle rare luci di questa mostra): “l’eccezionalità dell’esperienza artistica e biografica di Artemisia Gentileschi”, scrive lo studioso, “risiede, in definitiva, nella speciale condizione che la donna aveva ritagliato per sé: quella di poter decidere la propria sorte e di potersi elevare al rango di ‘Signora’, vivendo sempre al di sopra delle sue possibilità e rivolgendosi in prima persona a tutti i suoi uomini e a molti dei suoi committenti”.





L’avvio della mostra propone già una lettura romanzata, potremmo dire, della carriera di Artemisia, stabilendo un confronto tra la Susanna e i vecchioni di Pommersfelden e l’omologo dipinto della Moravská Galerie di Brno per suggerire al visitatore che “l’inizio e la fine” del percorso artistico di Artemisia siano “segnati da una donna che subisce una violenza, deve difendersi da un’accusa infamante e si ritrova sola a combattere contro gli uomini. Una coincidenza straordinaria, una metafora dell’intera vita di Artemisia”. Una coincidenza forzata, la si potrebbe piuttosto definire, intanto perché nella produzione di pressoché tutti gli artisti del Seicento figura la presenza di quadri che hanno per soggetto eroine bibliche, e poi perché è sicuramente un’esagerazione voler sancire una correlazione permanente tra la vicenda biografica di Artemisia e i suoi dipinti, come se per tutta la vita l’artista avesse lavorato solo in funzione del triste episodio del 1611 (è vero che poi in mostra non lo si dichiara apertamente, ma un confronto simile in apertura di mostra, e accompagnato da un fraseggio come quello che s’è sopra riportato, induce il pubblico a ritenere che l’intera parabola artistica di Artemisia sia stata una sorta di continua memoria della violenza). “Il nome di Artemisia Gentileschi”, scriveva Judith Mann nel 2013, “adesso evoca un’arte drammatica, popolata di visualizzazioni dirette e senza compromessi di donne forti e integralmente legate agli eventi della sua vita. Questa caratterizzazione descrive forse meno di un quarto dei suoi dipinti conosciuti, eppure persiste”. O, almeno, potremmo dire che persiste presso certi prodotti culturali di largo consumo, o presso certe mostre blockbuster. Quanto alla Susanna di Pommersfelden, poi, la mostra tende a minimizzare l’intervento di Gentileschi senior: nei pannelli di sala viene presentata come un’opera realizzata “sotto la supervisione del padre Orazio” e si afferma che la scoperta, nel 1839, della firma di sua figlia avrebbe fugato “qualsiasi dubbio sull’attribuzione ad Artemisia”. In realtà si tratta di un quadro tutt’altro che risolto e lungo è l’elenco di studiosi che hanno ipotizzato un intervento più o meno esteso di Orazio Gentileschi (Bissell, Contini, Garrard, Christiansen, Greer, Mann e altri, e pure Claudio Strinati nel suo bel saggio in catalogo, laddove afferma che è ragionevole pensare “che Orazio le abbia guidato la mano in questa e altre coeve circostanze”): il padre, del resto, aveva tutto l’interesse a presentare la giovanissima figlia, all’epoca diciassettenne, come un’artista di straordinario talento. Credo si possa convenire con Pierluigi Carofano che, negli atti delle giornate di studi sul caravaggismo e il naturalismo nella Toscana del Seicento (2009), scrive che “è veramente difficile pensare che un dipinto di siffatta qualità sia il prodotto di un’artista ancora adolescente, per quanto dotata”: l’opera è dunque un punto fermo per la ricostruzione del percorso artistico di Artemisia, dato che è il suo primo dipinto datato, ma occorre tornare a pensarlo come un quadro in parte eseguito, e forse anche pensato, da Orazio Gentileschi.
La seconda sala è una carrellata di ritratti di artiste che hanno operato tra il Cinque e il Settecento, superflua e priva di senso: primo, perché non si capisce il motivo d’allargare lo sguardo ad altre artiste, e per giunta su uno spazio di tre secoli, in una monografica su Artemisia Gentileschi; secondo, perché la selezione è comunque riduttiva rispetto a un argomento troppo complesso per essere esaurito in un’unica sala; terzo, perché se l’obiettivo è presentare al pubblico “il talento delle donne tra ‘500 e ‘700”, come recita il titolo della sezione, allora diventa ridicolo e anche un poco imbarazzante offrire al pubblico ritratti di artiste dipinti... da maschi! È questo il caso del ritratto di Lavinia Fontana dipinto da Pietro Bacchi da Bagnara, di quello di Angelica Kauffmann eseguito da Francesco Manno, di quello di Marta Rosa realizzato da Francesco Rosa, di quello di Giovanna Garzoni opera di Carlo Maratta (insomma, quasi tutti i ritratti in sala, esclusi gli autoritratti di Sofonisba Anguissola e di Artemisia Gentileschi). Segue poi un’altra sezione abborracciata, che vorrebbe dar conto dell’apprendistato di Artemisia presso la bottega paterna, ma nella sala vengono radunate tutte opere databili a quando la giovane non solo aveva già lasciato Roma e la casa di suo padre, ma era già sposata e con tre figli (tant’è che, per esempio, il Ritratto di giovane donna come Sibillla di Orazio, alla mostra su Artemisia del 2017, quella di Palazzo Braschi a Roma, era esposto nella sezione sul secondo periodo romano della pittrice e non certo nel capitolo sui suoi esordî). Artemisia è qui presente con un’opera estremamente discussa e sulla cui autografia ancora non c’è accordo unanime (la Madonna col Bambino di Palazzo Pitti, in passato assegnata a Giovanni Francesco Guerrieri, anche se di recente si è riaffermata una ancor più antica attribuzione ad Artemisia, senza però trovare consenso totale) e con una Allegoria della scultura comparsa sul mercato nel 2022 come attribuita a Francesco Cairo, poi successivamente assegnata ad Artemisia da Riccardo Lattuada e Francesca Baldassari, in via indipendente l’uno dall’altra, e aggiudicata in asta quest’estate a quasi due milioni di sterline. Viene comunque datata a un periodo a cavallo tra il soggiorno fiorentino e quello successivo a Roma: un’opera che, come le altre, non ha dunque niente a che vedere con la formazione di Artemisia nella bottega di Orazio. Pertanto, nella sezione che dovrebbe raccontare l’esordio della pittrice, il pubblico si ritrova con un’opera di autografia discussa e con un’opera matura. Il padre è presente con un’opera piuttosto nota, la Santa Cecilia e l’angelo della Galleria Nazionale dell’Umbria: viene suggerito al pubblico che, stando ad alcune non meglio precisate ipotesi, la santa potrebbe essere un ritratto di Artemisia da bambina (un’idea davvero curiosa e non suffragata da alcuna prova seria, tant’è che nella scheda di catalogo redatta da Carla Scagliosi, giustamente, non viene neppure riportata). L’idea che il volto di Artemisia sia presente nelle opere, o perché la pittrice si è autoritratta o perché l’ha ritratta qualcun altro, è onnipresente dall’inizio alla fine e viene proposta per gran parte delle opere esposte: inutile anche commentare oltre. Nella sala successiva, dove viene proiettato un video che ripercorre la storia della decorazione ad affresco del Casino delle Muse (alla quale parteciparono Orazio Gentileschi e Agostino Tassi), si arriva persino a proporre al pubblico la fantasiosa ipotesi secondo cui Orazio avrebbe dipinto sulle pareti del Casino il ritratto della figlia per indurre Tassi a sposarla e riparare così, secondo la mentalità dell’epoca per cui uno stupro era più un danno all’onore che alla persona fisica, la violenza cui l’aveva costretta (occorrerà sottolineare che nel saggio di Claudio Strinati, in cui si parla anche del ritratto di Artemisia negli affreschi del Casino delle Muse, non si fa il minimo cenno a questa ipotesi).




Si entra poi in una sala piuttosto confusa in cui vengono esposte tre marine di Agostino Tassi, presenti non tanto per ragioni storico-artistiche, quanto semmai per dare “prova del suo eccezionale talento” (così nel pannello di sala), accanto ad alcune “donne minacciate” di Artemisia per spostare ancora la narrazione della mostra sul piano delle vicende personali della protagonista (la Betsabea degli Uffizi, la Morte di Cleopatra di Collezione Ducrot e un Paolo e Francesca di recente attribuzione ad Artemisia rivestono dunque un ruolo piuttosto strumentale, anche perché sono opere cronologicamente situate molto lontane dalla vicenda dello stupro). Vicende personali che vengono spettacolarizzate nell’installazione della sala successiva: un ambiente con, al centro, un letto sfatto, rivoli di sangue alle pareti, e una voce femminile che interpreta la testimonianza dello stupro resa da Artemisia durante il processo contro Agostino Tassi. Un momento di trash con tinte voyeur che non dovrebbe aver niente a che vedere con una mostra seria e capace di trattare da adulti i suoi visitatori, e che peraltro parrebbe imitare una scenografia omologa che Emma Dante aveva allestito nel percorso della mostra su Artemisia che si tenne tra il 2011 e il 2012 a Milano, a Palazzo Reale: all’epoca, l’installazione non suscitò l’indignazione sollevata oggi da quella di Palazzo Ducale, ma questo non era un buon motivo per reiterare l’esperimento a più di dieci anni di distanza, perché se il focus di una mostra su Artemisia Gentileschi dovrebbe essere la pittura, la trasformazione delle sue sconvolgenti vicissitudini biografiche in uno show inopportuno si pone in maniera opposta rispetto agli obiettivi di una mostra che voglia essere equilibrata e rispettosa della pittrice.
La ricostruzione romanzata della storia di Artemisia prosegue comunque nella sala successiva, la cui descrizione smentisce il titolo (“La vendetta di Artemisia”), dacché gli apparati di sala affermano che “chi sostiene che Artemisia dipinga più volte nella sua carriera la scena in cui Giuditta decapita Oloferne perché vuole vendicarsi in questo modo della violenza subita da Agostino Tassi, non rende sufficiente merito al suo talento e alla sua grandezza”: la sala espone alcuni dipinti che hanno per soggetto Giuditta e Oloferne per dimostrare, ci informano i pannelli, che “nello sguardo di Artemisia, Giuditta è più decisa e fiera rispetto a come sia stata dipinta da altri grandi pittori del tempo”. E per dimostrarlo, il curatore ha qui riunito la Giuditta di collezione Lemme, opera molto discussa, di autografia non certa (e nel caso sarebbe comunque opera giovanile, da collocarsi attorno al 1610 se non anche prima), e dove l’eroina biblica “mostra senza alcuna eccitazione il macabro bottino” (così Maria Cristina Terzaghi nel catalogo della mostra del 2017, dove l’opera veniva proposta come una collaborazione tra padre e figlia), e poi ancora la Giuditta di Capodimonte, variante di qualità inferiore rispetto all’omologo dipinto di Detroit (tanto che c’è chi ha messo in discussione l’autografia), e opera in cui l’artista, “rispetto alla violenza delle precedenti versioni […] cambia registro e predilige la narrazione del pathos successivo all’uccisione del generale assiro” con una scena a lume di candela che “echeggia una moda diffusasi in quegli anni” (ancora Terzaghi, nel catalogo della mostra su Artemisia dello scorso anno), e infine una... replica della celebre Giuditta di suo padre Orazio adesso ad Hartford (il pubblico italiano ha visto l’originale lo scorso anno alla mostra Caravaggio e Artemisia. La sfida di Giuditta tenutasi a Palazzo Barberini). La replica in questione, esposta per la prima volta un anno fa da Pierluigi Carofano alla mostra Dramma e passione della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, viene esposta a fianco a un’altra replica del dipinto di Hartford, quella conservata alla Pinacoteca Vaticana, opera su cui la critica ha espresso diverse posizioni, anche se i più la ritengono opera di bottega (in mostra è presentata come autografo di Orazio), mentre soltanto Mary Garrard in passato l’ha ritenuta opera di Artemisia (un’idea che non ha avuto seguito). In mostra manca l’originale di Hartford (che peraltro ha pure una storia collezionistica antica legata a Genova) e dunque il confronto è tra l’opera assegnata ad Artemisia e la replica di bottega.





Le due sezioni successive, quella sui caravaggeschi genovesi e quella intitolata “Orazio Gentileschi e Roma criminale” (!) sembrano due semplici riempitivi, date le selezioni striminzite, insufficienti a fornire una rappresentazione esauriente degli argomenti affrontati, per quanto, paradossalmente, appaiano come i due capitoli più coerenti della rassegna: la parte su Orazio, in particolare, si concentra sugli sviluppi della sua arte nel primo scorcio del Seicento, grazie anche alla presenza di tre prestiti importanti (il San Francesco del Prado, il San Girolamo di Torino e il David della Galleria Spada di Roma, due capisaldi del percorso di Orazio, utile per rendersi conto dei suoi rapporti con l’arte di Caravaggio) che consentono al pubblico di farsi un’idea di come doveva lavorare l’artista nel momento in cui Artemisia cominciava ad apprendere i primi rudimenti nella bottega paterna (il pubblico è dunque costretto a tornare indietro nel tempo). Dopo questo lampo la mostra torna però a barcamenarsi tra le sue difficoltà: la sezione sul periodo fiorentino di Artemisia, che segue quella dedicata a Orazio, presenta al pubblico soltanto tre opere, una sola delle quali è riferibile al soggiorno a Firenze (la Cleopatra di collezione privata, esposta per la prima volta alla mostra del 2017, che potrebbe esser stata dipinta a Firenze, oppure immediatamente dopo che la pittrice lasciò la città granducale, mentre l’altra Cleopatra è un dipinto degli anni napoletani e il Ritratto di dama con ventaglio, proveniente dalla raccolta genovese di casa Balbi, per le somiglianze col Ritratto di gentiluomo di Palazzo d’Accursio a Bologna è riferibile alla metà degli anni Venti: peraltro vi si è voluto in passato vedere un autoritratto di Artemisia, eventualità suggerita anche dalla mostra genovese, ma che si può tranquillamente escludere in ragione dell’abbigliamento, che testimonia una ricchezza e uno status molto lontano da quello della pittrice).
Le ultime sezioni della rassegna non si discostano granché da quanto il pubblico ha avuto modo di vedere fino a questo punto: l’impostazione è ancora centrata sulle “eroine” di Artemisia (s’è già detto che non c’è correlazione tra i soggetti dei suoi dipinti e il vissuto della pittrice, e in più qui la mostra si spinge addirittura a sostenere che l’elemento che accomuna tutte le donne dipinte da Artemisia presentate in sala sta nel fatto che “sono quasi tutte il suo autoritratto”!), con una sala dove compaiono l’Aurora della Collezione Masu, la Minerva degli Uffizi e la Maddalena della collezione Sursock di Beirut, che il pubblico italiano ha dunque modo di rivedere a due anni di distanza dalla sua esposizione alla mostra Le signore dell’arte di Palazzo Reale a Milano, dove l’opera veniva presentata coi danni subiti durante l’esplosione del porto della capitale libanese del 2020, mentre adesso la si può ammirare restaurata. Accanto, se può avere un minimo di senso esporre la Lucrezia di Simon Vouet (è comunque un’opera degli anni Venti del Seicento), appare invece del tutto fuori contesto la Maddalena di Luca Cambiaso. Si prosegue quindi con un affondo tematico sulla storia di Sansone e Dalila, che include un inedito, un dipinto assegnato in quest’occasione ad Artemisia da Riccardo Lattuada di cui si conosce almeno una replica, passata in asta da Cambi nel 2013, e una discussa tela di collezione privata, in passato assegnata a Domenico Fiasella pure da un esperto di Artemisia come Roberto Contini, poi a Giuseppe Vermiglio da diversi studiosi, e attribuita invece ad Artemisia ancora da Lattuada, proprio in occasione della mostra genovese. L’ultima sala, che dovrebbe essere centrata sull’ultima fase della carriera di Artemisia, il periodo napoletano, presenta una sola opera, benché importante, ovvero l’Annunciazione del Museo di Capodimonte, prima opera napoletana certa di Artemisia, data 1630, e dipinto per cui sono imprescindibili le due Annunciazioni di Orazio eseguite durante il suo soggiorno genovese: una di queste si trova ancora in città, nella basilica di San Siro. Manca la possibilità di un vero affondo sull’Artemisia napoletana, dal momento che tutte le opere databili agli ultimi anni portate a Palazzo Ducale sono state sparpagliate nelle varie sezioni sulle “eroine”: in compenso continua fino alla fine la sequenza degli stereotipi sulle donne di Artemisia, tanto che per l’Annunciazione di Capodimonte il pannello arriva a sostenere che anche qui l’artista “si dedica all’esaltazione della grandezza di una donna” (!).








In conclusione di percorso, il curatore ha deciso di evitare accuratamente una delle cose più sensate che avrebbe potuto fare, ovvero lasciare in pace gli affreschi della Cappella del Doge, troppo spesso tormentati, nelle mostre passate, da allestimenti che intralciano una corretta visione delle scene che decorano l’ambiente più intatto e spettacolare di Palazzo Ducale: così, chi sperava di rinfrancarsi con la visione delle pitture di Giovanni Battista Carlone deve fare i conti con due inutili megaschermi sistemati proprio al centro della cappella, che servono per proiettare le gigantografie delle opere esposte nell’itinerario di visita (!) e di altri lavori non presenti invece alla mostra di Costantino D’Orazio. Termina così, con proiezioni digitali di riproduzioni fuori scala, una mostra che, tolti pochi spunti (le nuove attribuzioni, le opere di Orazio nella sezione a lui dedicata, la presenza di alcuni lavori importanti come la Susanna di Pommersfelden o l’Annunciazione di Napoli), non sarà certo ricordata come un prodotto all’altezza della sede che lo ospita, né come una memorabile rassegna su Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi: coraggio e passione pare semmai un prodotto commerciale, impostato non per trasmettere qualcosa al pubblico, ma per assecondare un racconto preconfezionato che, invece di contribuire ad abbattere gli stereotipi su Artemisia Gentileschi, sembra quasi lucidarli e metterli in vetrina, in controtendenza rispetto alle ultime occasioni espositive dedicate all’artista, o nelle quali Artemisia aveva un ruolo di primo piano. Manca poi un invito esplicito ad andare a vedere i due capolavori gentileschiani che si trovano in città (la già citata Annunciazione di San Siro e il Sacrificio di Isacco custodito a Palazzo Spinola che peraltro è legato al San Girolamo esposto in mostra).
Eccessivo il prezzo del biglietto (16 euro l’intero, 15 il ridotto) a fronte di una mostra disordinata, scadente sul piano divulgativo, con poche opere rilevanti, diversi lavori di secondo piano e opere sulla cui attribuzione non vige l’unanime consenso della critica. Naturalmente non sarebbe un problema allestire una rassegna dove buona parte delle opere ha affrontato complesse vicende attributive, spesso non ancora concluse: sono però occasioni riservate segnatamente agli studiosi (si spera dunque che, almeno, la mostra genovese riaccenda le discussioni su alcuni pezzi), mentre per una rassegna pensata per un pubblico largo ci s’immaginerebbe semmai un itinerario che proponga ai visitatori per lo più opere certe o quanto meno solide, sulle quali vige ampio accordo. Si salva il catalogo che, tolti alcuni inserti discutibili (per esempio le pagine di Costantino D’Orazio o Pietrangelo Buttafuoco recuperate da pubblicazioni già edite), è sicuramente migliore, più coerente e ordinato della mostra che accompagna, propone una serie di buoni contributi e con le schede fornisce informazioni precise. Una pubblicazione che però non basta a riscattare una mostra sgangherata e priva di fondamenta solide.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).