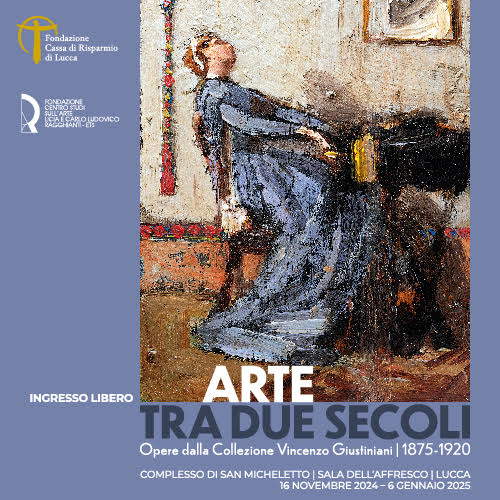Perché non si scrivono praticamente più recensioni di mostre?
Morte della critica. Scomparsa della critica. Crisi della critica. Se ne parla così tanto, e da così tanto, che mettendo assieme tutto quel ch’è uscito sul tema negli ultimi trent’anni si potrebbe pensare di dar vita a un nuovo genere letterario. L’argomento torna ciclicamente a impossessarsi delle pagine dei giornali e delle riviste (tipicamente quelle che trattano d’arte visiva o di letteratura, ovvero le due materie dove l’assenza della critica s’avverte di più), aggiornandosi di volta in volta sulle novità del momento, senza che però la situazione di fondo subisca modifiche sostanziali. Quello che segue, dunque, non è un contributo animato dalla pretesa d’essere originale, ancor meno dalla volontà d’essere esaustivo, ma semplicemente dal proposito di scattare una rapida fotografia a uno dei mezzi della critica d’arte, la recensione, ch’è stato oggetto d’un recente dibattito negli Stati Uniti partito da un lungo e dettagliato articolo di Sean Tatol pubblicato su The Point Magazine qualche settimana fa. Ci si riferirà, nelle poche pagine che seguono, soprattutto alle recensioni delle mostre, dacché le mostre sono il tipo di produzione con cui tanto il pubblico quanto gli addetti ai lavori sono soliti misurarsi più di frequente, sia che si parli d’arte antica, sia che si parli d’arte contemporanea. La recensione, naturalmente, non è l’unico mezzo attraverso cui la critica s’esprime, ma è probabilmente il più immediato per verificarne le condizioni di salute: chi volesse ripercorrere una storia della “crisidellacriticologia”, per adoperare l’efficace sostantivo che Daniele Capra ha coniato su queste pagine un anno fa, quando Finestre sull’Arte lanciò l’ennesimo round del dibattito attorno alla morte della critica, potrebbe tornare indietro fino al 1959 (anche se non escludo che si possa andare ancor più a ritroso), anno in cui Elizabeth Hardwick, sull’Harper’s Magazine, pubblicò un pezzo dal titolo autoesplicativo (“The decline of book reviewing”, “Il declino delle recensioni dei libri”) individuando già a quell’epoca alcuni problemi di cui la critica letteraria cominciava a soffrire. Ed è utile sottolineare come persino a quelle altezze cronologiche Hardwick rinvenisse i sintomi del declino della critica letteraria nella fiacchezza e nell’assertività di gran parte delle recensioni che venivano pubblicate anche su giornali importanti.
La voce della critica, in tutti questi decennî, è diventata sempre più debole ed è entrata in crisi in tutto il mondo, malgrado si possa riscontrare un apparente paradosso: mai come in questi ultimi tempi ci sono così tante persone che parlano d’arte, agevolate dalla facilità dei mezzi che la tecnologia oggi ci mette a disposizione per raggiungere una platea (fino a circa dieci anni fa, non si poteva neppure prendere in considerazione l’idea di sfiorare un pubblico se non si avevano alcune conoscenze tecniche necessarie ad attivare la propria presenza su internet). Eppure il genere della recensione sembra essere ormai completamente sparito dalla pubblicistica d’arte: il panorama, piuttosto sconfortante per chi ancora ritiene che la recensione sia un mezzo utile per orientarsi nel sempre più vasto panorama delle produzioni artistiche (vale tanto per quelle contemporanee, quanto per quelle che hanno a che fare con l’arte antica), è quello fotografato da Letizia Lala in un suo saggio, intitolato “La cronaca d’arte sul web” e pubblicato nel 2020 sulla rivista Lingue e culture dei media dell’Università di Milano, in cui veniva rilevata, fatte salve rare eccezioni, una sostanziale “rinuncia al compito di giudicare” che “trova nei moderni mezzi di comunicazione, con il loro alto grado di informalità, e con le loro produzioni contratte ed effimere, di rapida stesura e rapida lettura, un veicolo particolarmente potente, che sta stimolando forme di cronaca d’arte poco engagées: di critica acritica”. La studiosa, nel suo corposo articolo, gettava il suo sguardo soltanto sulle produzioni disponibili su internet, ma lo stesso discorso potrebbe essere esteso anche ai giornali su carta. Non si nega, naturalmente, che esista una critica trasmessa attraverso piccole pubblicazioni cartacee indipendenti, i cui risultati faticano però a uscire dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori, e spesso non sono neppure in grado di raggiungere tanti che s’occupano d’arte per mestiere: il paradigma del “ci facciamo festa da soli” non è, purtroppo, un argomento dialettico sufficientemente incisivo. E non lo è per un motivo piuttosto semplice: perché quando s’allarga la visione, la situazione è quella che veniva descritta in modo lapidario due anni fa, nel dicembre 2021, da Alfonso Berardinelli in un’intervista a Repubblica, nella quale il noto critico letterario si trovava a constatare, con una certa dose d’amarezza, che “il giornalismo culturale è peggiorato, come inibito, paralizzato. Giustifica, fa apologia, diventa pubblicità”.
Non che negli ultimi due anni non si siano prodotte delle situazioni significative che, pur ovviamente prive del potenziale di sovvertire le sorti della critica (e pure quelle del genere della recensione), potevano quanto meno aspirare ad avere un ruolo palliativo, candidandosi a mitigare gli effetti della crisi: penso, in particolare, all’esplosione di Instagram, dove a partire dal primo lockdown, nella primavera del 2020, schiere di utenti che prima d’allora forse neppure avevano preso in considerazione l’idea di parlare a un pubblico, si sono ritrovati ad aprire account dai quali hanno cominciato a parlare d’arte. Instagram, naturalmente, ci ha messo del suo: dovendo arginare la concorrenza di Tiktok, nello stesso periodo ha facilitato tutti quei creativi che, invece di esprimersi attraverso immagini, grafiche e fotografie, ovvero i mezzi che hanno permesso a Instagram di distinguersi nel mondo dei social network, si sono messi a creare brevi video, solitamente inferiori al minuto, nei formati tipici di Tiktok, con montaggi semi-professionali resi possibili dall’armamentario che il social di Meta ha fornito ai suoi utenti col preciso scopo di metterli nelle condizioni di creare contenuti gradevoli, accattivanti, in linea con ciò che l’algoritmo di Instagram è solito promuovere. Da questo terreno, fertile e relativamente facile da coltivare, è germogliata una vasta torma di divulgatori, influencer, intrattenitori assortiti, per la stragrande maggioranza giovani e che, forti di seguiti più o meno vasti, quasi quotidianamente riversano video, reel, stories che tipicamente esauriscono gli argomenti affrontati nello spazio d’una trentina di secondi. Mancano invece profili che facciano critica, anche al livello più elementare: visitare una mostra e offrire al pubblico un giudizio, anche breve e limitato.
Il mezzo, dunque, malgrado le sue potenzialità (facilità d’utilizzo, trasversalità, pervasività, adattabilità), e malgrado le caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto sia, mettiamo, a una eventuale figura d’un giovane critico alle prime esperienze, sia a profili più esperti, non ha catalizzato esperienze alternative: al contrario, si sono riprodotte qui le logiche che caratterizzano i mezzi tradizionali e che venivano già individuate esattamente vent’anni fa in uno scritto di James Elkins (“What happened to art criticism?” del 2003), tra i più citati sul tema in virtù della sua efficacia e della sua completezza. Vale a dire, chi si occupa d’arte preferisce descrivere, evocare o interpretare piuttosto che dire cosa ne pensa dell’oggetto che ha di fronte: sarebbe come se un fisico, scriveva Elkins, “dichiarasse di non voler più cercare di capire l’universo, ma semplicemente di volerlo apprezzare”. La stragrande maggioranza della scrittura d’arte, oggi, si limita alla descrizione o all’interpretazione. Nel descrivere l’opera d’un artista contemporaneo, ci si limita il più delle volte a osservarla, a raccontarla (magari nobilitandola con qualche citazione filosofica superficiale), tutt’al più a riportare il pensiero dell’artista: diventa sempre più raro trovare una scrittura critica che non soltanto riesca a stabilire una connessione profonda con l’opera d’un artista, ma che riesca anche a collocare la produzione dell’artista nel contesto d’un quadro storico, o che riesca a trovare eventuali derivazioni, filiazioni, elementi di confronto. Vale, naturalmente, anche nel caso d’una critica positiva: la critica non deve per forza essere negativa. Lo stesso problema si pone quando si leggono articoli sulle mostre d’arte antica: la recensione, testo argomentativo-valutativo per definizione, quando non viene sostituita dalla risciacquatura della cartella stampa oppure da un genere particolarmente in voga quale è la sintesi del comunicato seguita dall’intervista al curatore (e, beninteso, intervistare il curatore d’una mostra non è un’attività esecrabile, anzi, spesso è utile ascoltare il racconto di chi ha organizzato una mostra: non va bene se questo mezzo e la risciacquatura diventano gli unici strumenti che una testata adopera per parlare di mostre al pubblico), ha ceduto il passo ad articoli in cui si descrive semplicemente quel che si vede nelle sale, rinunciando al proprio giudizio, positivo o negativo che sia. Una sorta di cronaca della mostra, dunque, resa solitamente nel giro di uno o due giorni dopo l’apertura, dove conta di più la capacità d’arrivare per primi a fornire un racconto rispetto alla capacità di formulare un giudizio su quanto s’è visto. Questi generi di scrittura d’arte, che spesso vengono proditoriamente spacciati per recensione pur mancando sia degli elementi argomentativi sia degli elementi valutativi, hanno preso il sopravvento ovunque: sulle testate generaliste, sulle riviste di settore, sui profili social degli intrattenitori e dei divulgatori più o meno blasonati. Tutti che parlano di mostre, quasi nessuno che esprime la propria posizione su quello che osserva.
Come si è prodotta questa situazione? Due validissime ragioni, riferite all’ambito letterario ma perfettamente calzanti anche per le arti visive, venivano individuate già nel 1991 da uno dei maggiori critici letterarî italiani, Romano Luperini, in un saggio intitolato “Tendenze attuali della critica in Italia”, pubblicato sulla rivista Belfagor. Luperini, intanto, faceva distinzione tra la critica militante “giornalistica” e la critica militante “partigiana”, intendendo con la prima quella che collabora con la ricerca artistico-letteraria e si esprime sostanzialmente attraverso l’emissione di giudizî sulle produzioni artistiche e letterarie, e con la seconda quella che è volta a sostenere una determinata poetica contro le altre. Luperini riteneva che la critica giornalistica fosse “morta soprattutto per due ragioni”: da una parte la nuova organizzazione industriale della cultura, responsabile d’aver “rivoluzionato non solo le pagine culturali dei quotidiani e dei settimanali, ma anche l’intero universo massmediologico”, e dall’altra l’istituzionalizzazione della critica, trasformata in disciplina accademica, in “asettico oggetto di studio”. Luperini, come anticipato, pensava alla critica letteraria, ma lo stesso ragionamento può serenamente applicarsi anche alla critica d’arte. Si potrebbero poi aggiungere altri due elementi, che il divario di trent’anni da quel brillante scritto ha reso oltremodo evidenti: il fatto che le arti visive non rappresentino più l’arte dominante del nostro tempo, e l’affermarsi di quella che Byung-Chul Han ha definito la “società palliativa”, costantemente orientata alla ricerca della felicità a ogni costo.

Si potrebbe partire da quest’ultimo punto: la società palliativa tende a evitare il confronto doloroso, e “tenta di sbarazzarsi di tutto ciò che è negativo”, scrive Byung-Chul Han, preferendo sostituire il confronto col pensiero positivo che allontani l’orizzonte del dolore dall’esperienza dell’essere umano. Di conseguenza, “la società palliativa è […] una società del mi piace, che cade vittima della mania di voler piacere. Ogni cosa viene lucidata finché non suscita approvazione. Il like è l’emblema, il vero e proprio analgesico della contemporaneità. Non domina solo i social media, ma anche tutti gli ambiti della cultura. Nulla deve più far male”. Accade dunque che l’attività di chi si trova a esprimere giudizî venga guardata con sospetto, specialmente se s’esprime con prese di posizione negative: il critico viene visto come un’interferenza fastidiosa e non necessaria, giunta a turbare l’estatica contemplazione del pubblico, oppure viene chiamato ad astenersi dal disturbare il lavoro di chi mette un prodotto culturale a disposizione del pubblico, e talvolta gli verrà pure mossa l’accusa d’essere rancoroso o addirittura invidioso nei confronti dell’oggetto della sua critica (credo sia capitato almeno una volta a tutti coloro che lungo la loro carriera si son trovati a scrivere una recensione negativa). Queste trasformazioni che hanno interessato la nostra società spiegano in parte perché è ormai rarissimo rinvenire stroncature su tutti i mezzi, ma da sole non bastano a fornire spiegazioni sufficienti, dal momento che son sempre più difficili da trovare anche le valutazioni positive (si parla, ovviamente, della recensione dove il proprio giudizio è sostenuto da un’argomentazione anche basilare, e non del mero apprezzamento superficiale, che invece abbonda). Una prima spiegazione di quest’assenza potrebbe esser sostenuta da ragioni che hanno a che fare con l’esperienza individuale del critico: se ti trovi a parlare sempre in positivo, anche argomentando, rischi di perdere credibilità, perché il pubblico prima o poi s’aspetta una stroncatura. Si può poi opporre l’argomento, legittimo, dell’indifferenza, sottolineando che il non voler dedicare attenzione a una mostra scadente sia già di per sé un giudizio critico. Ma è sempre meglio non rischiare: rinunciando al giudizio tout court si evita di trovarsi, prima o poi, nella situazione di dover rendere spiegazioni al pubblico.
Ovviamente, le valutazioni individuali del critico posto di fronte alle eventuali reazioni del pubblico non sono che una parte del problema. Occorre allora spostarsi su di un altro piano: il fatto che le arti visive abbiano perso il loro posto di arte dominante (credo che oggi il ruolo di arte dominante vada riconosciuto al cinema, seguito a qualche distanza dalla musica: le arti visive forse non sono più neppure tra le prime cinque posizioni, volendo tentare una classifica di rilevanza per il pubblico e per l’industria) ha avuto come effetto una progressiva atrofizzazione di tutto il settore, direttamente proporzionale alla perdita di rilevanza delle arti visive per la vita delle persone. Non che il settore delle arti visive manchi di vitalità, ma i numeri del nostro mondo non sono neppure lontanamente paragonabili a quelli del cinema (per la differenza tra la critica d’arte e la critica cinematografica rimando a un bell’intervento di Luca Bochicchio sulle pagine di Finestre sull’Arte), oppure, mettiamo, a quelli del design. Sarà sufficiente qui rammentare che la più importante fiera d’arte del mondo, Art Basel, nel 2019 è stata visitata da circa 95mila persone, mentre la più significativa fiera mondiale di design, il Salone del Mobile di Milano, totalizzava oltre 430mila visitatori: è vero che la kermesse lombarda dura due giorni di più, ma i numeri comunque affermano che la principale fiera di design richiama il triplo di visitatori della principale fiera d’arte. Succede allora che nel settore delle arti visive, più spesso che altrove, si configurino dei rapporti d’interrelazione tra i soggetti che investono e quelli che scrivono, che finiscono per produrre situazioni piuttosto tipiche: si evita, per esempio, di formulare giudizî su una mostra organizzata da un soggetto che ha investito in pubblicità sulla rivista (per quanto esistano istituti ben consci che la critica e la pubblicità viaggiano su canali separati, e dunque non hanno problemi a investire in pubblicità anche qualora si prospetti la possibilità di una recensione non benevola), oppure si tende a non recensire la mostra di un soggetto col quale si ha in progetto di aprire un canale di comunicazione, o ancora può accadere che una rivista scelga di far parlare di una mostra a un recensore più clemente (quando, ovviamente, non si fa scrivere il pezzo sulla mostra al curatore stesso: accade anche questo). Ancora, le dimensioni vieppiù ristrette del settore sono responsabili della frequente sovrapposizione dei ruoli, nel senso che accade spesso che chi organizza o cura mostre si trovi, nei momenti d’interstizio tra una rassegna e l’altra, a vestire i panni del giornalista o del critico, e per non rischiare d’inimicarsi chi poi dovrà recensire la sua mostra s’asterrà dal produrre un giudizio negativo sulle attività dei colleghi. Quando le maglie s’allargano, ovviamente crescono anche le possibilità per una critica ritenuta meno rischiosa: “Si può notare […] come, nell’arte contemporanea, una certa critica – anche negativa – emerga soprattutto nei confronti di opere e operazioni di artisti dal profilo e dalla risonanza internazionale o globale, e questo in virtù della distanza che si stabilisce tra questi artisti e una buona fetta della critica militante”, mentre quando “ci si muove all’interno di una rete più ristretta, la comunità collabora, dialoga, si scambia favori e lavori, ed è quindi nella natura umana che si preferisca a volte il quieto vivere e l’opportunità professionale all’integrità e all’approfondimento del discorso critico” (così Luca Bochicchio).
Per gli stessi motivi, la “critica acritica” può diventare anche un’attività calcolata soprattutto laddove chi scrive aspiri a ottenere incarichi, da quelli più prestigiosi (la direzione di un museo, oppure la curatela di una mostra importante e ben remunerativa) a quelli più occasionali ma che fanno curriculum (la presenza a una conferenza), e ritenga dunque più conveniente mantenere un atteggiamento conservativo quando scrive. Per com’è strutturato oggi il sistema dell’arte, e tenendo anche conto della precarietà del lavoro nel settore, molti ritengono più vantaggioso coltivare le pubbliche relazioni (anche scrivendo sulle riviste: un articolo scritto in un certo modo può essere un utile veicolo promozionale) che esercitare un’attività critica anche minima. Non manca, naturalmente, chi invece fa calcoli molto più triviali: stante il fatto che gli uffici stampa sono sempre “pronti a gratificarti con mille benefits e a soffocarti di premure” se visiti una mostra per recensirla (così scriveva Antonio Pinelli nelle sue memorabili “Confessioni di un recensore di mostre”, del 2005, uno dei testi più godibili, acuti e utili per capire come lavora chi scrive recensioni), esiste una vasta pletora di recensori, solitamente molto presenzialisti, che non sono disposti a giocarsi la possibilità di ricevere questi benefit (ovvero anteprime, viaggi pagati da chi organizza le mostre, possibilità di partecipare a pranzi e cene, e quindi tessere relazioni: dietro le mostre esiste un mondo che spesso non è noto a chi sta dall’altra parte del foglio) a fronte di una recensione negativa o anche semplicemente critica.
Le modifiche subite dall’industria culturale da diversi decennî a questa parte naturalmente hanno avuto un ruolo altrettanto preminente nel ridurre le occasioni di critica. La produzione artistica e letteraria si è notevolmente intensificata, le redazioni sono costrette a inseguire le novità, e il tempo per osservarle in maniera critica si è notevolmente ridotto: recensire è un’attività che richiede tempo e richiede conoscenze (non soltanto sull’oggetto della mostra, ma anche, per esempio, su argomenti che hanno a che fare con l’oggetto della mostra, ed eventualmente anche sulla produzione accademica attorno al tema della mostra e sulla storia espositiva che ha preceduto l’evento in questione, e via dicendo), specialmente quando ci si trova a dover produrre una stroncatura, dal momento che una recensione negativa espone ovviamente chi la scrive al rischio di contrattacchi, e dinnanzi all’eventualità di subire controffensive occorre rendersi il meno vulnerabili possibili, e per coprirsi non esiste altro modo che scrivere preparati. Il rischio, naturalmente, non si corre se il giornalista incaricato di recensire la mostra si limiterà a un reportage di ciò che ha visto, attività per la quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, fatta eccezione per le competenze tecniche del mestiere di giornalista (verifica delle fonti, conoscenza delle regole deontologiche e così via): mi capitò, una volta, di trovarmi all’anteprima stampa di una mostra su Giulio Romano a Mantova, durante la quale una collega, conversando con un’altra giornalista, dopo averle elencato le ultime mostre visitate in quel di New York, le chiedeva cosa c’entrasse Giulio Romano con Mantova. Domanda più che lecita da parte di un visitatore occasionale, meno se viene formulata da una giornalista cui la propria testata affida il compito di scrivere della mostra: dubito seriamente che possa esserne uscita una recensione consapevole, mentre più probabile che il pezzo della collega si sia risolto con una semplice risciacquatura del materiale stampa. È del resto risaputo che le redazioni delle testate generaliste ormai non abbiano praticamente più personale che si dedichi esclusivamente alle arti visive (con tutte le conseguenze del caso: le bufale attorno alle attribuzioni di pessime opere a nomi altisonanti sono il frutto più appariscente di questo disinteresse).
Un’industria culturale che offre di continuo nuovi prodotti (si pensi a quante mostre ogni anno vengono organizzate in Italia) si trova poi a dover fare i conti con un pubblico che viene sottoposto a una quantità sempre crescente di stimoli: diventa quindi cruciale raggiungere il pubblico, più che fornirgli strumenti per orientarsi. Anzi: la critica rischia di diventare un ostacolo. Lo ha spiegato bene Roberto Carnero sulle pagine dell’Avvenire lo scorso gennaio, in riferimento a quel che accade nel settore della letteratura: “le case editrici, tramite i loro più o meno efficienti uffici stampa, sono molto presenti nel momento in cui si tratta di promuovere un certo libro o un certo autore, ma reagiscono in maniera non sempre diplomatica quando il critico si permetta di fare davvero il proprio mestiere, cioè di criticare l’opera in questione, magari avanzando obiezioni o riserve”. Si sostituisca, mettiamo, il termine “case editrici” con la parola “gallerie”, e si troverà una descrizione adattabile anche al sistema dell’arte contemporanea, sempre meno interessato a produrre critica. Servono dunque buoni comunicatori più che buoni critici, servono persone che sappiano raccontare l’arte più che esprimere giudizî, e chi sviluppa le proprie competenze narrative o relazionali avrà sicuramente più possibilità di lavoro rispetto a chi invece avrà sviluppato un’attitudine critica. In questo senso, i calcolatori più freddi e lucidi sono proprio i divulgatori, gli intrattenitori e gli influencer che operano sui social (malgrado talvolta si creda, a torto, che queste figure siano più genuine rispetto a chi fa critica giornalistica), poiché consapevoli che le uniche possibilità che hanno per lavorare nell’ambiente sono o sviluppare una base di seguaci talmente ampia da diventare appetibili per chi voglia promuovere tramite i loro canali un proprio prodotto (strada difficile), o dimostrare competenze comunicative e proporsi come consulenti per tutti quei soggetti (musei, gallerie, società di produzione, case editrici e via dicendo) che necessitano di promuovere i proprî prodotti su quegli stessi canali coi quali i nuovi comunicatori dell’arte via web hanno piena confidenza (strada più facilmente percorribile). A chi giova allora recensire? Meglio essere organici per non tagliarsi opportunità di lavoro: “C’è un’industria del tempo libero da far fruttare e un ambito artistico da capitalizzare […]. Come? Ampliando indiscriminatamente il pubblico […], equiparando la cultura allo svago, fomentandone i bisogni e la richiesta, iniziando alla celebrazione di un rito. Come? Attraverso un’arte più facile, impattante, immediatamente comunicabile, accessibile, fruibile. Un’arte ‘popolare’, di massa, da consumare. Come? Intrattenendo, spettacolarizzando, creando un evento da veicolare attraverso la potenza del marketing: stupire e sorprendere” (così Luca Zuccala).
C’è quindi ancora spazio per una critica che produca recensioni? O, più in generale, c’è ancora spazio per una critica? Si può auspicare un miglioramento? All’ultima domanda tocca dare, per il momento, una risposta negativa, perché i problemi non sono contingenti, ma sono strutturali, dunque a meno che non si producano avvenimenti di vasta portata che introducano cambiamenti radicali (e al momento non è dato immaginarne), la situazione generale rimarrà invariata. Esiste ovviamente una critica “istituzionale”, per così dire, prodotta in ambito scientifico dalle università o dagli istituti che fanno ricerca, che studiano con approccio accademico le produzioni del presente. Si tratta però di ricerche che quasi mai travalicano i confini dell’accademia raggiungendo un pubblico vasto: quando si lamenta il declino della critica, tendenzialmente si pensa alla critica in grado di raggiungere platee ampie, o quantomeno non composte soltanto da addetti ai lavori. Chi può permettersi di fare una critica di questa portata, tolti i temerarî e tolti i fuoriclasse? Verrebbe da pensare a un’unica categoria di persone, ovvero quelle disposte a rinunciare ai rischi che possono derivare dall’esercizio della propria facoltà di giudizio, o che ritengono che tale rischio nel loro caso sia minimo. Penso ai docenti universitari che non mirano a ottenere posti, posizioni o incarichi all’interno dell’industria culturale, penso in generale a tutti coloro che non devono render conto a nessuno di ciò che scrivono, perché non devono legare le proprie sorti agli umori di chi leggerà il proprio scritto, o perché non devono intrattenere relazioni che potrebbero esser danneggiate da una recensione. Finché queste persone avranno voglia di scrivere, finché ci sarà qualcuno che vorrà osare, e finché ci saranno spazî disposti ad accogliere coloro che vogliono scrivere (la nostra rivista è tra questi), ci sarà ancora posto per le recensioni e più in generale per la critica. Non si salveranno forse le sorti della critica, ma quanto meno le si consentirà di sopravvivere.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. È giornalista iscritto all’Ordine dal 2017, specializzato in arte e storia dell’arte. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte, iscritta al registro della stampa del Tribunale di Massa dal giugno 2017. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Ha esperienza come docente per la formazione professionale continua dell’Ordine e ha partecipato come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).