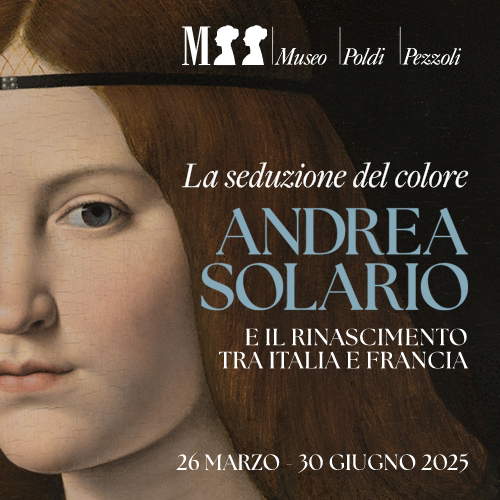Firenze, l'opera di Thomas J. Price? Un banale rimasticamento: l'argomento interessante è un altro
A Firenze in piazza della Signoria da circa cinque secoli, ogni giorno dell’anno, una donna vestita è in procinto di tagliare la testa di un uomo, inerte e addormentato ai suoi piedi, di cui tiene la testa per i capelli. Se un movimento femminista avesse voluto scegliere un’immagine di protesta più efficace contro il patriarcato, non avrebbe saputo fare di meglio della Giuditta di Donatello che sta per decapitare il generale Oloferne.
Poco più là un giovane nudo ha appena decapitato una donna, la cui testa solleva in alto come un trofeo: il Perseo di Cellini con la testa di Medusa. Questa immagine sanguinaria sarebbe dunque una rappresentazione di femminicidio, mentre il poco distante Ratto delle Sabine di Giambologna una violenza di genere? E se poi, per reazione isterica, qualche nostalgico del patriarcato volesse interpretare il Perseo di Cellini come un atto di rivalsa del maschio verso la violenza della donna, quasi a vendicare Oloferne ucciso da Giuditta, di distorsione in distorsione uscirebbe fuori un vero e proprio mostro ermeneutico.
Si discute in questi giorni nella stessa piazza, davanti alle stesse statue, il caso di un’ennesima scultura in cui alla questione del gender si unisce quella più attuale della razza, ovvero la statua di una ragazza di colore assorta a guardare il suo telefonino, alta circa quattro metri, in bronzo dorato, opera dello scultore britannico Thomas J. Price. La vexata questio è: si può affermare che sia brutta una scultura del genere senza essere accusati di razzismo e sessismo? E dal momento che anche l’artista è di colore, si corre il rischio di discriminare pure l’autore?
Così come non avrebbe senso affermare, come è stato scritto recentemente su una rivista, che sia una scultura di cui sarebbe “evidente la qualità del lavoro, della plastica e dell’oggetto” (questa evidenza rivelata su cosa si fonderebbe, sul giudizio di chi si autolegittima “critica d’arte”?), allo stesso modo non avrebbe senso dire che sia brutta. È una scultura di una donna nera che riprende schemi già utilizzati in passato (in Italia ad esempio da scultori non particolarmente amati dalla critica mainstream come Ugo Attardi negli anni Settanta e Giuseppe Bergomi in tempi più recenti) e che proviene nel suo stile iperrealista dalle donne nere di Duan Hanson negli anni Sessanta, intente in attività giornaliere, con la differenza che mentre queste ultime erano a grandezza naturale, quelle di Price sono monumentali.
Quindi potremmo dire che l’opera di Price sia un rimasticamento, poco originale in fondo, di quanto già fatto da altri artisti, aggiungendo che sculture pubbliche di donne nere in bronzo tra l’altro ne esistono già altre sparse per il mondo, come The Bronze Woman di Aleix Barbat del 2008 presso gli Stockwell Gardens di Londra o quella dedicata a Mary Jane Seacole a Londra dal 2016 presso il St. Thomas Hospital, a cui farebbe da precedente storico quella di donna di colore (simbolo dell’Africa) collocata dal 1863 a Londra sul monumento del memoriale della Grande Esposizione del 1851. La grande scultura di Price non sarebbe perciò neanche la prima scultura di donna nera ad essere collocata in una piazza pubblica: basta forse il fatto che sia soltanto la prima donna nera collocata in piazza della Signoria per ritenerla “rivoluzionaria”, visto che la statua in sé ricalca modelli accademici, veristi, realisti socialisti e usurati? Può essere rivoluzionario un linguaggio così antiquato?

Il gesto di due poveri idioti che hanno appeso delle banane al collo della statua di Price (gesto idiota tanto quanto quello di attaccare al muro con nastro adesivo una banana, esporla, metterla all’asta e comprarla per 6 milioni di dollari) rischia di distrarci dal porre le domande giuste. Ad esempio: era necessario collocare una scultura tanto normalizzante in sé nello stile, nella banalità del soggetto, nella mancanza di tensione formale, proprio nella piazza che ospita capolavori della statuaria che hanno fatto la storia della scultura (difficile ipotizzare che la ragazza di Price rimarrà nella stessa storia)? C’è dietro queste scelte una commissione di direttori di musei, filosofi, storici e critici dell’arte che seleziona le opere in base a determinati parametri e visioni culturali condivise, attenzionando il fatto, per un luogo pubblico così sensibile, che tra 2015 e 2025 su 6 sculture contemporanee installate ben 4 provenissero da artisti collegati alla Galleria Gagosian (quella di Price essendo la non meno prestigiosa galleria Hauser & Wirth)?
Non sarà che i gesti dei soliti idioti, con la complicità di critici in buona fede (ma, come si dice, la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni) ci costringono a parlare sempre di cose sbagliate per motivi sbagliati facendoci perdere di vista ciò di cui dovremmo seriamente discutere? Ad esempio che si può contestare una scultura poco originale dal punto di vista storico artistico senza offendere ciò che rappresenta bensì solo il suo essere un’opera d’arte fuori luogo in mezzo a capolavori del Rinascimento e che esiste una differenza tra significante e significato, forma e contenuto, segno e referente. Appendere banane al collo di una statua che raffigura una ragazza nera (gesto idiota) non ha lo stesso valore semantico che avrebbe se gli idioti lo avessero fatto su una ragazza in carne ed ossa (gesto razzista).
Torniamo allora alla nostra Giuditta: si riesce a fare qualcosa di più innovativo, violento, moderno, antiretorico, rivoluzionario? Questa è la sfida per l’arte contemporanea, non chiamare in causa, per difendere l’opera di Price, come un disco rotto, decolonizzazione e diritti civili, senza magari aver mai letto Booker T. Washington, Frederick Douglass, Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois, James Baldwin, Frantz Fanon, Léopold Senghor, Aimé Cesaire, Malcolm X, Huey Newton, Eldridge Cleaver, Angela Davis? E scoprire, anche attraverso i loro scritti, che non può essere la statua prodotta da un artista (nero o bianco poco importa a questo punto), il quale lavora per una delle più potenti gallerie d’arte dell’occidente, in una città dedita interamente al turismo internazionale (entrambi espressione del consumismo contemporaneo), a poter rappresentare e risolvere questioni di sfruttamento e dominio “coloniale” (o comunque lo si voglia chiamare). Parafrasando Malcolm X, esistono sculture “da cortile” e sculture “da campagna”: le prime sono al servizio del potere economico e complici dello sfruttamento coloniale, le seconde vorrebbero abbatterlo: la ragazza di Price non sembra affatto una scultura “da campagna”.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Marco Tonelli
Marco Tonelli (Roma, 1971), critico e storico dell’arte. Dopo la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università La Sapienza di Roma (1996), ha conseguito il diploma di Specializzazione in Archeologia e Storia dell’arte (2000) e un Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte (2003) presso l’Università degli Studi di Siena. È stato assessore alla Cultura del Comune di Mantova, caporedattore della rivista Terzo Occhio e commissario inviti della XIV Quadriennale di Roma. Dal 2015 al 2017 è stato direttore artistico della Fondazione Museo Montelupo Fiorentino per cui ha ideato la rassegna Materia Prima e ha curato il progetto annuale Scultura in Piazza a Mantova. Dal 2019 al 2023 è stato Direttore artistico di Palazzo Collicola e della Galleria d’Arte Moderna di Spoleto. Attualmente è Curatore scientitico della Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi. Insegna all'Accademia di Belle Arti di Venezia.