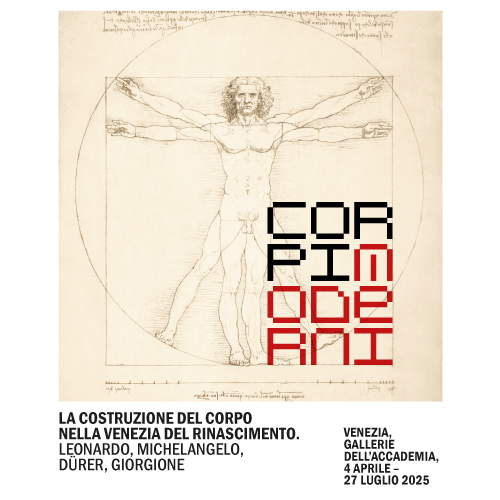Anastilosi di tre colonne del Tempio G di Selinunte: tanto marketing, poca archeologia
È fatta. Questa volta. Era dagli anni Settanta che se ne parlava. La ricostruzione del tempio G di Selinunte, il più grande della Sicilia (109 metri di lunghezza e i 50 di larghezza), e uno dei più grandi del Mediterraneo antico, si concretizza nell’anastilosi di tre delle colonne del lato meridionale, alte sedici metri, tra quelle meglio conservate del cimitero di rovine che da secoli accarezzano la nuda terra dell’antica Selinus. L’edificio non era stato del tutto rifinito prima che probabilmente un violento sisma lo facesse rovinare al suolo. Dopo svariati annunci negli anni, a far la differenza adesso è una questione di cassa. Al di là, infatti, delle ragioni conservative con cui si intende nobilitare un progetto che ha solleticato i vari corsi politici più per il miraggio del turismo in massa che sarebbe in grado di richiamare, l’ok a procedere arriva dritto dritto dai 5 milioni che il Governo uscente, su proposta dell’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, ha impegnato in calcio d’angolo (l’ok definitivo al finanziamento da parte della Ragioneria Generale è arrivato la scorsa estate) per l’operazione. Toccherà (a meno di ripensamenti) al nuovo Governo guidato da Renato Schifani pubblicare entro fine anno la gara per dare il via al grande cantiere.
Il progetto si deve all’archeologo Oscar Mei, docente di Archeologia classica presso l’Università di Urbino, dal 2010 impegnato in campagne di scavo nel parco archeologico siciliano, all’archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, il primo a suggerire molti anni fa un progetto di ricomposizione, e a Claudio Parisi Presicce, soprintendente capitolino dei Beni culturali, membro della missione Malophoros a Selinunte.
“Un progetto che attirerà l’attenzione del mondo su Selinunte, con inevitabili ricadute sul numero di visitatori che in futuro vorranno scoprire il parco archeologico”, ha detto Samonà, in linea con i predecessori. Sorprende di più, però, che tra i difensori delle ragioni di marketing ci sia stato anche lo sfortunato Assessore Sebastiano Tusa, che si era espresso in questi termini: “Non siamo più al tempo degli intervalli della vecchia TV in B/N con le pecorelle che passeggiavano romanticamente sulle rovine! Dobbiamo tenere conto della sensibilità non solo di noi addetti ai lavori, ma anche della molteplicità della gente che oggi visita i siti archeologici”. Ecco, magari dagli addetti ai lavori ci si attenderebbe anche l’“educazione” dei visitatori, piuttosto che vederli impegnati ad assecondare “una cultura di moda del turismo rozzo, spettacolare, diseducativo”, come ebbe a dire Ranuccio Bianchi Bandinelli a proposito dell’anastilosi del tempio E nella stessa Selinunte.

Quando Sgarbi prometteva l’“ottava meraviglia del mondo”
E sembra quasi che risponda a queste accuse lontane nel tempo Mei quando avverte: “Non puntiamo sulla spettacolarità, qui non si tratta di una ricostruzione del tempio, bensì di una grande operazione scientifica di ricerca e di tutela”. Mentre evidente è la polemica con il progetto faraonico con cui nel 2018 Vittorio Sgarbi voleva riergere nella sua interezza il colossale monumento: “ottava meraviglia del mondo”, prometteva l’allora allora assessore in Sicilia. Eppure, introducendo altre considerazioni il proposito appare meno sregolato di quello odierno. “È del poeta il fin della meraviglia […] Chi non sa stupir vada alla striglia”. In due versi Giambattista Marino teorizzava la poetica della meraviglia. Ora, è vero che l’archeologo non è un poeta, figurarsi se lo può essere un politico, un assessore, ma tra le ragioni della “grande operazione scientifica di ricerca” si potrebbe riconoscere anche il recupero di uno dei fini originari con cui fu edificato il monumento antico: rendere evidente con muscoli di pietra la potenza e ricchezza della gloriosa colonia greca.
L’arte dello stupore, inteso appunto come meraviglia, attraversa i secoli, dalle sette meraviglie del mondo antico, attraverso le Wunderkammern (stanze delle meraviglie, appunto) sorte in epoca medievale e sviluppatisi nel Cinquecento, i “trionfi” barocchi. Stupire, commuovere, affascinare, anche a costo di esagerare, come furono disposti a fare poeti, musicisti e architetti nel Seicento.
Tutto questo per dire che se togliamo il recupero del “fine originario della meraviglia” (valutabile nel caso specifico di questo tempio), quello conservativo appare non interamente sostenibile: che senso ha, infatti, “salvare” solo tre colonne e non sottrarre alla terra e agli agenti atmosferici l’intero patrimonio di resti? È lo stesso Mei a far notare come “un intervento conservativo si è dimostrato in questi anni fondamentale”, perché “gli elementi architettonici, fatti per stare in piedi, a terra si stanno sbriciolando”. Alcuni sì e altri no? E anche se si tratta di quelli di cui sono stati individuati con certezza gli elementi strutturali, il discorso non cambia. Per il professore, poi, “sarebbe un modo per rendere il monumento più leggibile per i visitatori”. Ora, se è vero che spesso i resti archeologici non sono di immediata comprensione per il vasto pubblico, è difficile ritenere che nell’immaginario collettivo, persino in quello dei bambini, un tempio non venga identificato con le sue colonne e che a tutti sia possibile “ricomporle” con una ricostruzione mentale. In altre parole, che sia necessario rimettere su tre colonne per rendere comprensibile una tipologia architettonica stranota appare, francamente, una forzatura. O più poeticamente con il padre della Teoria del restauro, Cesare Brandi: “niente occorreva di più, anche per un profano, per fantasticarlo quale fosse - giacque ruina immensa - quando era in piedi”.
Esperienza più rara per qualsiasi visitatore resta, invece, quella di trovarsi davanti alle macerie di un tempio, invece che a una ricostruzione, per la quale basta spostarsi anche solo di pochi passi. E non è un bel vedere: il Tempio E è il mostro di Frankenstein in cemento armato datato anni Cinquanta.
Semmai, si potrebbe obiettare, per restare in quella categoria del meraviglioso, che anche quel cumulo di rovine in un paesaggio archeologico storicizzato siano parimenti in grado di “stupire, commuovere, affascinare”. Lo diceva già con parole definitive, di nuovo, Brandi: “Per chi sa lo spettacolo immane e al di là di ogni paragone rappresentato dai cumuli ciclopici dei templi di Selinunte non ci vuol molto a riconoscere che nessuna ricostruzione al mondo potrà mai equivalere a quella che fantomaticamente risorgeva nella mente di ognuno da rovine cosi leggibili, cosi chiare, nei blocchi enormi, nei capitelli grandi come cupole”.

La comunità scientifica si è già espressa in passato contrariamente
Sulla dubbia valenza scientifica dell’operazione si espressero anche altre autorevoli voci. Giuseppe Voza chiese: “lasciateci vedere, magari pulito, ben mantenuto e assistito, il gigantesco ammasso delle membra abbattute del tempio G che da secoli domina il magico paesaggio archeologico di Selinunte”. Salvatore Settis, quando l’idea era stata rispolverata nel 2011 dal Governatore Raffaele Lombardo insieme allo stesso Valerio Massimo Manfredi, l’aveva bollata come “opera di regime fuori fase storica”.
Restano valide pure per l’impatto dell’anastilosi delle tre colonne del tempio G sul paesaggio storicizzato le parole spese da Ranuccio Bianchi Bandinelli in occasione della ricostruzione del Tempio E, bollata come “un risultato deplorevole. Deplorevole da vari punti di vista. Si è alterato un paesaggio ormai classico, sul quale sono state scritte pagine di alta poesia, un paesaggio che aveva ormai un suo valore culturale così come esso era; e questa distruzione di un valore culturale (evidentemente non sentito o ignoto a chi ha voluto il ripristino) avrebbe potuto essere giustificato, tutt’al più, da un preciso interesse scientifico archeologico, in modo che la perdita di un valore culturale fosse compensata dalla acquisizione di un altro”.
Se permangono forti dubbi sulle ragioni teoriche e conservative, anche sul fronte della ricerca le riserve non mancano. “Si parte comunque dallo studio, cominciando con indagini archivistiche, bibliografiche e iconografiche sul tempio. Contemporaneamente si andrà avanti con i rilievi fotogrammetrici e quelli fatti con il laser scanner 3d, si mapperanno i materiali con cui fu costruito”, ecc., recita l’Ansa. “Si parte”, ma sarebbe meglio dire si prosegue: studi e rilievi erano iniziati, infatti, ben dodici anni fa, nel 2010, sotto la direzione di Mario Luni dell’Università di Urbino, di cui Mei è allievo. Gli esiti di quelle ricerche furono presentate l’anno dopo proprio in un convegno a Selinunte, al Baglio Florio, dedicato al tema dei restauri dell’antico. Senza che fosse stato spostato dalla sua originaria posizione di crollo alcun elemento architettonico, era stato possibile realizzare una vera e propria “carta archeologica” della situazione esistente, nuove planimetrie e sezioni dell’edificio, elementi di analisi di dettaglio confluiti nell’ipotesi di ricostruzione proposta con il modellino in scala presentato a conclusione del convegno. Peraltro, in quell’occasione Tusa, allora Soprintendente del Mare, lungi dai pomposi propositi di qualche anno dopo, si era espresso a favore della necessità di “procedere con tempestività alla sua (del tempio, ndc,) protezione”.

Ma in tempi di crisi economica era proprio necessario investire 5 milioni di denaro pubblico?
Ma se la querelle resta aperta c’è più realisticamente da chiedersi se in tempi di grave crisi economica e con un patrimonio diffuso sofferente in attesa di interventi non più procrastinabili, fosse il momento opportuno per investire 5 milioni di fondi pubblici. Sgarbi pensava a delle sponsorizzazioni, senza gravare sul bilancio pubblico. Aveva reso nota una stima dei costi e tra i preventivi che aveva tra le mani, oltre a quello da 15 milioni di euro per rimettere su l’intero tempio, ce ne era un altro proprio da 5 milioni. Che si tratti dello stesso rispolverato adesso?
Ad ogni modo i conti non tornano. E trattandosi di fondi pubblici sarebbe meglio che tornassero. Entrando nel dettaglio del preventivo da 15 milioni, accreditato dalla sua provenienza istituzionale (la Soprintendenza del Mare), questi conti Sgarbi li faceva: “ognuna delle colonne del tempio costerà 180 mila euro e considerando che l’edificio ne possedeva 50, il costo dell’imponente colonnato dorico si aggira attorno ai 9 milioni di euro. A questo si deve aggiungere il resto dell’edificio”. Non si capisce, dunque, perché si debbano pagare adesso 5 milioni di euro tre colonne che a 180 mila l’una sarebbero costate in tutto la cifra enormemente inferiore di 540 mila euro. Tra rovine, anastilosi, paesaggio archeologico ruderale, sembra che la faccenda inizi a prendere una piega decisamente più prosaica.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Silvia Mazza
Storica dell’arte e giornalista, scrive su “Il Giornale dell’Arte”, “Il Giornale dell’Architettura” e “The Art Newspaper”. Le sue inchieste sono state citate dal “Corriere della Sera” e dal compianto Folco Quilici nel suo ultimo libro Tutt'attorno la Sicilia: Un'avventura di mare (Utet, Torino 2017). Come opinionista specializzata interviene spesso sulla stampa siciliana (“Gazzetta del Sud”, “Il Giornale di Sicilia”, “La Sicilia”, etc.). Dal 2006 al 2012 è stata corrispondente per il quotidiano “America Oggi” (New Jersey), titolare della rubrica di “Arte e Cultura” del magazine domenicale “Oggi 7”. Con un diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna, ha una formazione specifica nel campo della conservazione del patrimonio culturale (Carta del Rischio).