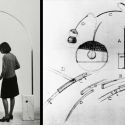Da Nicola Pisano a Michelangelo in un solo monumento. L'Arca di San Domenico a Bologna
Quando, nella Basilica di San Domenico a Bologna, si entra nella cappella dedicata al santo spagnolo e si osserva l’Arca di San Domenico, il monumento che custodisce i suoi resti, si è subito catturati dall’imponenza del monumento, si rimane affascinati per la sua finezza, per le sue forme singolari, per la verve narrativa delle scene del sarcofago, ci si sorprende a conoscere la sua storia, che ci racconta di un’opera la cui realizzazione andò avanti per secoli. Quando però l’Arca di San Domenico fu concepita, era anche una delle opere più innovative di quel momento storico. Era il 1264 quando i domenicani di Bologna decisero di erigere una sontuosa arca che potesse accogliere degnamente le spoglie di san Domenico di Guzmán, morto a Bologna poco più di quarant’anni prima, il 6 agosto del 1221. La decisione, peraltro, come ha spiegato la studiosa Anita Fiderer Moskowitz autrice di uno dei più recenti e densi contributi sull’Arca, fu presa in palese violazione delle regole introdotte nel 1261 dallo stesso Ordine dei predicatori domenicani, quando generale dell’Ordine era Umberto di Romans, e recepite negli statuti due anni più tardi. Questa legge prevedeva che “nec fiant in domibus nostris superfluitates et curiositates notabiles in sculpturis et picturis et pavimentis et aliis similibus quae paupertatem nostram deformant” (“non ci saranno nelle nostre case notevoli superfluità e curiosità nelle sculture, nelle pitture, nei pavimenti e in altre opere simili che deturpino la nostra povertà”). Probabilmente l’idea fu di fare un’eccezione per il fondatore dell’ordine, anche tenuto conto del fatto che un monumento sontuoso a lui dedicato, oltre a onorarlo in maniera confacente, avrebbe potuto meglio promuovere il suo culto, e quindi giovare all’ordine.
Il problema dei domenicani bolognesi stava però nel fatto che in città non c’erano scultori capaci di dar forma a ciò che avevano in mente: i frati dovettero dunque allargare la ricerca alla Toscana, e qui trovarono l’artista adatto alle loro esigenze. Il pugliese Nicola Pisano (1220 circa - 1278/1287) aveva da poco terminato il pulpito del Battistero di Pisa, probabilmente qualcuno dei domenicani bolognesi lo aveva visto, e la scelta cadde su di lui. Non ci sono documenti antichi che forniscano prove sulla committenza (anche se la prima menzione dell’Arca risale al 1265): tuttavia, poiché da Vasari in avanti l’Arca di San Domenico è sempre stata associata a Nicola Pisano, e poiché gli studiosi sono concordi sull’assegnare a lui la paternità del monumento, si è sempre ritenuto che i lavori siano cominciati nella bottega di Pisa. Ad ogni modo, per il 1267 la tomba era già completata (anche se, come si vedrà, la sua storia non era di certo conclusa), e con una cerimonia solenne, il 5 giugno di quell’anno, i resti del santo vi furono traslati: si sa peraltro che un assistente di Nicola Pisano, fra’ Guglielmo (Pisa, 1235 circa - 1312), architetto, scultore e membro dell’ordine domenicano, era presente a Bologna durante la cerimonia (si narra poi che durante la cerimonia, il frate pisano riuscì a impossessarsi di una costola di san Domenico per portarla nella sua città, e che avrebbe confessato il furto solo in punto di morte). Ad ogni modo, Nicola Pisano firmò, nel 1265, un nuovo contratto, quello per il pulpito di Siena, dove si trasferì l’anno successivo: per il 1266 quindi il grosso del lavoro sull’Arca di San Domenico doveva già essere a un ottimo stato di avanzamento.


Dell’Arca che vediamo oggi, la parte da assegnare a Nicola Pisano e ai suoi aiuti (lavorarono assieme a lui, oltre al già citato fra’ Guglielmo, anche Arnolfo di Cambio e due allievi, tali Lapo e Donato, menzionati da Vasari ma non noti da altre fonti) è il sarcofago, scolpito su tutti i lati. È questa l’unica parte originale del monumento che oggi vediamo in San Domenico. Il sarcofago è poggiato sopra uno zoccolo di marmo verde ed è chiuso nella parte alta da una cornice modellata con un motivo di foglie di acanto e uccelli, reminiscenti dei sarcofagi dell’antichità classica. La narrazione si svolge lungo tutti i quattro lati della cassa: le scene sono separate da quattro figure ad alto rilievo, quelle di sant’Agostino, sant’Ambrogio, san Girolamo e san Gregorio, ovvero i quattro dottori della Chiesa che sono posti ai quattro angoli (anche se la loro identificazione non è unanime), mentre altre due figure ad alto rilievo, la Madonna col Bambino e il Cristo redentore, sono poste al centro dei lati lunghi, a spartire ulteriormente la narrazione. Cominciando la lettura dal lato lungo con le due scene separate dalla Vergine col Bambino, vediamo a sinistra il Miracolo della resurrezione di Napoleone Orsini caduto da cavallo e, a destra, la Prova del fuoco. Nella prima si parla di un miracolo di san Domenico, che resuscitò il giovane Napoleone Orsini, morto a seguito di una caduta da cavallo, durante un viaggio verso Roma, mentre nella seconda dà conto di un episodio avvenuto prima del 1216 nella Linguadoca, quando san Domenico e gli eretici albigesi gettarono i rispettivi libri nel fuoco per convincere le autorità locali della verità della loro parola: i libri degli eretici bruciarono, mentre per miracolo quelli di san Domenico rimasero sospesi sopra il fuoco. Sui lati corti si vedono le scene con I santi Pietro e Paolo che consegnano la missione all’Ordine domenicano (si narra infatti che i due padri della Chiesa, apparsi in visione a san Domenico, gli consegnarono una Bibbia e un bastone) e con il Miracolo dei pani, quest’ultimo avvenuto a Bologna nel 1218, quando san Domenico, a cena con i suoi fratelli, in mancanza di alimenti si mise a pregare e gli apparvero due angeli che gli diedero pane e fichi. Infine, sull’altro lato lungo, si osservano la scena dell’Approvazione della regola di san Domenico da parte di papa Innocenzo III, fatto risalente al 1216 investito anch’esso di un alone miracoloso (sembra infatti che Innocenzo III dapprima respinse la regola, e ci ripensò dopo aver visto in sogno san Domenico sorreggere la chiesa di San Giovanni in Laterano), e l’Adesione di Reginaldo di Orleans all’Ordine, che narra della malattia del teologo Reginaldo di Orleans che, guarito da san Domenico, decise di entrare tra i predicatori. Tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che in antico il sarcofago dovesse poggiare su cariatidi, anche se il numero delle figure che reggevano la tomba di san Domenico è sempre stato oggetto di discussione: forse sei o otto, e ad ogni modo tre di esse oggi si conservano presso altrettanti musei (una è al Museo del Bargello, una al Museum of Fine Arts di Boston e una al Louvre).
Una delle particolarità di queste scene consiste nel fatto che Nicola Pisano le immaginò sulla base dei racconti di testimoni oculari che erano ancora vivi nel momento in cui l’artista pugliese dovette immaginare l’impianto dell’Arca di San Domenico. La vera origine delle raffigurazioni, tuttavia, è oggetto di discussione. Tutti gli altri episodi trovano invece riscontro nella biografia di san Domenico scritta da Umberto di Romans tra il 1256 e il 1260. Secondo Moskowitz, invece, almeno un paio di miracoli, quello di Napoleone Orsini e quello dei pani, tradurrebbero in immagini il racconto di una testimone oculare, una suora chiamata Cecilia Contarini, giovanissima quando san Domenico era in vita, che sarebbe stata consultata dai domenicani bolognesi. È interessante notare che in questa scena si vede una donna anziana che rivolge lo sguardo non verso la scena miracolosa, ma in direzione opposta: per la studiosa la donna potrebbe essere proprio Cecilia Contarini, raffigurata mentre guarda in direzione contraria rispetto a tutti gli altri per sottolineare il suo ruolo di testimone degli eventi. Non la pensa allo stesso modo Serena Romano, che ritiene erroneo il tentativo di far derivare il racconto dalla testimonianza della suora, per il fatto che nel 1264-1265 non aveva ancora reso le sue memorie, e per il fatto che queste ultime furono in ogni caso ignorate dai leader dell’Ordine domenicano, né mai entrarono a far parte dell’agiografia ufficiale, nonostante alcuni episodi riportati dalla suora compaiano tuttavia nelle Legendae Sancti Dominici: Cecilia Contarini era stata infatti ritenuta testimone poco attendibile (secondo Romano è anche molto improbabile che l’anziana raffigurata nell’angolo della scena con il miracolo della caduta da cavallo sia un ritratto della suora: sarebbe stato un espediente “fortemente innovativo”, ma difficile da provare).
Si tratta ad ogni modo di miracoli avvenuti quando il santo era ancora in vita: evidentemente per precisa scelta dei committenti si preferì non includere miracoli che Domenico di Guzmán avrebbe compiuto da morto. È stato infatti riscontrato che il programma iconografico del sarcofago venne concepito quasi come una traduzione visiva dei metodi adoperati da san Domenico durante la sua predicazione: dottrina, esempi pratici, e miracoli. Come avrebbe spiegato Jacopo da Varazze, la dottrina aveva effetto sulle persone non istruite, per le quali erano sufficienti gli insegnamenti, gli esempi si indirizzavano invece a chi, una volta esposta la dottrina, rimaneva indifferente e dunque aveva bisogno di vedere i risultati dell’applicazione di tali teorie per farsi convertire, e infine i miracoli erano destinati al pubblico più ostinato e difficile da convincere. Occorre poi immaginare l’Arca sistemata in un punto diverso della basilica rispetto a quello attuale: si trovava con tutta probabilità in posizione centrale, vicino al tramezzo che separava lo spazio riservato ai frati da quello dei laici, con il lato più spettacolare, quello con le scene dei due miracoli separate dalla statua della Madonna, rivolto verso questi ultimi, dal momento che le scene di Napoleone Orsini e degli albigesi sono scolpite in maniera meno complessa rispetto alle altre così che possano essere ben osservate anche a distanza. La prima collocazione dell’arca doveva dunque rispondere a evidenti necessità propagandistiche.
Si è detto in apertura che l’Arca di San Domenico aveva caratteri totalmente innovativi per l’epoca in cui fu realizzata. Questi caratteri sono stati ben sottolineati nel volume di Moskowitz: per esempio, era inedita l’idea di rappresentare più scene in un unico rilievo. E poi, sebbene Nicola Pisano avesse preso a modello i sarcofagi romani per il suo pulpito di Pisa, era del tutto nuova l’idea di integrare tale modello in una tomba moderna. “L’inclusione di un sarcofago istoriato”, ha scritto Moskowitz, “colloca l’Arca di San Domenico entro due tradizioni: la prima, quella dell’impiego di sarcofagi antichi per le tombe dei santi, una pratica che cominciò nell’VIII secolo con la traslazione su larga scala di reliquie di martiri dalle catacombe alle basiliche romane; e la seconda, quella preferita da molti papi, soprattutto nel XII secolo, ovvero quella di scegliere, come loro futuro sepolcro, qualcosa di simile ai sarcofagi pagani, magari in porfido oppure decorato con simboli e temi trionfali”. Moskowitz ha poi notato delle deliberate continuità tra l’Arca di San Domenico e i sepolcri degli antichi sovrani, che come l’arca bolognese erano immaginati per essere visti da tutti i quattro lati, e non addossati a una parete: una suggestione, unita ai rilievi all’antica, che potrebbe aver indotto il pubblico del tempo a fare paragoni con le tombe degli antichi sovrani, per concludere che l’Arca, “seppur non basata esplicitamente sugli antichi sepolcri imperiali, veniva vista come una sorta di rivale degli ideali che questi ultimi rappresentavano”. I miracoli di san Domenico e l’eternità della parola di Dio contro, in sostanza, la gloria effimera del potere terreno. Potevano però darsi anche problemi più eminentemente pratici: quando san Domenico morì, le sue spoglie furono poste entro una semplice cassa di cipresso nella chiesa di San Niccolò delle Vigne. A seguito della sua canonizzazione nel 1234 da parte di Gregorio IX, i resti del santo furono tumulati in un sarcofago di marmo sistemato in una delle cappelle laterali della basilica di San Domenico da poco conclusa (i lavori terminarono nel 1228). Evidentemente si era posta la necessità di dare maggiore visibilità e, come detto in apertura, una più degna sepoltura al fondatore dell’ordine, che specialmente dopo la canonizzazione attirava un numero sempre più consistente di pellegrini a Bologna.




Ad ogni modo, nel XV secolo, i domenicani, evidentemente spinti dal confronto con altri monumenti che erano stati innalzati dopo la metà del Trecento, come l’Arca di San Pietro Martire o l’Arca di Sant’Agostino, dovettero progettare di rinnovare in maniera radicale il monumento per adattarlo alle nuove esigenze. Il primo passaggio fu dunque quello di elevare notevolmente in altezza il monumento: il Governatore Protonotario Apostolico e il Reggimento del Comune di Bologna commissionarono la cimasa, curiosamente, a un altro grande scultore pugliese, “magistrum Nicolaum de Pulia”, ovvero Niccolò dell’Arca (Niccolò da Bari; 1435 circa - Bologna, 1494), la cui fama fu associata all’impresa di San Domenico al punto che l’artista ricevette il soprannome proprio a quest’opera. Niccolò fu impegnato nell’esecuzione della cimasa tra il 1469 (all’Archivio di Stato di Bologna si conserva una trascrizione del contratto, datato 20 luglio di quell’anno, e contenente il programma iconografico che l’artista doveva seguire) e il 1473, due anni in più rispetto a quanto previsto dal contratto: sopra al sarcofago dispose una elegante copertura a scaglie, sormontata da un fregio con cherubini che regge due eleganti volute decorate con elementi vegetali che si uniscono in alto a formare un pinnacolo a fianco del quale si notano due putti che reggono festoni di frutta e fiori, sotto ai quali, lungo le due volute, si notano due delfini. Tutta la cimasa è decorata con statue: in alto, svetta sul pinnacolo il globo con la figura del Padreterno che a sua volta in mano regge la sfera che simboleggia il suo dominio sul mondo. Alludono invece al tema della creazione gli elementi lungo le volute: i festoni sono simbolo della terra, i putti del cielo e i delfini dell’acqua. Più in basso, notiamo un piccolo sarcofago dal quale spunta la figura del Cristo morto tra due angeli, mentre sui lati si vedono le figure dei quattro evangelisti, letti tuttavia anche come quattro profeti per via del loro singolare abbigliamento orientaleggiante. La rappresentazione è chiusa da otto statue che si dispongono lungo i lati della cimasa. Sono i santi protettori di Bologna: Francesco, Petronio, Domenico e Floriano sulla parte anteriore, e Agricola, Giovanni Battista, Procolo e Vitale su quella posteriore (Niccolò dell’Arca ne completò cinque su otto: il Giovanni Battista fu eseguito nel Cinquecento inoltrato da Girolamo Cortellini, mentre i rimanenti due, Petronio e Procolo, come si vedrà più sotto, sono invece opera di un giovanissimo Michelangelo).
Osservando le figure scolpite da Niccolò dell’Arca e dai suoi collaboratori si assiste, ha scritto Eugenio Riccomini, “a un progressivo evolversi del suo linguaggio. L’Eterno al culmine del coronamento, e soprattutto i quattro Profeti inturbantati alla turchesca e avvolti nel ricco e più volte replicato panneggio dei manti hanno sapore sfarzosamente borgognone e ancora ricordano le imponenti figure di Sluter o della pittura fiamminga, mentre le figure che paiono più recenti hanno la fierezza spavalda del gusto rinascimentale; la stessa, insomma, che ostentano i personaggi laici nei dipinti coevi del Cossa. E un paio di esse sembrano proprio ritratti contemporanei". Pare infatti che le figure dei santi Vitale e Agricola raffigurino lo stesso Niccolò dell’Arca “vestito alla brava, in stivali alti, con la chioma scomposta e il cipiglio scontroso da uomo ‘fantasticus et barbarus’ (così lagnandosi del suo carattere lo chiama un frate di san Domenico)”, e il signore di Bologna, Giovanni Bentivoglio, “in abito azzimato rivestito all’interno di pelliccia e con la mano sul pomo della spada”. Accanto a queste suggestioni, sono stati poi indicati, ha scritto Grazia Agostini, “precisi legami con la Tomba Marsuppini di Desiderio da Settignano in Santa Croce, databile intorno al 1455”, benché secondo Cesare Gnudi l’insieme sia “ancora legato al gusto tardo-gotico”.
La realizzazione della cimasa da parte di Niccolò dell’Arca fu, peraltro, il frutto di una collaborazione tra il Comune e i domenicani. A questi ultimi spettò la scelta dell’artista, mentre la città finanziò il progetto con una tassa apposita e formò una commissione che doveva supervisionare l’andamento dei lavori. Questo perché nel Quattrocento l’Arca di San Domenico non era più importante solo per i domenicani, ma per la città tutta, avendo assunto i contorni di un monumento civico a tutti gli effetti. Di conseguenza, la “densità formale e programmatica del nuovo progetto”, ha spiegato in un suo saggio lo studioso Randi Klebanoff, “può essere vista come deliberata e pregna di significato. Nel XV secolo, l’attenzione sul corpo del santo in quanto portatore di messaggi prevalentemente domenicani fu incorporata in uno schema che rifletteva il variegato corpo civico, e modellò una visione utopistica della città come un cosmo sacro”. Secondo Klebanoff, la complessità dell’Arca offre un paradigma composito: vi si apprezza un’arte rivolta al pubblico dei fedeli, dei pellegrini, degli adoratori di reliquie, ma anche un “sistema di visualizzazione di magnificenza e ostentazione tipico della cultura civica rinascimentale”. Ed effettivamente il programma iconografico della cimasa veicola contenuti molto più universali rispetto a quelli del sarcofago, entro i quali s’innestano anche messaggi rivolti alla città, rappresentata dai suoi santi patroni. Bologna, secondo Klebanoff, viene qui rappresentata come una città investita del favore del Padreterno, il tutto in un periodo storico in cui il pontefice, Paolo II, tentava di riaffermare la giurisdizione papale sulla città, incontrando però la strenua opposizione di Giovanni II Bentivoglio, del quale il papa temeva la considerevole forza militare. Una missione diplomatica nel 1465 stabilì che il papa avrebbe continuato a riconoscere l’autorità bentivogliesca sulla città, in cambio di un tributo annuale di dodicimila ducati: in questo senso, il programma iconografico dell’arca, ha scritto Klebanoff, è indicativo del fatto che “il vicario di Dio poteva anche domandare un tributo, ma Dio stesso aveva ritenuto opportuno dotare la città di un tesoro inestimabile”, ovvero il possesso delle reliquie di san Domenico, assurte a simbolo del favore della divinità.

















Come detto, la cimasa fu messa in opera nel 1473, ma Niccolò dell’Arca non aveva completato il lavoro: di ventuno statue previste, ne furono consegnate soltanto sedici. Mancavano tre dei santi protettori, uno degli angeli reggicandelabro alla base dell’Arca, e la figura del Cristo risorto. Il Cristo non fu mai realizzato, il san Giovanni Battista, come anticipato, fu eseguito da Girolamo Cortellini nel 1539, mentre le statue rimanenti, il san Procolo, il san Petronio (che era stato già sbozzato da Niccolò dell’Arca) e l’angelo di destra si devono alla mano del giovane Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564) che le scolpì tra il 1494 e il 1495. L’artista fiorentino, neanche ventenne, ottenne l’incarico grazie alla mediazione di un nobile bolognese, Giovanni Francesco Aldrovandi, che lo aveva accolto dopo che l’artista aveva abbandonato Firenze a seguito della cacciata dei Medici, suoi protettori, proprio nel 1494. Con l’Angelo reggicandelabro l’artista approdò a un “logico e organicissimo approfondimento”, come ha scritto Enzo Carli, dei motivi studiati nella Madonna della Scala, sua opera giovanile: l’artista sviluppa infatti il suo senso plastico scolpendo un angelo dalle forme possenti, inscritto entro uno schema cubico, avvolto da un panneggio ben più ampio e articolato rispetto a quello dell’angelo di Niccolò dell’Arca, coi suoi “profondi addentri” che sottolineano la forza della struttura architettonica della scultura, e a tutto ciò occorre aggiungere una “espressione di una interna energia, raffrenata e quindi resa più drammatica dalla disciplina architettonica del cubo cui la figura è costretta”.
La stessa energia si avverte nella figura di San Petronio, animata da un dinamismo evidente nella posa delle gambe, che suggeriscono un personaggio nell’atto di muoversi in avanti in maniera solenne e compassata. Una forza che si ritrova pari anche nel San Procolo che, seppur restaurata nel Cinquecento da Prospero Sogari Spani a causa della caduta di una trave che l’aveva danneggiata, ancora comunica la fierezza e l’eroismo del santo, un ufficiale romano originario di Bologna che aveva subito il martirio durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l’imperatore Diocleziano. Una tensione e una monumentalità che anticipano il Michelangelo più maturo, come quello del David (si osservi per esempio il gesto della mano del san Procolo, che richiama quello del capolavoro oggi alla Galleria dell’Accademia di Firenze).
Infine, un altro dei grandi scultori della Bologna rinascimentale avrebbe in seguito partecipato all’impresa: si tratta di Alfonso Lombardi (Ferrara, 1497 circa - Bologna, 1537), che nel 1532 si occupò, dietro commissione del consiglio della città, della stele, lo scabellum marmoreum, che sorregge il sarcofago, scolpita sui quattro lati con l’Adorazione dei Magi e con quattro scene della vita di san Domenico: la nascita, una scena in cui è raffigurato da fanciullo mentre dorme per terra (fin da bambino aveva infatti rifiutato di dormire sul letto per sottoporsi a disciplina), l’episodio della vendita dei libri per ricavare denaro con cui sfamare i poveri (“non voglio studiare su libri di pelle mentre delle persone muoiono di fame”, avrebbe detto), e la visione di fra’ Guala con san Domenico assiso tra Cristo e la Madonna. L’ultima immagine, quella della morte e del seppellimento del santo scolpita sull’altare, fu invece realizzata nel 1768 dal francese Jean-Baptiste Boudard. Risale invece al XVII secolo la costruzione dell’attuale cappella di San Domenico e lo spostamento dell’Arca nel luogo ove tutti oggi la possono ammirare.
Un’opera realizzata dunque in cinque fasi principali (Nicola Pisano, Niccolò dell’Arca, Michelangelo, Alfonso Lombardi, Jean-Baptiste Boudard), con aggiunte e modifiche che si sono succedute lungo i secoli, e che rendono l’Arca di San Domenico una sorta di compendio di cinque secoli di scultura a Bologna, con esempi paradigmatici degli sviluppi della scultura italiana tutta. Entro un unico monumento, che ne avrebbe ispirati poi a sua volta diversi altri (come le già citate arche di San Pietro Martire e di Sant’Agostino, che probabilmente suggerirono l’idea di aggiornare il monumento, ma che inevitabilmente non poterono non guardare al loro omologo felsineo), e che per tali ragioni non ha altri pari.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE
Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta
Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo