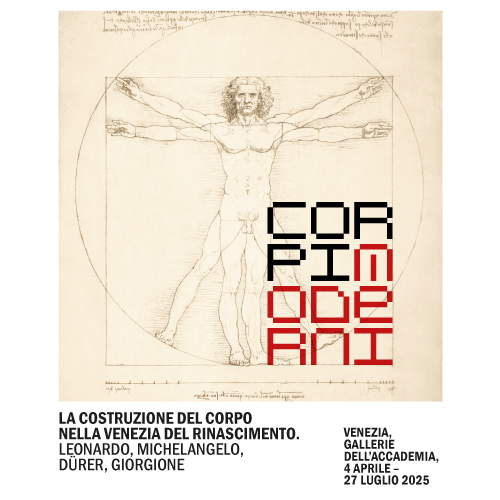Il mistero della pieve di Montesorbo in Romagna
Distante dal frastuono stradale, con i suoi 441 metri sopra il livello del mare, isolata a metà percorso tra i borghi di Sarsina e Ciola, nella Romagna interna, insiste sul cammino di San Vicinio una piccola ma preziosa chiesetta dall’età misteriosa. Si tratta della pieve di Montesorbo, adagiata all’ombra di lunghi cipressi secolari, nella solitaria valle tra i fiumi Savio e Borello, nei pressi di Mercato Saraceno. Di mirabile fattura e d’impianto romanico, la pieve non svetta distraendo lo sguardo dal paesaggio ma gli si adatta (a esso) seguendo la linea sinuosa dell’orizzonte.
Riconosciuto come monumento nazionale per il suo valore storico e artistico, l’edificio chiesastico di Santa Maria Annunziata, è questa la sua denominazione, appare modesto e rurale grazie all’inganno ottico dei materiali semplici con cui è composto l’esterno, cioè il laterizio, l’arenaria e il gesso. Ad una vista più attenta invece, per una serie di elementi (il panorama in cui s’imbatte, la sua peculiare composizione, ogni dettaglio costruttivo, il tipo di reperti che si trovano all’interno, frammenti e spolia custoditi, e finanche la presenza di una Madonna con Bambino, ovvero, una tempera su tela di lino), la chiesetta dall’umile aspetto incredibilmente si tramuta in una costruzione di ricercata nobiltà.
Questa bellezza tuttavia resta avvolta nel mistero. È come se la pieve non volesse farsi conoscere mai del tutto, come se volesse restare sempre un poco impenetrabile. La tradizione di studi locali ha visto nella numerosa presenza di materiale architettonico e scultoreo antico la preesistenza sullo stesso sito di almeno un tempio romano, votato alla dea Cerere. L’ipotesi è sì affascinante ma per ora non esiste alcun elemento capace di suffragarla seriamente, dal momento che, come vedremo, diverse sono le datazioni dei reperti e delle parti che la compongono.



Montesorbo è una realtà singolare, è il prototipo di altre pievi del territorio dove l’arte e la fede lungo la direttrice del pellegrinaggio di San Vicinio si sono convocate, compensate e amalgamate. Ma la sua singolarità è data anche da un’altra serie di fattori che riguardano le differenti fasi di stratificazione, i numerosi documenti, reperti, rovine, frammenti… e soprattutto datazioni contraddittorie che inducono gli studiosi ad “accapigliarsi” sulla verità delle sue origini.
La prima menzione della pieve, un documento del 1223 (giunto fino a noi in copia regestata, l’atto, datato 3 ottobre, riguarda la vendita di diversi beni, da parte di Cacciaguerra da Montepetra, al vescovo di Sarsina e a Berardo) la renderebbe compatibile con l’impianto evidentemente romanico dell’abside, ma quando, visitando l’interno a croce greca, notiamo i reperti e i frammenti presenti, la mensa paleocristiana dell’altare maggiore, le colonne (interrate sotto il pavimento per più di un metro), e i capitelli delle navate romane, gli splendidi rilievi di fattura e figurazione longobarde (assimilabili alle sculture di Cividale del Friuli), i resti di plutei altomedievali, una lastra con croce ed epigrafe d’arte carolingia, le quattro splendide arcate di ciborio altomedievale con figure di aquile, pavoni, mostri marini, la lastra del vescovo Florentius del secolo X, non possiamo non pensare a quanto complesso sia definire una volta per tutte l’età e la fattura della piccola chiesa.
Nonostante nella documentazione rinvenuta esista una pergamena ravennate datata 867 che, sebbene in modo alquanto indiretto, cita il pievato di Montesorbo. Occorre però, per la prima vera attestazione della pieve, attendere il 948. A rendere più complessa la sua “decifrazione” concorrono quindi diversi fattori.
Anche se una ricostruzione attendibile delle sue fasi architettoniche risulta piuttosto problematica da realizzarsi, al contrario, una lettura dei numerosi e importanti reperti custoditi al suo interno porterebbe a formulare un’ipotesi che vede, tanto per iniziare, nella chiesetta un originario edificio paleocristiano sorgere intorno al VI-VII secolo, probabilmente per ragioni devozionali legate a san Vicinio. La memoria storica di san Vicinio che la tradizione manterrà viva a lungo può davvero motivare il laborioso trasferimento del materiale romano di reimpiego e la persistenza del ricco arredo artistico.




Una seconda fase, tra l’VIII e il IX secolo, vedrebbe l’arricchimento dell’arredo liturgico con il ciborio, i cui frammenti sono di chiara matrice longobarda. Al X secolo potrebbe risalire il cantiere voluto dal vescovo Florentius, attestato dai resti della sua lastra tombale. A cavallo dei secoli XII-XIII si colloca l’intervento romanico, forse concentrato sulla sola abside. Nel 1442 viene edificato l’attuale ciborio riutilizzando le colonnette del precedente, rovinato forse per una serie di terremoti incorsi. È in questo momento, cioè, dopo la costruzione del baldacchino, che molto probabilmente viene collocata la Madonna che adora il Bambino.
Diventata presto oggetto di culto, la piccola tempera (60 x 40 centimetri), restaurata nel 1961, è stata attribuita a più mani: Antonio Corbara la colloca nella cultura urbinate, Andrea Emiliani a Bartolomeo di Maestro Gentile da Urbino, Pietro Zampetti a un pittore umbro e, infine, Bonita Cleri la attribuisce a un anonimo quattrocentesco dal linguaggio “adriatico”.
Spicca in questo piccolo monumento, oltre alla tempera devozionale con la Vergine, anche un frammento, collocato nel lapidario della navata destra, davvero raro che mostra allineati e in bassorilievo una mano, un volto e una croce. Anche su questo punto non si è mai raggiunto un giudizio unanime da parte degli studiosi ma l’ipotesi più convincente è quella che lo vorrebbe come un predecessore dei nostri cartelli stradali, e pertanto avrebbe indicato ai pellegrini un luogo di preghiera e di ristoro.
Oltre alla piacevolezza dell’esperienza, la sosta qui, lungo i luoghi dell’entroterra romagnolo, impone pertanto una riflessione. Sicuramente la pieve non sarebbe soltanto da annoverare, e in maniera asfittica, tra gli importanti monumenti religiosi della zona, da passare in rassegna come una delle varie tappe turistiche della Romagna collinare, dovrebbe pretendere invece che uno studio più approfondito e trasversale spinga ad altre più responsabili avventure di studio scientifico e in altri azzardi interpretativi almeno su temi come la sua origine e la sua ricchezza di reperti. Al contrario, rischia di restare ancora chiusa nei suoi misteri, e in questo caso ha il diritto di reclamare quel religioso rispetto dei suoi segreti che, forse, in definitiva, non vuole proprio rivelare…
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE