Se la Biennale di Venezia diventa un fotosafari tra gli outsider. I limiti della mostra di Pedrosa
Cinquant’anni esatti son trascorsi da quando un “Comitato d’iniziativa per la pittura naïf alla Biennale di Venezia” scriveva a Carlo Ripa di Meana, ch’era stato appena nominato presidente della Biennale da poco riformata, un’accalorata lettera per domandare all’istituzione il pieno riconoscimento del movimento naïf, da sancire magari con la presenza in mostra d’un salone dedicato a quegli ‘ingenui’ ch’erano da anni ostracizzati dalla più parte della critica, esclusi dai circoli blasonati, spesso financo derisi, ma ch’erano tuttavia in grado d’imperversare sul mercato, incarnando con solare vividezza l’assunto per cui la storia dell’arte e la storia del gusto spesso circolano su strade distanti. Era la primavera del 1974: “Siamo sicuri”, scriveva il comitato indirizzandosi a Ripa di Meana e al consiglio direttivo, “che a nessuno di voi sarà sfuggita l’importanza del fenomeno storico della ‘nuova immaginazione’: la crescita di un movimento, definito dell’art naïf, che è quantitativamente e qualitativamente un fatto nuovo nello sviluppo della sensibilità di masse sempre più vaste, le cosiddette energie emergenti del nostro tempo. Non siamo più di fronte a vampate di immaginazione extra-accademica o primitiva o popolaresca […]. Abbiamo a che fare con un movimento che non si arresterà più e che crescerà, anche nelle difficili condizioni attuali della cultura dei popoli e nel complicato rapporto con le arti e la sensibilizzazione estetica delle masse. È in grazia di questa precisa e ferma coscienza che vi chiediamo di riconoscere concretamente alla nuova pittura naïf quello statuto culturale pieno, quella dignità professionale, quel rispetto artistico che le è dovuto, contro ogni concezione elitaria o subalterna della cultura”. I firmatarî di quella lettera non potevano immaginare che proprio durante un anniversario tondo, nel 2024, schiere di artisti folk e brut da tutto il pianeta sarebbero stati finalmente esposti alla mostra più importante del mondo e quell’agognata ammissione istituzionale dell’arte “emarginata” sarebbe infine arrivata, sebbene il curatore della sessantesima edizione della Biennale, Adriano Pedrosa, fatichi a immaginarla come un riconoscimento, e preferisca pensare, seppur un poco implicitamente, che l’ipertrofica convocazione d’artisti indigeni, queer, outsider alla sua Biennale sia casomai la pacifica conseguenza d’una sorta di corso naturale della storia dell’arte.
In un certo senso, Pedrosa ha ragione nel momento in cui, durante la sua intervista a Julieta González pubblicata nel catalogo, afferma che per un visitatore europeo o statunitense è piuttosto facile riconoscere gli artisti contemporanei di quello che lui chiama il “Sud del mondo”, poiché “a partire dalla fine degli anni Novanta e dall’inizio degli anni Duemila, gli artisti contemporanei della nostra parte del mondo hanno acquisito una maggiore visibilità: se non tutti, almeno alcuni di loro viaggiano ed espongono in musei, gallerie e biennali”. In Italia forse lo avvertiamo di meno dacché i nostri musei d’arte contemporanea seguono il più delle volte altri orientamenti, ma è sufficiente visitare le fiere principali per aver contezza delle tonnellate d’arte africana, asiatica, latinoamericana proposte da tanti galleristi che, inevitabilmente, intercettano un gusto e un interesse che da almeno un ventennio, e con crescente costanza, eccitano gli appetiti dei collezionisti di mezzo mondo, e in questo senso gli italiani non fanno eccezione. Stranieri ovunque – Foreigners everywhere, la mostra internazionale della Biennale 2024, non disvela pertanto alcuna novità sostanziale degna di nota (addirittura i saggi che compongono il catalogo, tolto il solo contributo inedito di Claire Fontaine, costituiscono una collettanea di articoli pubblicati tra il 1998 e il 2023): va semmai letta, da un lato, come un momento di consacrazione ufficiale per artisti da anni presenti sul mercato, anche con quotazioni decisamente elevate, e dall’altro come strumento d’amplificazione di discussioni intavolate già da tempo, come mezzo che consegna ai visitatori della Biennale artisti che altri istituti, negli anni addietro, hanno portato all’attenzione del pubblico europeo e statunitense. All’Arsenale, il percorso s’apre con Claire Fontaine e Yinka Shonibare, artisti ben noti ai frequentatori dell’arte contemporanea, rappresentati da due gallerie di spicco (rispettivamente la parigina Mennour e la newyorkese Goodman), ma il discorso potrebbe essere esteso a una parte decisamente consistente, forse addirittura maggioritaria, degli artisti viventi in mostra, ben presenti su di un mercato dominato dal cash bianco ed eurocentrico, siano essi autodidatti o artisti popolari, o al contrario artisti forti d’un percorso tradizionale, formale, accademico: giungono in successione Frieda Toranzo Jaeger (rappresentata dalla Galleria Barbara Weiss), Emmi Whitehorse (Garth Greenan), Greta Schödl (Labs Gallery), Julia Isídrez (Gomide&Co), Dana Awartani (Lisson), e via dicendo. Persino l’aborigena Naminapu Maymuru-White, “grande anziana yolnu” come ce la presentano le didascalie in mostra, ha affidato la cura dei suoi interessi a una delle gallerie leader dell’intero comparto Asia-Pacifico (l’australiana Sullivan+Strumpf, che è tra gli habitué di Art Basel).
Lo stesso assunto vale, naturalmente, per la sezione allestita al Padiglione Centrale dei Giardini, dove si trovano, tra gli altri, Louis Fratino, ovvero uno degli artisti attualmente più pompati dal mercato (inserito in un curioso e bizzarro dialogo con Filippo de Pisis, sulla base della comune omosessualità, almeno a leggere dalle didascalie), oppure la nativa Kay Walkingstick che aveva un solo show con la sua galleria all’ultima edizione di Art Basel Miami, o ancora l’indigeno Aycoobo che ha vinto un premio alla Biennale di Toronto del 2022, mentre gran parte degli artisti non viventi (che costituiscono la maggioranza dei nomi di questa Biennale) sono stati comunque già esposti in mostre di rilievo, dal MoMA di New York alla Tate di Londra passando per molti dei grandi musei internazionali d’arte contemporanea. E se c’immaginiamo un Pedrosa che vaga per la foresta amazzonica alla ricerca delle opere degli sciamani Yanomami onde rivelare al pubblico europeo immagini mai viste prima alle nostre latitudini, rimarremmo delusi: le opere di André Taniki e Joseca Mokahesi girano da almeno una ventina d’anni per i musei del nostro continente, con la Fondation Cartier a fare da apripista nel 2003 con la mostra Yanomami. L’esprit de la forêt. Insomma, dove sono questi esclusi, questi emarginati dal sistema?




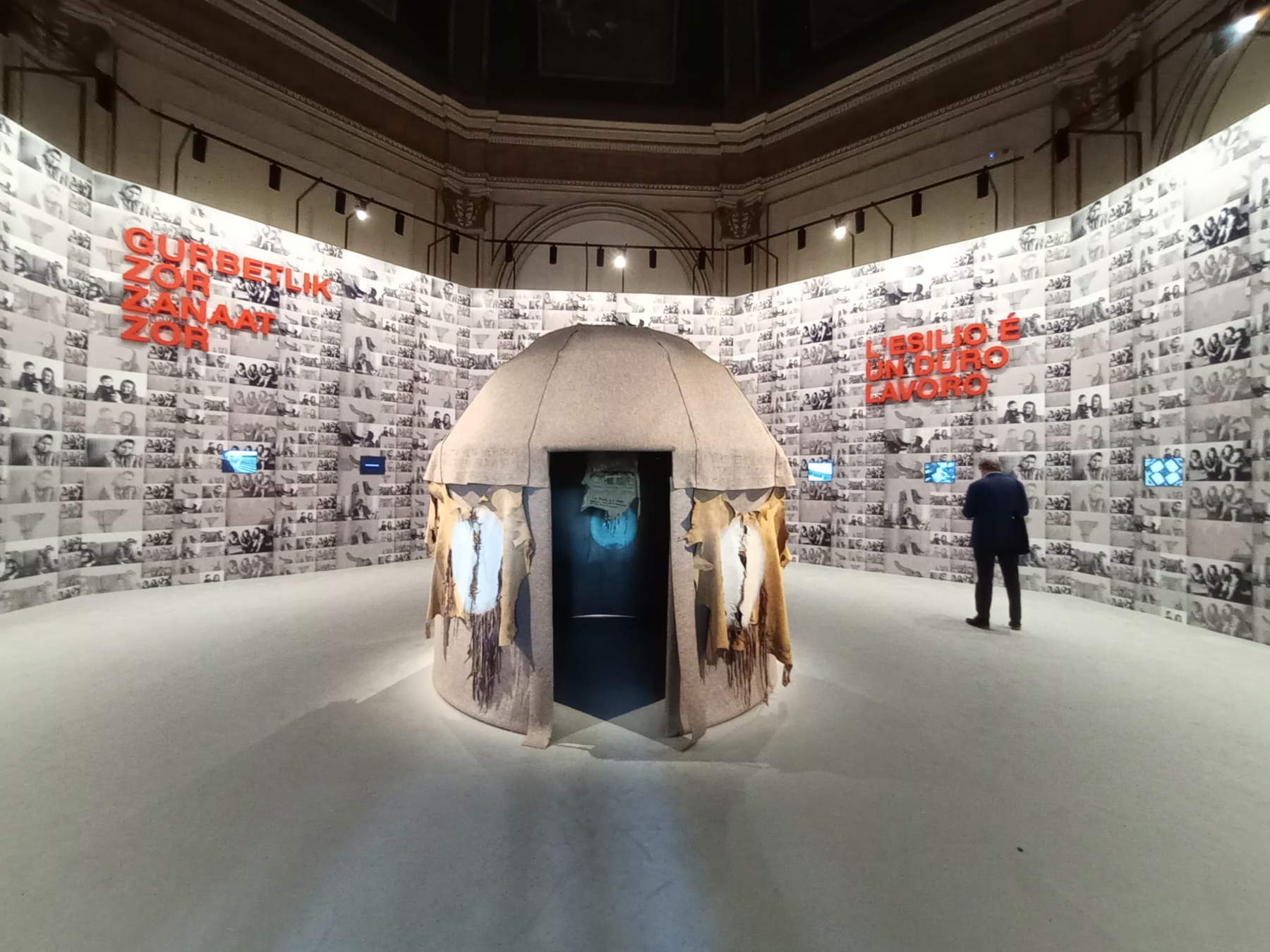

La prima conseguenza è dunque una sorta di colonialismo di ritorno che avvolgeva già l’atmosfera della passata edizione della mostra internazionale, Il latte dei sogni di Cecilia Alemani, e che però diventa tema ineludibile in un’edizione, quella attuale, che intende porre il tema della decolonizzazione al centro dell’attenzione. L’unico a non sottrarsi all’argomento è Ticio Escobar nel suo saggio pubblicato nel catalogo, laddove sottolinea che gli artisti “popolari” hanno “il diritto di utilizzare tutti i canali e le istituzioni (con cui la cultura dominante interrompe e interferisce) e di usarli come rifugi, trincee o addirittura come piste per potenziali voli”, così che “da questo punto di vista non si può criticare la decisione di ricorrere al mercato e di lottare per ottenere prezzi più equi e un maggiore riconoscimento della creatività popolare”. Osservazione più che corretta, ma che apre una serie di questioni d’importanza non secondaria: può dirsi veramente “escluso” un artista che viene messo sotto contratto da una delle più potenti gallerie del mondo e che porta le sue opere nei contesti più istituzionali dell’universo dell’arte contemporanea? Fino a che punto può allora reggere la narrativa su cui questa Biennale è stata impostata? Fino a che grado possiamo considerare inconsapevole l’arte d’uno sciamano che ha passato gli ultimi anni a viaggiare tra Parigi, Londra, Shanghai? Non si corre il rischio d’imbrigliare questa creatività popolare ottenendo un effetto del tutto contrario a quello che s’auspicava? Lo sciamano ha ovviamente tutto il diritto di ricorrere ai marketplace europei e nordamericani per ottenere un riconoscimento economico, culturale, sociale (anzi, il sogno di tanti outsider è proprio il riconoscimento ufficiale), e però allo stesso tempo anche il pubblico ha tutto il diritto d’interrogarsi sugli effetti dell’operazione, di farsi qualche domanda sulla spontaneità d’un artista che da anni si misura col mercato occidentale, sul suo reale grado d’esclusione, sul vero motivo della sua presenza: è qui perché siamo davvero interessati a ciò che ha da dire e magari anche alle condizioni della sua comunità, oppure è qui perché ce lo esibiscono come curiosity di cui poi ci dimenticheremo quando saremo stanchi d’ammirare la sapienza artigiana delle sue mani che mai toccarono moderni strumenti occidentali? Già all’epoca dell’esplosione dei naïf Giancarlo Marmori, in un suo memorabile articolo, osservava che “un naïf, una volta scoperto, non può ignorare a lungo di esserlo”, e che “oggi un naïf ha scarse possibilità di vita clandestina, autentica e serena”: valeva alla metà degli anni Settanta, quando Marmori scriveva il suo pezzo sull’Espresso, vale a maggior ragione oggi, nel mondo post-globalizzazione, nell’era di internet e dei social, e con il pubblico dell’art world abituato a viaggiare, una settimana a Venezia, quella dopo a New York, quella dopo ancora a Seul.
Certo, diversi degli artisti o dei progetti scelti da Pedrosa per la sua mostra (che, a differenza dell’edizione trascorsa della mostra internazionale, si distingue per una maggior chiarezza, per gli allestimenti più puliti, per una più immediata freschezza) sono in grado di sorprendere il pubblico, soprattutto se non li si conosceva: si rimane allora sinceramente impressionati dinnanzi alla potenza visionaria di Santiago Yahuarcani, pittore autodidatta della nazione Uitoto, che con le sue opere ambientate tra foreste intricate, spiriti guardiani e animali della sua Amazzonia, richiama alla mente i giudizî universali delle nostre chiese del Due e del Trecento. Ci s’appassiona alle storie dei guidatori dei mototaxi nigeriani raccontate in uno schietto video di Karimah Ashadu. Sono toccanti i tessuti della turca Günes Terkol che con le sue stoffe, trasfigurando l’attualità in un racconto che pare quasi privo d’una reale dimensione temporale, dà vita a polifonie di voci femminili con le quali s’entra subito in sintonia. Le ordinatissime fotografie dell’angolano Kiluanji Kia Henda riescono a comunicare con efficacia e poesia cosa sia il privilegio, cosa sia il divario sociale. Ci si lascia catturare per qualche istante dallo scintillio delle sculture in ceramica dorata di Victor Fotso Nyie, giovane camerunense che da tempo vive e lavora a Faenza. Si può esser contenti del riconoscimento che quest’edizione della Biennale ha accordato a Nedda Guidi, rilevante ceramista a lungo marginalizzata, e tuttavia inserita in mostra non tanto per il suo ruolo pionieristico nel percorso di nobilitazione della ceramica che ha attraversato l’arte del secondo Novecento, quanto piuttosto perché “donna queer, femminista convinta”. Ancora, si ha modo di saggiare l’acutezza di progetti come il Disobedience Archive di Marco Scotini o il Museum of the Old Colony di Pablo Delano. Tolti questi e pochi altri acuti, per la Biennale di Pedrosa vale lo stesso commento che Jonathan Jones, il noto critico del Guardian, aveva scritto otto anni fa per la mostra dell’artista indiano Bhupen Khakhar (presente in questa edizione della Biennale) che s’era tenuta alla Tate di Londra: “perché la Tate Modern espone un artista antiquato e di second’ordine, la cui arte ricorda il tipo di pittori britannici che non lascerebbe mai entrare dalle sue porte?”.










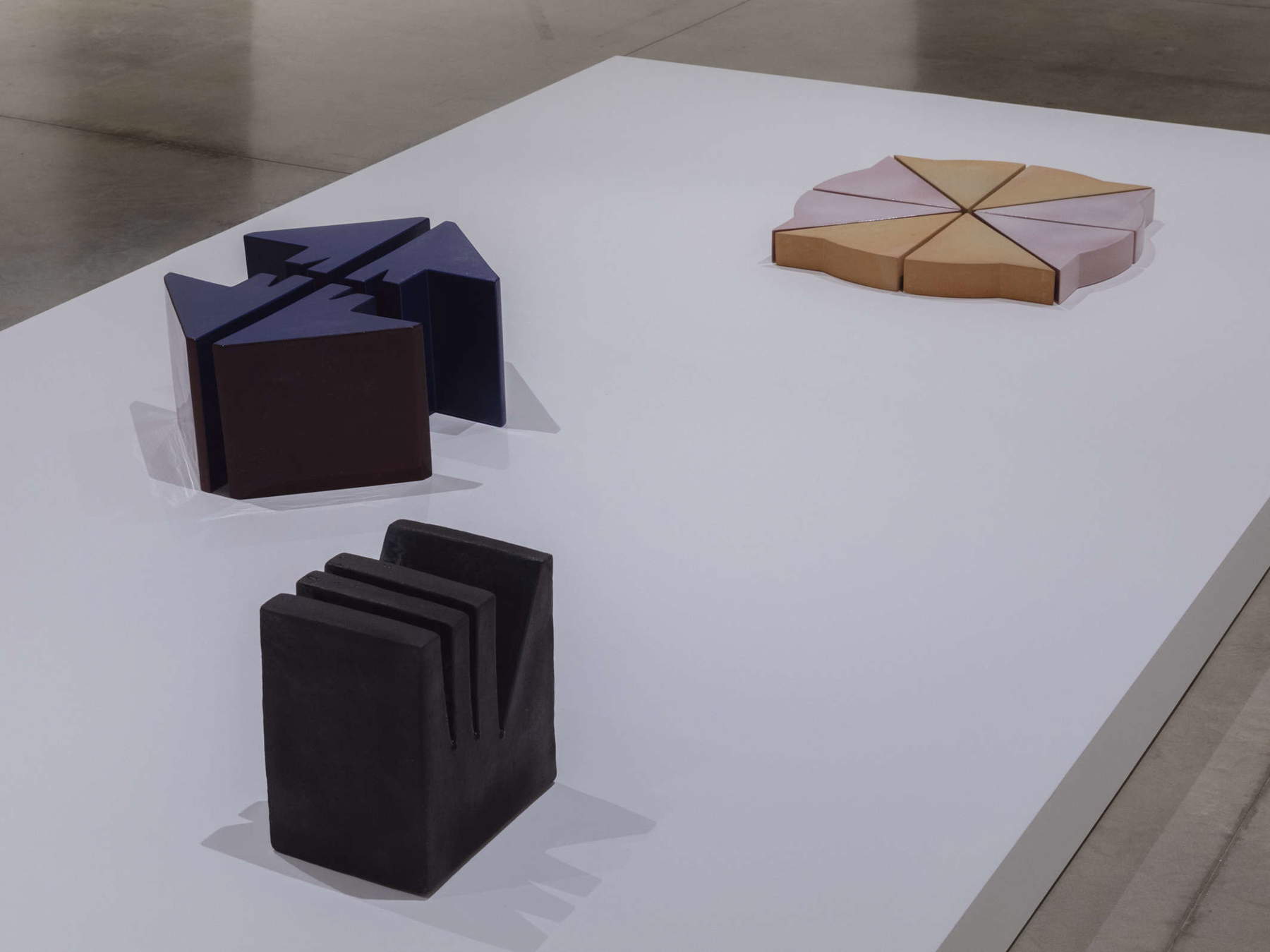

Si potrebbe rivolgere la stessa domanda ad Adriano Pedrosa, data la gran quantità di arte outsider, folk e naïf della sua Biennale: quale differenza separa un artista autodidatta nato e cresciuto nella foresta amazzonica da, mettiamo, uno dei tanti pittori contadini dell’Emilia del dopoguerra che non erano mai entrati in un museo o non avevano mai preso in mano un libro di storia dell’arte? Cos’hanno di diverso un’indigena diné e un pastore dell’Appennino che, citando Soffici, non ha mai visto i baffi d’un professore? Quali caratteristiche hanno i nostri Ghizzardi, i nostri Zinelli, i nostri Bolognesi che non s’adattino a quella definizione di outsider come “artista che si trova ai margini del mondo dell’arte proprio come l’autodidatta, l’artista folk o artista popular” resa da Pedrosa nel catalogo della sua mostra? Che disdetta, per il Comitato di cinquant’anni fa: emarginati in Biennale sì, ma soltanto se esotici. L’unica giustificazione dell’esclusione degli outsider europei o nordamericani (il solo presente in mostra, non si comprende perché, è l’austriaco Leopold Strobl), al di là del fatto che un italiano, un francese o uno spagnolo finirebbero per annacquare il nostro mea culpa per i secoli di colonialismo cui abbiamo sottoposto il resto del mondo, è probabilmente il peso specifico che l’arte irregolare, l’arte popolare, l’arte folk rivestono nell’economia dell’arte degli altri continenti.
Partendo da questo presupposto, tocca allora domandarsi se sia questo il modo più serio e più corretto per includere anche la Biennale di Venezia nei processi di decolonizzazione culturale in corso. Ovvero: portare a Venezia un agglomerato monolitico di esclusi, indigeni e queer, tagliando fuori in maniera dogmatica tutto il resto tranne pochissime eccezioni, è davvero utile? Probabilmente no, per varie ragioni. Intanto, pur con tutte le ottime intenzioni che di sicuro animano la direzione artistica di questa Biennale, si finisce per alimentare, benché inconsapevolmente, una dinamica di scontro che non è neanche negli interessi degli esclusi che la mostra intende portare verso il centro (ricordando Errico Malatesta: “le masse oppresse […] non potranno emanciparsi se non mediante l’unione, la solidarietà con tutti gli oppressi, con tutti gli sfruttati del mondo tutto”). Una dinamica che, sperimentata su altri campi e ad altri livelli (ché, si sa, le arti visive ormai contano più poco o niente) comporta necessariamente, e lo si vede dalla realtà dei fatti, il rafforzamento degli afflati populistici, nazionalistici, reazionarî che non smettono di scuotere il “Nord del mondo”, per adoperare la terminologia cara al curatore di questa Biennale. Difficile del resto non intravedere una logica della contrapposizione quando s’intende la storia dell’arte non come un processo storico che ha sempre avuto e sempre avrà diramazioni regionali e locali, quanto piuttosto come una sorta di regolamento di conti col passato, come una rivincita, come un attacco a una regola. E poi, non è utile perché si cade nel rischio di trasformare la Biennale non in quello spaccato del mondo contemporaneo che dovrebbe essere, magari con qualche pretesa d’individuare una direzione futura, ma in una specie di mondo movie diviso per sale, in un compendio di folklore e di produzioni artigianali di quello che una volta avremmo chiamato “terzo mondo”, nel corrispettivo formato mostra di un fotosafari. Ne ha dato implicita conferma la nutrita farragine gauche caviar di casa nostra che già durante i giorni dell’anteprima si sdilinquiva per la mostra coloratissima in grado d’offrirci un compendio delle mille, meravigliose tecniche artigianali del Sud globale, e che non ha mancato di spruzzare su Instagram l’esito dei proprî estatici stupori. Non si rischia forse di scavare un ulteriore solco tra occidente e resto del mondo? Allestire a Venezia una vetrina in cui esporre una sequenza di batik, stoffe andine e disegni di sciamani separata da tutto il resto non espone questi artisti al pericolo di alimentare gli stereotipi sul loro conto? Oppure di rendere ancor più evidente quella marginalità che si vorrebbe annullare? L’atteggiamento che informa Stranieri ovunque – Foreigners Everywhere non rischia di essere tanto simile a quello degli etnologi che secoli addietro allestivano i loro gabinetti di curiosità? E poi, per inciso, non possiamo finalmente liberarci dell’idea per cui un artista fluido debba essere ancora percepito come “strano”?
I limiti della Biennale di Pedrosa emergono anche dai tre “Nuclei Storici”, tre piccole rassegne di storia dell’arte del Novecento, una più imbarazzante dell’altra, progettate con tutti i difetti del Nucleo Contemporaneo. Il primo Nucleo Storico che s’incontra (se si vuole cominciare il giro dall’Arsenale), Italiani ovunque, citiamo dal catalogo, “riunisce opere di artisti italiani che hanno viaggiato e vissuto all’estero, sviluppando la propria carriera in Africa, Asia e America Latina, nonché negli Stati Uniti e in Europa”, “immigrati italiani di prima e seconda generazione che sono a loro volta diventati stranieri nel Sud del mondo e oltre nel corso del XX secolo”. Non si comprendono bene i criterî della selezione, perché al di là di artisti che hanno davvero lasciato l’Italia per trasferirsi definitivamente altrove c’è anche chi, come Galileo Chini, in Thailandia è rimasto giusto il tempo per completare un lavoro che là gli era stato commissionato (curioso peraltro constatare come l’unica opera in situ di Chini, gli affreschi che ornano la cupola del Padiglione Centrale dei Giardini, sia stata lasciata al buio: manco il minimo sindacale verso uno degli artisti selezionati). Ma al di là delle ragioni della selezione, il Nucleo altro non è che una sorta di album di figurine che occupa tutta una sala, un informe nugolo d’artisti tra loro slegati, un’indistinta accozzaglia che raduna esperienze spesso profondamente diverse, e neppure il bell’allestimento (i cavalete de cristal, ovvero i display trasparenti ideati da Lina Bo Bardi nel 1968 per il MASP di San Paolo, il museo oggi diretto da Pedrosa) riesce a risollevare gli esiti d’una pessima esposizione.
Non va meglio con i due Nuclei Storici dei Giardini, quello dedicato all’astrazione e quello sul ritratto, entrambi animati dal proposito d’osservare le declinazioni dei movimenti del primo Novecento rese dagli artisti che operarono lontani dai continenti nei quali emersero le avanguardie. Anche in questo caso non c’è alcun tipo d’inquadramento storico che non sia il voler mostrare che, sulla scia di quanto s’andava producendo a inizio secolo nei centri propulsori dell’Europa e dell’America del Nord, nel resto del mondo c’era chi apportava il proprio contributo e sviluppava in ambito locale le suggestioni che provenivano da altri centri. È ciò ch’è sempre accaduto nella storia dell’arte: il Rinascimento nasce a Firenze, ma sono esistiti un Rinascimento lombardo, un Rinascimento urbinate, un Rinascimento ligure e via dicendo, ognuno col proprio temperamento e i proprî caratteri d’originalità. E però a nessuno storico dell’arte serio verrebbe in mente d’allestire una mostra dentro un’unica sala dove sparpagliare un Boltraffio, un fra’ Carnevale, un Ludovico Brea e via elencando senza fornire al visitatore una qualche coordinata per orientarsi, al di là di qualche nota biografica sugli artisti esposti. Perché questa è la situazione dinnanzi alla quale il visitatore si trova percorrendo i due Nuclei Storici dei Giardini: una poco comprensibile carrellata di artisti africani, latinoamericani e asiatici del primo Novecento, giustapposti senza criterio, senza guide (presenti solo brevi biografie), senza suddivisioni chiare, in una massa confusa dove manca qualunque distinzione tra contesti anche radicalmente diversi, dove gli artisti veramente originali, come Tarsila do Amaral oppure Candido Portinari nella sezione dei ritratti, affogano tra pittori di secondo e terz’ordine, col rischio che il visitatore finisca per perderseli. Anche i Nuclei Storici sono, dunque, un’occasione persa.




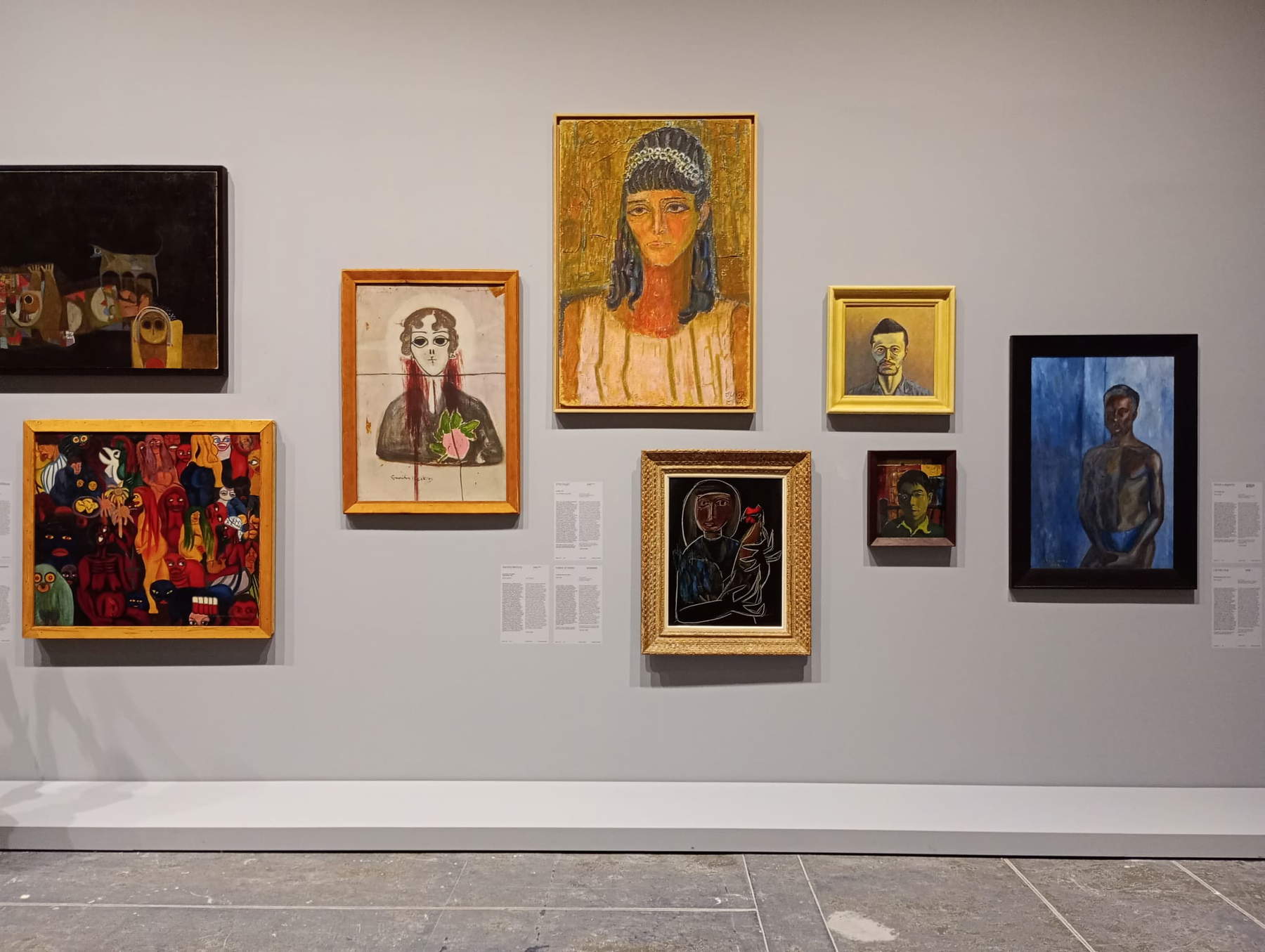
Può sembrare un paradosso, ma si respirava un’aria più fresca alla Biennale curata da Ralph Rugoff, che non ricorderemo forse tra le edizioni migliori della storia, ma è stata l’ultima in cui la direzione ha messo assieme artisti del “Nord” e del “Sud” senza ghettizzazioni e senza logiche da resa dei conti, mettendo sullo stesso piano tanto i prodotti artistici dell’Occidente quanto quelli del resto del globo, con il comune obiettivo d’offrire una visione del mondo e di provare a ipotizzare una rotta. Non è detto che poi l’ipotesi sul futuro sia corretta, non è detto che i tempi non smentiscano le idee di un curatore, ma almeno in passato s’offriva ai visitatori la possibilità di discutere su di un indirizzo. Adesso, per trovare a Venezia una proposta artistica visionaria, tocca andare fuori dalla Biennale e vedersi la potente mostra di Pierre Huyghe alla Punta della Dogana, perché Stranieri ovunque – Foreigners Everywhere è una mostra innocua, affabile, assiomatica, poco incisiva, tutt’al più riepilogativa.
Le ultime due Biennali si sono più preoccupate della necessità d’assecondare un gusto, si sono impegnate a cercare delle antitesi, si sono aggiunte a discussioni già avviate altrove e senza neppure aggiungere contributi particolarmente interessanti. Anzi, la Biennale 2024 ha probabilmente sancito una regressione, dal momento che la mostra internazionale di quest’anno impone un’idea di decolonizzazione che pare quasi prescindere da ogni forma di dialogo. Del resto è Pedrosa stesso che, nell’intervista a Julieta González, afferma che la ragion d’essere dei due Nuclei Storici dei Giardini è quella di “sfidare il canone occidentale”. E quella della decolonizzazione come sfida all’Occidente è peraltro un’idea che nell’illusione di risolvere un problema finisce per crearne altri: sul New York Times, Jason Farago ha correttamente fatto notare le saldature tra questo genere di narrativa e la retorica anticoloniale d’un Putin che cerca di promuovere la sua Russia come amica dei paesi africani, mentre al contempo tenta d’imporre all’Ucraina il proprio imperialismo fuori dalla storia. E allora non è davvero questa la decolonizzazione culturale di cui necessitiamo.
C’è però un’altra possibilità? Certo, e la si può trovare in qualcuno dei padiglioni nazionali (anche se non sono molti quelli in cui si vada al di là di una mera presentazione dell’escluso di casa propria): in quello della Francia, per esempio, dove Julien Creuzet indica, con un’opera totale intrisa di poesia, che il processo di decolonizzazione va immaginato come un momento di ripensamento non solo delle nostre strutture politiche, ma anche del nostro posizionamento nel mondo. Decolonizzazione, dunque, come ristrutturazione, più che come sfida o come resa dei conti. Altrimenti possiamo continuare a pensare d’aver fatto il nostro contentandoci d’aver visto qualche naïf esotico. Il Comitato di cinquant’anni fa probabilmente avrebbe esultato.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).



































