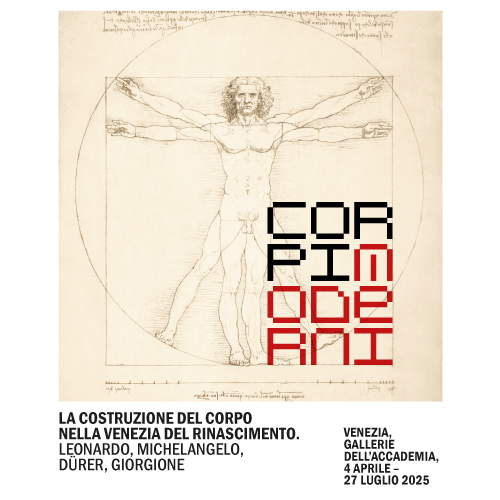Se la macchina è strumento di poesia. Com'è la mostra su Jean Tinguely a Milano
Jean Tinguely torna a Milano settant’anni dopo la prima volta e quarantaquattro dopo averla scelta per dichiarare morto il Nouveau Réalisme, nel decimo anniversario della fondazione, ovvero quella volta che tutti gli artisti del movimento si ritrovarono a Milano per prender parte a un funerale durato tre giorni, culminato nella notte del 28 novembre 1970, davanti al Duomo, davanti a ottomila persone radunate sulla piazza. Tinguely aveva pensato a una spettacolare performance, a un singolarissimo catafalco per celebrare la morte del movimento: un “monumento anarchico autodistruttivo”, una macchina che s’uccideva davanti a tutti, sopra un palco, in una delle piazze più belle e più famose del mondo. L’aveva chiamata La Vittoria, oppure Il suicidio della macchina, e per metterla in scena s’era reso necessario un mese di preparativi o, come avrebbe scritto lo stesso Tinguely, di “preparazione, costruzione, viaggi, discussioni, meccanizzazione, automobilizzazione, affollamento, complicazioni, disperazione-speranza, riflessione, concentrazione, saldature, parole, montaggio, rischi, speranza, decisione, confusione”. La macchina, un enorme monumento fallico alto più di dieci metri, era rimasta nascosta per tutto il giorno, celata da un drappo viola, ed era stata svelata solo verso le dieci di sera. Poi, dopo poco, cominciò a muoversi, per dare avvio alla propria autodistruzione nel fumo e nel fragore dei fuochi d’artificio che infuocavano il cielo di Milano, coprivano le voci, sorprendevano le ottomila persone presenti, testimoni dell’immane, fragorosissimo suicidio. Gli ultimi fuochi partivano verso le undici e venti, la macchina era distrutta, il grande fallo perdeva il suo potere, perdeva il suo dominio, e le ultime fiamme del monumento sarebbero state spente dai pompieri verso le due del mattino. Tinguely, successivamente, avrebbe ringraziato anche i piccioni di piazza del Duomo per aver volato mentre la Vittoria si autodistruggeva. Il Nouveau Réalisme, in realtà, era già fermo da diversi anni (l’ultima mostra collettiva del movimento era stata organizzata nel 1963), ma in quell’occasione, in quel decimo anniversario, gli artisti del gruppo avevano deciso di vedersi tutti a Milano per un ultimo, definitivo spettacolo conclusivo, una sorta di farewell tour con una tappa sola, dopodiché ognuno avrebbe continuato per conto proprio la sua carriera. Christo aveva impacchettato il monumento a Vittorio Emanuele in piazza del Duomo, Rotella s’era messo a strappare manifesti davanti a tutti, Niki de Saint-Phalle sparava, Dufrêne declamava, e via dicendo.
La Vittoria, momento apicale di quei tre giorni, segna anche il momento di chiusura della mostra che, quest’anno, l’Hangar Bicocca di Milano dedica a Jean Tinguely: è la prima retrospettiva che s’apre in Italia dopo la scomparsa dell’artista. L’ultima occasione per il pubblico italiano di conoscere Tinguely era stata nel 1987, prima a Venezia poi a Torino, mentre la prima s’era data nel 1954, a Milano. Settant’anni fa esatti: era stato Bruno Munari a invitare Tinguely a portare le sue prime macchine allo Studio d’Architettura B24, e Milano era stata pioniera, dacché l’artista svizzero prima d’allora aveva esposto le sue Méta-mécaniques soltanto una volta, quello stesso anno, alla Galerie Arnaud di Parigi. Per entrare nel mondo di Tinguely occorre dunque cominciare a visitare la mostra non dalle prime macchine che s’incontrano (il percorso non è organizzato in senso cronologico: l’allestimento è scenografico), ma da poco più avanti, da un gruppo di tre sculture (Sculpture méta-mécanique automobile, Méta-Herbin e Trycicle) che offrono al visitatore la possibilità di misurarsi con le prime ricerche di Tinguely. Da almeno un paio d’anni, l’artista, appena arrivato a Parigi, rovistava nelle periferie della città per cercare pezzi di ferro e di metallo che non servivano più a niente e a nessuno, e poi li portava nel suo studio, li montava e li dipingeva, e dava così forma alle sue prime Méta-mécaniques, come avrebbe consigliato di chiamarle Pontus Hultén, per suggerire una forma d’espressione che abbia con la meccanica la stessa analogia che la fisica ha con la metafisica, e cioè un qualcosa in grado d’andare oltre quello che ci si aspetterebbe da una macchina: le macchine, in altri termini, son fatte per seguire un ordine, delle regole, per essere precise, affidabili, auspicabilmente efficienti. Il punto d’avvio delle ricerche di Tinguely è invece il disordine meccanico: i suoi assemblaggi non rispondono ad alcun ordine prestabilito. L’unica legge che domina i suoi Méta-mécaniques è la legge del caos, i suoi oggetti sono improvvisati, si muovono senza uno scopo definito, sono essenzialmente liberi.



Tinguely non è stato il primo artista cinetico della storia, altri lo avevano preceduto: lui però ha l’intuizione di far collaborare essere umano e macchina per mescolare, trasformare, rivedere il vocabolario dal quale era partito, quello delle avanguardie del primo Novecento (Méta-Herbin reca anche nel titolo un omaggio ad Auguste Herbin: lo stesso Tinguely aveva fatto per Kandinskij, per Malevic e per altri avanguardisti) per creare non delle macchine e neanche delle sculture, ma dei dipinti animati da motori elettrici, perché così venivano visti dai primi critici che videro le sue opere: le Méta-mécaniques venivano accostate più a dipinti che a sculture.
La riflessione sulla macchina è pertanto centrale fin da subito nella ricerca di Tinguely. Che cos’è una macchina? Cosa può fare una macchina? Che relazione c’è tra essere umano e macchina? “Le macchine auto-distruttive e auto-creative di Tinguely”, scriveva Hultén nel 1968, “sono tra le più coinvolgenti idee di una società delle macchine […]. Se l’arte è una riflessione sulle idee fondamentali di una civiltà, poche immagini, pochi simboli sono più pertinenti di queste macchine, che hanno la ricchezza e la bellezza di tutte le invenzioni più semplici, e quindi più grandi”. Il primo “tentacolo nel cuore della nostra civiltà”, come lo chiamava Hultén, erano le Méta-matic, le macchine per creare opere d’arte, progettate da Tinguely sul finire degli anni Cinquanta. Se ne trova un esempio anche alla mostra di Milano: è il Méta-matic no. 10, una macchina che dipinge. All’Hangar Bicocca si può attivare: si acquista in biglietteria un gettone da 5 euro, e con l’aiuto d’un addetto che carica i colori sulla macchina è possibile azionarla e portarsi a casa il dipinto astratto realizzato dal marchingegno: “Venite e create il vostro dipinto con spirito, furia o eleganza, con i Méta-matics di Tinguely, le sculture che dipingono!”: così diceva l’invito alla mostra del 1959 in cui l’artista esponeva per la prima volta questi inusuali apparecchi, questi bizzarri accrocchi che avevano però una finalità, quella di consegnare al pubblico opere d’arte create, forse per la prima volta nella storia, da un oggetto che si muoveva da solo, e l’unica azione umana richiesta era semplicemente quella necessaria per attivare il congegno. Il pubblico della Galerie Iris Clert di Parigi, dove Tinguely aveva esposto per la prima volta le macchine artiste, era stato testimone d’un ribaltamento: in una società industriale che disegna macchine allo scopo di creare prodotti di massa tutti uguali, Tinguely ne disegnava una il cui esito era un dipinto sempre diverso, personalizzato secondo i gusti di chi la azionava. Interessante, divertente anche, come gran parte delle macchine di Tinguely, il cui aspetto ludico alle volte prevale su altre dimensioni (si guardi la Maschinenbar in mostra e si faccia caso all’atteggiamento dei bambini nei suoi riguardi): difficile percepirle come minacciose. Eppure, forse anche un poco inquietante: l’artista forse già prefigurava un futuro di macchine sempre più intelligenti, in grado di sostituirsi all’essere umano persino nella realizzazione di prodotti espressivi tipici della nostra creatività, oppure forse riteneva che, in una società che tende alla standardizzazione e all’omologazione, anche l’arte possa diventare il prodotto d’una macchina. Tinguely aveva però una percezione diversa un poco diversa della sua scultura capace di produrre opere d’arte. “La macchina per dipingere”, sentenziava Hultén nel catalogo della mostra veneziana del 1987, “è un’invenzione d’importanza fondamentale e difficile percezione, paragonabile al ready made di Marcel Duchamp. Le Méta-matics come il ready made sono avulse da ogni particolare stile artistico. Anche se i disegni prodotti dalle Méta-matics richiamano con ironia il tachisme (macchie e chiazze di colore disposte sulla tela senza intenzionalità costruttiva), movimento dominante a Parigi nel 1959, non è questa la loro caratteristica principale. Si tratta piuttosto di un nuovo modo di accostarsi alla realtà, sono oggetto di meditazione metafisica. Le Méta-matics arrivano alla vera essenza della nostra civiltà perché armonizzano il rapporto tra essere umano e macchina. Insieme possono creare qualcosa di irrazionale e di non funzionale, di vitale e di creativo. ‘Per me’, dice Tinguely, ‘la macchina è anzitutto uno strumento per riuscire ad essere poetico. Se rispettate le macchine ed entrate nel loro spirito, potete essere in grado di fare una macchina gioiosa, e con gioiosa intendo libera. Non è una possibilità meravigliosa?’”.

![Jean Tinguely, Méta-Matic No. 10 (1959 [Replica, 2024]; Treppiede di ferro, lastra e barre di metallo, ruote di legno, cinghie di gomma, pittura nera, motore elettrico, 84 x 118 x 61 cm; Basilea, Museum Tinguely). © Jean Tinguely by SIAE, 2024. Foto: Agostino Osio Jean Tinguely, Méta-Matic No. 10 (1959 [Replica, 2024]; Treppiede di ferro, lastra e barre di metallo, ruote di legno, cinghie di gomma, pittura nera, motore elettrico, 84 x 118 x 61 cm; Basilea, Museum Tinguely). © Jean Tinguely by SIAE, 2024. Foto: Agostino Osio](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2024/2900/jean-tinguely-meta-matic-no-10.jpg)
Non esiste forse questione legata alla società delle macchine che Tinguely non abbia sondato. E in questo senso la mostra di Milano espone un campionario molto rappresentativo delle sue opere. Rappresentativo e tutto sommato completo: le rare lacune (sarebbe stato bello vedere in mostra, per esempio, la spettacolare Grosse Méta-Maxi-Maxi-Utopia, ovvero l’enorme macchina che Tinguely mise assieme per la mostra di Palazzo Grassi a Venezia del 1987, dentro la quale si può anche camminare) immaginiamo siano dovute soprattutto a questioni di natura tecnica, dal momento che le macchine di Tinguely sono oggetti fragili, altra caratteristica che inevitabilmente urta col nostro immaginario, dacché ci aspetteremmo che le sue imponenti macchine in metallo siano forti, robuste, resistenti. No: le macchine di Tinguely sono delicate. Soffrono l’usura, soffrono le offese del tempo che scorre, molte non possono esser più messe in funzione, e lo stesso Méta-matic no. 10 è presente in mostra con una fedele replica costruita quest’anno. Altre sono ferme, ma diverse sono in funzione, e in mostra scattano a intervalli di venti minuti per dar vita a una strampalata coreografia: partono, si muovono, battono, sbattono, colpiscono, suonano, rantolano, rintoccano, rumoreggiano, percuotono, spaccano, poi una smette e comincia l’altra, fino a che l’ultima non ha terminato il suo giro e nello spazio dell’hangar s’impone di nuovo il silenzio (quale luogo, poi, poteva esser meglio adatto a ospitare una mostra su Tinguely, se non una vecchia fabbrica convertita in uno spazio espositivo?). Le macchine di Tinguely non hanno un’anima ma sembrano averla. Ognuna ha un carattere proprio, ognuna una propria vita, ognuna, si diceva, ci parla d’un aspetto delle società che le ha prodotte. Col Ballet des pauvres, Tinguely capovolge letteralmente l’idea tradizionale di scultura, appendendo i suoi objet trouvé al soffitto e inscenando un balletto eccentrico, disordinato, scomposto. I Baluba sono sculture traballanti che, a detta dell’artista stesso, rappresentano “quella sorta di follia e frenesia dell’era tecnologica odierna”: il nome è preso a prestito da quello della popolazione dell’Africa Centrale che, negli anni Sessanta, con Patrice Lumumba, era riuscita a ottenere l’indipendenza del Congo dal Belgio. Tinguely aveva scelto di dare questo nome alle sue confusionarie sculture, con un misto d’ironia e rispetto, perché l’epopea dei Baluba gli era parsa interessante, un miscuglio di lotta e caos come quello che l’artista voleva riprodurre con le sue opere, mezzi per suscitare nel pubblico reazioni di curiosità, sorpresa, distanza, rifiuto, vale a dire le stesse reazioni, opposte, che ancora oggi proviamo nei riguardi della società della tecnica. C’è poi una delle opere più note di Tinguely, Rotozaza No. 2, un nastro trasportatore, attivato in mostra un paio di volte alla settimana, che in un ciclo continuo distrugge bottiglie in vetro mandandole in frantumi (al pubblico viene chiesto di stare a distanza per non farsi colpire dalle schegge): è uno degli esempî più interessanti della dimensione che spesso assumono le sculture di Tinguely, giocose e pericolose allo stesso tempo, divertenti e distruttive, quasi avessero un temperamento proprio (si guardino le macchine del Plateau agriculturel mentre si muovono: sono dipinte col rosso tipico dei macchinarî agricoli, e quando partono sembrano quasi dei personaggi che ballano sul pavimento d’una discoteca). C’è un’opera poetica come il Requiem pour une feuille morte, dove tutto il meccanismo, imponente, un gigantesco macchinario di undici metri di larghezza, viene ironicamente messo in azione da una piccola foglia di metallo bianca, posta sul lato dell’opera.
E ci sono poi le opere della popolarità di Tinguely, che a partire dagli anni Settanta diventò sempre più una celebrità e fu in grado d’orientare i suoi lavori verso nuove direzioni, introducendo, per esempio, l’utilizzo della luce, come avviene nelle lampade che giungono verso il finale di mostra, oppure operando su una scala vasta: ne sono una dimostrazione le due opere che aprono l’itinerario di visita, ovvero Cercle et carré-éclatès e Méta-Maxi, opere che espandono le ricerche di Tinguely sul movimento e sul suono (curioso notare i pupazzetti di peluche che spuntano dalle fauci di Méta-Maxi: si vedrà, più avanti, che in Tinguely virilità, brutalità e delicatezza spesso convivono), fino ad arrivare a quei lavori che, più d’altri, certificano il successo di Tinguely: Pit-Stop, per esempio, fu commissionata dalla Renault, ed è fatto con pezzi delle automobili da Formula 1 Renault RE40 guidate nel campionato mondiale 1983 da Alain Prost ed Eddie Cheever (la macchina ha le sembianze d’un grande robot dai cui bracci partono spezzoni di filmati di gare dei due piloti: è questa, peraltro, l’unica macchina di Tinguely che proietta dei film), oppure Café Kyoto, progetto per l’omonimo caffè a Kyoto, in Giappone, per il quale l’artista realizzò lampade, tavoli, sedute. L’opera che chiude la mostra è però densa, inusuale, oltre che fondamentale per comprendere un aspetto tutt’altro che secondario della poetica di Jean Tinguely: il visitatore si trova al cospetto d’un albero bizzarro, luccicante, simile a un fungo, un albero dalla doppia faccia, rigido e scuro davanti, morbido, sinuoso e candido dietro. È Le Champignon magique, uno degli ultimi frutti della collaborazione tra Jean Tinguely e Niki de Saint Phalle, sua moglie: i due si sposarono nel 1971 e rimasero uniti fino alla fine, fino alla morte di Tinguely occorsa nel 1991. Il fungo magico è di due anni prima, la parte di Jean è fatta coi suoi tipici assemblaggi meccanici, mentre quella di Niki è nient’altro che una delle sue Nanas, le sue donne voluminose, materne, rassicuranti, coperta di mosaici a specchio come le grandi sculture che aveva progettato per il Giardino dei Tarocchi a Capalbio (chi visita la mostra su Jean Tinguely non può perdersi la contemporanea rassegna su Niki de Saint Phalle al Mudec: è utile e importante anche per leggere in prospettiva il lavoro di Tinguely).


È evidente che nell’albero che Jean e Niki progettarono assieme convivono la dimensione naturale, edenica, atemporale di Niki de Saint Phalle e, allo stesso tempo, quella artificiale, meccanica, tecnologica di Jean Tinguely: l’ambigua dialettica tra natura e cultura che sostiene la ricerca di Tinguely emerge potente, chiara, straripante proprio nell’opera che chiude la mostra, opera in cui il principio maschile che regola l’arte di Tinguely, e che talvolta può apparire financo brutale, violento, prevaricatore, si palesa in tutta la sua evidenza, non foss’altro per il fatto che lo notiamo per contrasto. Tuttavia s’è detto anche che risulta difficile negare l’elemento ludico, ironico, talora anche benevolo delle macchine di Tinguely, artista che nutriva una certa fiducia nel progresso, riflesso moderno, e inevitabilmente sbiadito, della convinzione ottocentesca che le macchine avrebbero garantito all’umanità un futuro radioso, un futuro che riscatterà l’essere umano dalla fatica, dal dolore e dalla sofferenza perché saranno le macchine a lavorare per noi, a sollevarci dai nostri gravami più insopportabili, saranno le macchine a trasportarci verso una nuova età dell’oro, verso una nuova armonia con la natura. Esiste una dialettica nell’opera di Tinguely: l’artista esalta la macchina, esalta l’artificiale, esalta la capacità dell’essere umano di presiedere il dominio della tecnica, ma è anche consapevole della violenza cui può tendere la macchina, è ben conscio della brutalità che si cela dietro gl’ingranaggi, dietro i bracci, dietro i nastri trasportatori. Tinguely aveva quindici anni quando scoppiò la seconda guerra mondiale: anche se la Svizzera era rimasta lontana dagli eventi bellici (non mancarono però incidenti e qualche bombardamento, anche a Basilea, la città dove Tinguely abitava da ragazzo, e dove oggi peraltro ha sede il museo a lui dedicato), l’eco del conflitto veniva avvertita in tutta la sua violenza (Tinguely peraltro maturò anche, nel 1939, la decisione di unirsi alla resistenza dell’Albania contro l’aggressione fascista, ma venne fermato alla frontiera e rimandato a casa per via della sua giovanissima età). Aver subito la seconda guerra mondiale significava dunque, per Tinguely, avere ben presente l’idea della potenza distruttrice delle macchine. E l’artista ha più volte espresso l’idea che le macchine dovessero essere più femminili.
In diverse interviste, Tinguely dichiarò d’esser stato profondamente affascinato dal Muterrecht di Johann Jakob Bachofen, il primo studio approfondito sul matriarcato, sulla successione matrilineare, sul diritto materno. “Era di Basilea la prima persona che ha scritto un libro sul matriarcato”, ricordò una volta in un’intervista. “In tempi antichi, tutti i bambini ricevevano il nome dalla madre, non si cercava la paternità. La paternità è l’inizio del fascismo. […] Io sono per l’abolizione del patriarcato. Le donne devono replicare [al maschio] con un’altra forma di potere, altrimenti il mondo è fottuto”. L’aspetto spesso assurdo, fragile, rumoroso, goffo, inutilmente complesso delle macchine di Tinguely può allora esser letto anche come una critica raffinata, appuntita, ironica contro l’ossessione per il controllo e per il possesso ch’è tipica del maschio. Tinguely, con le sue macchine, si fa portavoce d’una visione del progresso umano legata a un’idea di trasformazione ch’è basata su di una energia inquieta, forte, che rischia d’essere alienante, di riaffermare il principio del maschio e di conseguenza di separare l’essere umano dalla natura: tuttavia non può allontanarsi dalla natura, se non vuol correre il pericolo dell’autodistruzione. Da questa visione, certamente modellata anche dalla vicinanza a Niki de Saint Phalle ma comunque presente, sebbene forse meno esplicita, fin dalle sue prime ricerche, emerge l’idea d’uno spazio d’interazione tra essere umano e macchina che non sia basato sulla dominazione: per Tinguely, la società tecnologica è una sorta di seconda natura, una matrice artificiale, una nostra estensione che l’umanità ha costruito e che ha ridefinito il nostro rapporto col mondo naturale. Non si può tornare indietro: la tecnologia è necessaria alla sopravvivenza della nostra civiltà, e l’artista ne era consapevole. Il “fungo magico” mostra che esiste sì una dialettica tra natura e tecnologia, esiste sì una tensione che oppone i benefici garantiti dalla macchina alla sua potenza distruttiva, ma esiste anche la possibilità d’un incontro, d’un dialogo tra la natura e la tecnologia. Le macchine di Tinguely appaiono talvolta divertenti forse perché l’artista vuol dimostrare che dietro quell’apparenza minacciosa, dietro quell’inquietante rigidità, dietro quelle forme dure e spigolose esistono anche le premesse per una riconciliazione. Nel 1968, commentando il Rotozaza No. 1 che Tinguely aveva realizzato l’anno prima, Hultén si premurava di sottolineare che “siccome Tinguely ama le macchine, odia vederle corrotte e istupidite da uno sfruttamento spietato e dall’avidità”. È un pensiero che compare implicitamente nell’opera di Tinguely anche prima della comune esperienza, professionale e di vita, con Niki de Saint Phalle, che certo ha contribuito a definire e orientare in maniera più marcata i presupposti che già s’osservavano nella sua arte, ma già un anno prima che s’incontrassero, come s’è visto, la prima preoccupazione di Tinguely era quella d’entrare nello “spirito della macchina”. Non ha mai chiarito fino in fondo cosa volesse dire, e fino a che punto dovesse essere “gioiosa” quella macchina, ma quel fungo magico assemblato assieme a Niki de Saint Phalle, quello Champignon magique può forse essere utile a toglier qualche velo. Agli albori dell’era dell’intelligenza artificiale, all’avvio d’un’epoca in cui il ruolo della macchina torna a esser centrale nel dibattito pubblico, Tinguely è un artista più contemporaneo di tanti nostri artisti contemporanei.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).