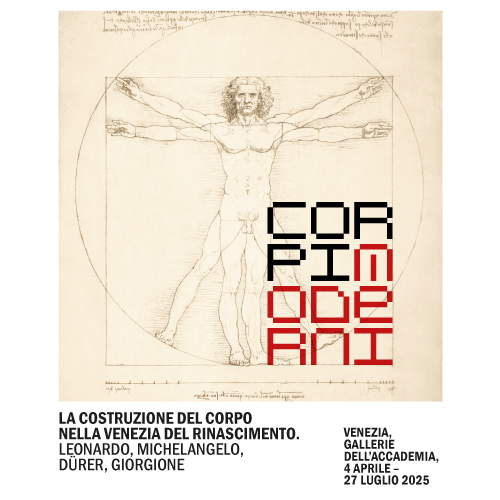Le ceramiche di un grande artista che non amava la ceramica. La mostra di Fausto Melotti a Lucca
Forse, nelle intenzioni di Fausto Melotti, una mostra come quella che la Fondazione Ragghianti di Lucca gli dedica quest’anno non si sarebbe mai dovuta tenere. Il progetto, curato da Ilaria Bernardi, porta nelle sale del complesso di San Micheletto un’esaustiva selezione di ceramiche di Fausto Melotti per indagare questo lungo e significativo capitolo della sua produzione, che lo tenne impiegato in via pressoché esclusiva per almeno un quindicennio, dalla fine della seconda guerra mondiale ai primi anni Sessanta. La mostra, che s’intitola semplicemente Fausto Melotti. La ceramica, ricorre nel ventesimo anniversario dalla pubblicazione del Catalogo generale della ceramica dell’artista trentino. E sarebbe interessante sapere cosa Melotti avrebbe pensato d’un’attenzione tanto alta nei riguardi della sua produzione ceramica, perché per lui era stata una sorta di ripiego. Un’attività in cui credeva poco, tanto da arrivare quasi a vergognarsene. Nella sua testa, la ceramica era l’espediente cui era stato costretto a dedicarsi per evitare la miseria, l’indigenza, per trovare qualcosa con cui campare e lasciare comunque socchiusa la porta dell’arte. Un piano B, potremmo dire.
In una delle sale della mostra, ci si sofferma una ventina di minuti per guardare un’intensa intervista del 1984, nella quale Melotti si confidava ad Antonia Mulas, per la prima e unica volta nella sua carriera proprio su quell’argomento, che forse riteneva scomodo, quasi imbarazzante. “Visto che la scultura non mi dava il pane e poi non mi piace fare i debiti [...] mi sono messo a fare delle ceramiche”, ricordava. “Ho inventato una specie di ceramica che è piaciuta molto e che mi ha dato dei soldi, per cui ho potuto vivere tranquillo [...]. Dopo, a un certo momento, si sono accorti che anche come scultore non ero male e ho piantato la ceramica”. Melotti decide di darsi alla ceramica quando si rende conto che l’ambizione di farsi riconoscere dalla critica viene sistematicamente frustrata. Ciò nondimeno, il suo rapporto con la ceramica è precoce: ha solo ventinove anni quando, nel 1930, conosce Gio Ponti, allora direttore artistico della Manifattura Richard Ginori, e inizia a collaborare con lui realizzando alcune piccole sculture, riuscendo anche a farsi pubblicare su Domus e a esporre, in quello stesso anno, alla IV Triennale di Arti Decorative di Monza. Il giovane Melotti però coltiva obiettivi diversi per la propria carriera: vuole sorprendere critica e pubblico con le sue originali, innovative sculture astratte, che espone per la prima volta nel 1934 in una collettiva alla Galleria Il Milione di Milano, per poi replicare l’anno successivo, nella stessa sede, con la sua prima personale. Il successo sperato tuttavia non arriva: Melotti viene ignorato da tutti, nessuno scriverà una riga su quelle opere leggere, geometriche, che fondono scultura e architettura, che mirano a un’armonia nuova tra materia e spazio. Nell’intervista ad Antonia Mulas, l’artista attribuisce questo fallimento alla mancata comprensione della sua opera: “Sono rimasto solo, in solitudine, in silenzio; c’è stata una congiura del silenzio intorno a quello che io facevo e per decine di anni io sono stato solo. Tutte le sculture che facevo nel mio studio e che erano lì da vedere, nessuno le guardava. Anche i critici che per caso venivano in studio, giravano la testa. Allora neanche a regalarle, le volevano”. Sarebbe poi giunto, molti anni dopo, il tempo della rivalsa. E, ad Antonia Mulas, Melotti rivelava, con un certo orgoglio, che quelli che all’epoca non avevano degnato d’uno sguardo le sue opere, più tardi si sarebbero pentiti. Rimaneva però ancora una certa distanza nei confronti della ceramica.
Neppure lui, in sostanza, riusciva ad affrancarsi dal pregiudizio che all’epoca accompagnava ogni produzione ceramica: l’idea che un ceramista non fosse uno scultore, che s’esprimesse con mezzi meno nobili rispetto a quelli della scultura in marmo o in bronzo, che il suo lavoro avesse a che fare più con la decorazione che con l’arte. E questo malgrado la critica più avveduta non nutrisse più alcuna riserva nei riguardi della ceramica: basterà pensare al successo ottenuto dai lavori di Lucio Fontana che, tolte poche eccezioni (viene spesso citata, quando si parla della ceramica di Fontana, una recensione di Garibaldo Marussi che, in occasione d’una sua mostra al Milione nel 1950, scrisse, con tono quasi sprezzante, che “le opere che Fontana oggi presenta sono quasi tutte dei piatti, dei grandi piatti, da appendere al muro, per ravvivare il tono di un ambiente”), riscossero sempre i favori della critica. Si sa che però l’autorappresentazione non è il modo migliore per ricostruire in maniera puntuale il percorso d’un artista, e se l’artista ritiene che una parte della sua produzione abbia poco significato non è sempre detto che ciò corrisponda al vero. È questo il caso della ceramica di Fausto Melotti: la sua continua e costante ricerca d’un riconoscimento come scultore astratto non rende meno rilevante la sua opera in ceramica. Con la ceramica, Melotti non smette di sperimentare, d’innovare, di espandere i confini della scultura stessa, tanto da trasformare oggetti d’uso comune, come piatti e persino piastrelle, in sculture capaci di trasmettere a chi le osserva il senso di quell’“amore per la fragilità e per la leggerezza” che Giuliano Briganti gli attribuiva e che sostiene tutta la sua opera.






Gli esordî della ceramica di Melotti vengono ricostruiti nella prima sezione della mostra, che espone uno sparuto nucleo di opere degli anni Trenta, a partire da un semplice e scolastico bassorilievo in gesso realizzato dall’artista assieme ai suoi allievi del libero corso di Plastica Moderna della Scuola del Mobile di Cantù, e da una elegante e delicata Madonna col Bambino, che riesce a sublimare il tenero abbraccio tra madre e figlio in una sintesi leggera, suadente ed evocativa, “che lascia già emergere”, scrive Ilaria Bernardi, “la predisposizione dell’artista a una semi-astrazione dei connotati del volto e del corpo tanto che il Bambino sembra un tutt’uno con il corpo della madre”. Esposti nella stessa sezione anche i bozzetti della Decorazione, della Pittura e dell’Architettura, tutti in gesso, realizzati per il vestibolo del Palazzo dell’Arte di Milano in occasione della VII Triennale: le personificazioni delle arti, assise su troni a forma d’obelisco, sono forti d’una presenza fisica robusta, d’una monumentalità arcaica, d’una sintesi solenne che richiama alla mente il linguaggio di Mario Sironi, animato dal desiderio di trovare un punto d’incontro, in apparenza paradossale, tra classico e moderno. Melotti risponde sbilanciandosi verso De Chirico: le sue personificazioni delle arti, con la loro apparenza ieratica, i loro inserti geometrizzanti, i loro volumi che si fondono con l’architettura e il paesaggio (tra le gambe dell’Architettura vediamo spuntare degli alberi, e sul suo grembo vediamo anche un edificio: è quanto accadeva anche negli Archeologi di De Chirico del 1927), sono orientate verso una dimensione metafisica, imponente, eterna.
La seconda sezione, la più corposa della mostra, s’apre con un confronto tra Lucio Fontana e Fausto Melotti, il momento più alto della mostra: un crocifisso di Fontana, opera del 1950 (una terracotta smaltata con lustro e oro in prestito dal Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza), esempio straordinario del barocchismo della ceramica di Fontana, è affiancato alla Lettera a Fontana di Fausto Melotti, una sorta di tributo che lo scultore trentino rivolge all’amico, e che pone le basi per le sue ricerche future, dacché la sintesi d’astrazione e figurazione che Melotti ottiene con questo lavoro (un volto umano incastonato in una partitura evanescente, quasi liquida), fatto di materia densa e vibrante, orienterà gran parte della produzione successiva, stabilendo anche implicitamente la posizione dell’artista nell’ambito del dibattito sull’astrazione e sulla figurazione che di lì a pochi anni incendierà gli ambienti artistici italiani. Questo vale sia per le opere che ancora palesano un’evidente vicinanza a Fontana (come l’opera Senza titolo del 1949, una sorta di grande scoiattolo che trasuda vita, luce, movimento, esattamente come le ceramiche di Fontana), sia per quelle che invece iniziano a staccarsi dal lavoro dell’amico. La mostra dà modo d’apprezzare questo allontanamento: l’Arcidiavolo del 1948 è un’opera che serba ancora tracce dell’infatuazione per le ceramiche di Fontana, ma che nell’allungamento della figura contiene già i germi di quella sintesi quasi geometrica che porterà Melotti alla purezza formale delle Korai di metà anni Cinquanta.







Secondo Melotti, “l’arte non rappresenta, ma trasfigura in simboli la realtà”: lo si vede bene dalle sculture degli animali, rappresentate in buon numero alla mostra della Fondazione Ragghianti, dal precoce Tricheco alla Giraffa, dal Cavallino al Gallo, esposti assieme al famosissimo Bulldog di Bruno Munari e al Cavallo giallo di Aligi Sassu. Sono forse tra le realizzazioni ceramiche più note di Melotti e “rendono evidente”, scrive Ilaria Bernardi nel catalogo, “come il loro autore aspiri a delineare un mondo onirico, semi-astratto, di calviniana leggerezza: quello della fantasia [...]. È l’universo magico di Melotti a emergere in maniera sempre più evidente nelle sue ceramiche: è la tensione verso l’astrazione e stilizzazione delle forme a permettergli di trasformare in arte forme ispirate all’esistente”. La dimensione “onirica” della sua arte è ben marcata anche nei rilievi astratti, alcuni dei quali sono esposti nella rassegna di Lucca a dimostrare ulteriormente l’aggiornamento di Melotti sulle tendenze artistiche del suo tempo: gesto e segni si rincorrono disegnando cerchi e arabeschi sopra basi cromatiche fumose, rarefatte, trasparenti. La sala termina con una selezione di altre sculture dal carattere spiccatamente sperimentale: da una parte i Cerchi, testimoni di un’ulteriore ricerca sulle forme geometriche pure combinate per giungere a raffinati esiti di lirismo astratto, e dall’altra i Teatrini, esempî d’una ricerca cominciata fin dal 1944 con la quale Melotti dà corpo a scene situate al limitare tra interno ed esterno, piccoli ambienti dove avvengono episodî, eventi, incontri fuori dal tempo e dallo spazio. “Nei teatrini”, avrebbe poi dichiarato l’artista, “io non ho abbandonato l’idea rigorosa del contrappunto, ma ho voluto creare qualcosa in un certo senso figurativo, però spostandolo in un ambiente astratto metafisico”: i Teatrini sono quasi, in sostanza, la naturale prosecuzione della ricerca al limite tra astrazione e figurazione che Melotti aveva cominciato già accostandosi a Fontana (curioso notare che lo stesso Fontana avrebbe poi avviato a sua volta una serie di Teatrini).
L’ultima sala è dedicata alle ceramiche d’uso comune, oggetti coi quali Melotti esplora a fondo le potenzialità della ceramica: nelle teche il pubblico ha modo d’ammirare vasi, coppe, coppette, tazzine da caffè, piatti che stanno in bilico tra arte e design: “come in un processo alchemico”, spiega Ilaria Bernardi, “Melotti trasforma gli oggetti d’uso quotidiano in qualcos’altro che, nei colori (tra cui il blu, il bianco, l’oro) e la materia (nella quale s pesso ci sono frammenti vitrei), evoca l’abisso dell’universo”: oggetti “così semplici nella forma, sembrano frammenti di universo strappati dall’artista e offerti a tutti noi”. E oggetti che spesso mettono la funzionalità in second’ordine per sbilanciarsi verso la scultura: si vedano le tazzine da caffè, con la loro forma oblunga, poco pratica. Altri ancora possono esser considerate opere d’arte a pieno titolo: è il caso dei vasi, spogliati totalmente della loro funzione primaria, per diventare sculture astratte che talvolta si presentano con sembianze animali o fitomorfe, spesso perdendo la forma tipica del vaso, vicine alla poetica informale, in grado di dimostrare la spiccata sensibilità che Melotti aveva tanto per la materia quanto per il colore.





Fausto Melotti avrebbe lasciato la ceramica all’inizio degli anni Sessanta, quando sarebbe finalmente arrivato l’ambito riconoscimento come scultore astratto: la ceramica, a suo modo di vedere, non era più necessaria. E lui poteva tornare a essere padrone completo del processo creativo: tra i motivi per cui non apprezzava questa forma d’arte c’era anche il grado d’imprevedibilità dato dalla cottura. Melotti riconosceva nel fuoco il vero regista di tutte le operazioni, e anche qualora il risultato finale si fosse dimostrato identico a quello che lui s’immaginava, vedeva comunque nell’opera finita le correzioni lasciate dal fuoco. Era come se qualcuno avesse messo delle virgole in quello che lui diceva o scriveva, diceva l’artista. E non lo riusciva a sopportare. La mostra della Fondazione Ragghianti riesce però bene nell’intento di dimostrare come l’autovalutazione di Melotti fosse troppo severa: il suo percorso nella ceramica fu coerente, sperimentale, nuovo, aggiornato, moderno, attento. Le sue ceramiche erano antiretoriche esattamente come le sue sculture fatte con altri materiali. Anche con le sue ceramiche Melotti ci ha insegnato, avrebbe detto ancora Giuliano Briganti, “che la fragilità è la nostra condizione e che solo adottando il linguaggio della fragilità possiamo sfiorare con la punta delle dita le cose che fragili non sono”. Ciò vale soprattutto per la ceramica, materia fragile di per sé. Il grande critico aveva in mente i Teatrini, quando scriveva queste considerazioni. Aveva in mente la poesia effimera delle scene che Melotti organizzava nei suoi spazî metafisici, aveva in mente la grande libertà della sua leggerezza, aveva in mente quella semplicità tutta contemporanea e che però non poteva non considerare una certa misura classica. E forse senza la ceramica tutte le potenzialità espressive dell’arte di Melotti non sarebbero mai emerse.
Occorre poi considerare che la produzione ceramica di Melotti rimonta a un periodo di straordinaria vivacità per quest’arte in Italia: è l’epoca in cui comincia l’irripetibile stagione di Albissola, l’epoca delle sperimentazioni di Fontana, di Asger Jorn, di Leoncillo, di Emilio Scanavino, l’epoca in cui Picasso comincia a lavorare la terra nel suo atelier di Vallauris, l’epoca in cui anche il design (con Gio Ponti, Bruno Munari, Ettore Sottsass e altri) inizia a guardare con insistenza alla ceramica. Proprio a Carlo Ludovico Ragghianti si deve, peraltro, una delle prime ricognizioni della ceramica italiana, ovvero la mostra Handicraft as a fine art in Italy che si tenne a New York nel 1947, e dov’erano esposti anche alcuni vasi di Melotti. Ecco: la sua esperienza fu tra le più originali e significative di questo percorso di riscoperta della ceramica, di cui lui fu tra i principali protagonisti, forse senza avvedersene, o comunque cercando di nasconderlo. E la mostra della Fondazione Ragghianti ha il merito di sottolineare con precisione l’estensione e la versatilità del contributo che Melotti ha dato alla ceramica italiana e, attraverso la ceramica, all’arte del suo tempo.
Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!
La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).