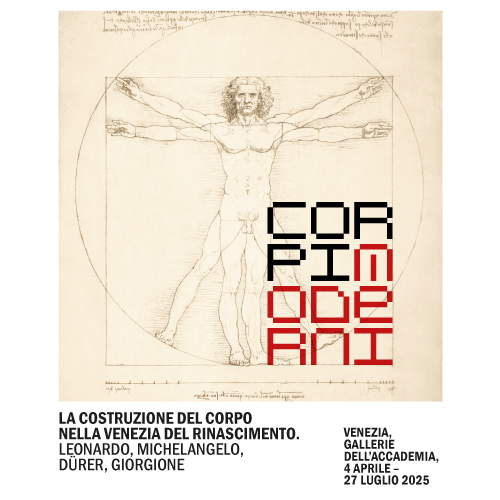Con Tracey Emin tutti amiamo meglio
Con Tracey Emin tutti amiamo meglio. Tracey è forse la prima artista dopo Frida Kahlo che trasforma gli ultimi tabù come la vulnerabilità e la malattia in una nuova espressione artistica oltrepassando l’attuale gerarchia accademica. Se i sentimenti e le emozioni non erano stati abbastanza indagati dal Romanticismo e dall’Espressionismo, Tracey fonde insieme le due correnti riattualizzandone le tematiche, dipingendo sesso e nudità come faceva Egon Schiele, dolori e tormenti come Edvard Munch, entrambi ampiamente citati e invocati nel suo lavoro come suoi massimi riferimenti, ma anche cucendo i nomi dei suoi amanti su copriletti e tende, illuminando stazioni e ministeri con le sue dichiarazioni d’amore a neon. Prima di Tracey, l’istinto e la spontaneità erano già stati usati in maniera diretta e bruta dagli Espressionisti Astratti come Jackson Pollock e Willem De Kooning promossi dalla CIA negli anni Cinquanta per competere sia con il Socialismo Realista delle nazioni comuniste che con il mercato dell’arte europeo ancora dominante. Se oggi sappiamo che lo spontaneismo e l’arbitrarietà nell’arte, originari del Dada, favoriscono più il mercato americano che un più globale ideale libertario, possiamo indagarne l’utilità e l’attualità attraverso l’uso smodato che ne fa Tracey.
L’arte di Tracey è votiva, sanguigna e carnale, non è rappresentativa: dipinge, scolpisce e cuce non i suoi traumi ma con i suoi traumi, con le sue ferite fisiche e psicologiche, senza filtri. Lo stupro, gli aborti, il cancro, le operazioni e l’invalidità sono la sua tavolozza o la creta con cui rimodella e ridefinisce non solo il proprio rapporto al corpo, al sesso e la sua femminilità ma la nostra identità diventata nel frattempo fluida (e quindi indefinita) con il sopraggiunto wokismo, ancora figlio del liberalismo. Come Tracey, la messicana di padre tedesco Frida Kahlo, sopravvissuta a un terribile incidente stradale, che tanto Breton volle integrare nel suo ormai morente movimento ma in realtà surrealista solo tecnicamente, seppe accettare le sue fragilità rifiutando di vederle come infermità, facendone anzi lo stendardo della sua arte e della sua iconica immagine. Forse il calvario di Frida non è estraneo al fatto che sia oggi venerata come una santa. Diciamo che sia Frida che Tracey, entrambe emblema di sopravvivenza, hanno saputo trasformare il connubio cristiano del martirio e dell’adorazione in un modello culturale di resilienza, sicuramente pop ma soprattutto laico e attuale.
Con una pacata sicurezza, con la commovente naturalezza, la confidenza e il carisma di una grande artista, Tracey ci ha parlato a Firenze come tornata dal futuro. Un futuro in cui tutto il pacchetto delle risorse cognitive è stato riabilitato e reintegrato da tutti. Risorse cognitive come l’amore, l’empatia, la cura e la gentilezza, la tolleranza e la comprensione, sedate dal consumismo e mai veramente riattualizzate dalla Chiesa ma anzi propinate sotto forma di oratoria, di monotona retorica. L’amore si acquisisce, si acquisisce con la pratica, come una lingua, la lingua con cui ha parlato Tracey a Palazzo Strozzi a Firenze per la sua prima personale istituzionale in Italia, davanti a una platea di giornalisti ignari di essere in realtà sermonati e convertiti dalla papessa contemporanea della vulnerabilità.





Ma come si parla l’amore? Ebbene, lo parliamo quando ci confidiamo, quando ci dichiariamo, non importa a chi, se a nostro figlio, fratello, amico, collega o futuro sposo. Quando parliamo sinceramente, senza ironia, senza alcuna forma di aggressività, in maniera disinteressata, coinvolgente, autentica, soggettiva e vulnerabile, esponendoci, svelandoci con compassione verso gli altri e verso noi stessi. Ecco perché il cristianesimo ha il più grande arsenale affettivo: il rito della confessione, il perdono, le prediche, la messa, i giubilei, se non fosse tutto così burocratizzato, dai fedeli agli impiegati preti ai Ceo cardinali, la Chiesa sarebbe all’avanguardia dell’amministrazione affettiva del pianeta. I monoteismi hanno fallito nel convertirci all’amore, ma oggi Tracey e pochi profeti come lei parlano la lingua che tutti conosciamo e che dovremmo parlare tutti. Tutti dovremmo parlarci seguendo i principi della dichiarazione d’amore e in ogni contesto. Un po’ come successe nelle rivoluzioni linguistiche letterarie del Medioevo dal latino alle lingue volgari, contaminando cioè con il linguaggio naturale ogni forma di linguaggio artificiale.
Anche quando non parla dei cateteri vescicali o dei suoi gatti, Tracey si confida sempre, si racconta pubblicamente riportando l’attenzione sulla necessità dell’intimismo anche in contesti formali e politici come quello della conferenza stampa a Palazzo Strozzi il 13 marzo fra sindaci, mecenati e amministratori vari. Togliere tutte le affettazioni e le barriere, senza però abolire i limiti della moralità, per sanificare la res pubblica, ripristinare la funzione sociale dell’attaccamento, il senso di fiducia e di appartenenza, alla base della vita: è quello che incarna il suo lavoro più famoso My Bed del 1998, venduto nel 2014 a tre milioni di dollari da Charles Saatchi (mecenate di tutto il gruppo degli Young British Artists fra cui Damien Hirst e Sarah Lucas suoi compagni di banco) che l’aveva comprato a solo 150 mila sterline, al conte Christian Duerckheim. Prestato dopo l’asta Christie’s alla Tate per dieci anni, doveva teoricamente essere restituito al conte e collezionista tedesco quest’anno, ma la Tate Modern ha appena annunciato che ci sarà una grande mostra per segnare il trentesimo compleanno della sua carriera artistica su Tracey Emin a Febbraio 2026, e sotto l’immagine di My Bed – cavallo di battaglia della Tate di cui sarebbe il caso diventasse in qualche modo bene inalienabile – adesso la didascalia riporta long loan, il prestito è diventato quindi di durata indefinita. È già qualcosa, e speriamo sia quella l’occasione per poterlo vedere dal vivo.
Vi chiederete cosa rende My Bed un tesoro nazionale: un letto disfatto e sporco, corredato di bottiglie di alcol vuote, cicche di sigarette, calze di nylon, assorbenti e preservativi usati, vecchie polaroid, diventato simbolo di depressione e derivati, trascendendo con il suo intimismo l’esibizionismo, le forzature e in qualche modo l’emulazione e la corruzione di molta arte scandalistica e modaiola alla Marc Quinn o Maurizio Cattelan. L’unica notevole differenza tra il letto di Tracey Emin e tutte le altre opere provocatorie o cosiddette irriverenti, è che il letto è suo, un dettaglio non da poco e che lo distingue e lo legittima come opera intimistica e originale. Tutto sta nel pronome my nel titolo dell’opera: ogni residuo, oltre che essere ognuno potenziale campione di dna, ne certifica l’autenticità in senso proprio e figurato. Ognuno di questi residui testimonia anche dell’inclusione e della previsione teorica scientifica nell’opera di tutto il corredo dei sintomi inclusi nella depressione. Tutte le derive e le forme depressive che vanno dall’alcolismo al suicidio sono rappresentate, preventivate e quindi teorizzate, nel letto di Tracey. Un capolavoro a tutti gli effetti, che ha solo ventisette anni e senza dubbio uno dei rari capisaldi della Storia dell’arte recente.



Appartenuta anche quella a Saatchi, Palazzo Strozzi ripropone una riproduzione dell’installazione ricavata dall’azione Exorcism of the Last Painting del 1996, in cui in un’ode trash alla pittura, abbandonata dopo due aborti, l’artista tenta una sofferta catarsi ritualizzata rinchiudendosi nuda nel museo di Stoccolma per tre settimane, il tempo fra un ciclo mestruale e un altro. Una versione femminile della famosa performance di Joseph Beuys e il coyote, come lei stessa dichiarerà, in cui ripercorre il soggetto del nudo femminile come l’hanno dipinto maestri da Munch a Picasso a Klein.
Imponente nel cortile di Palazzo Strozzi, una replica monumentale di nudi femminili accovacciati in bronzo della Emin che ammiccano ai bronzi femminili De Kooning ma visti dalla prospettiva opposta. Un’occasione per constatare che l’artista inglese applica lo spazialismo di Fontana, conferendo il suo tocco di sincerità spinta ai sessi femminili già beanti più de L’origine du monde di Courbet, tutti rigorosamente con il foro. E poi amplessi ricamati e onanismo femminile in grande formato che sfidano il puritanesimo, rinfoltiscono l’iconografia mondiale e contribuiscono all’educazione sessuale e alla fine del patriarcato.
In bronzo anche una lettera d’amore difficilmente decifrabile ma tant’è, un tentativo comunque di trascendere il genere. Una poesia d’amore a neon rosa alta quanto il soffitto di Palazzo Strozzi, frammenti amorosi su fazzoletti e altre opere tessili che unite a tutto il suo corpus di love neons, neon d’amore, costituiscono un manifesto di estetica affettiva che solo oggi Tracey riconosce di non aver abbastanza capito di dover distinguere dal sesso. Resta quindi un’occasione persa e un rimpianto che al posto del neon, pur fatto site specific e che dà il titolo alla mostra, Sex And Solitude, Tracey non abbia ornato invece la facciata di Palazzo Strozzi, regalandola all’Italia e quindi alla Storia dell’Arte, come fece in altre pubbliche occasioni benedicendo in qualche modo Downing Street e la San Pancras Station, con una delle sue consacranti dichiarazioni d’amore. Peccato.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE