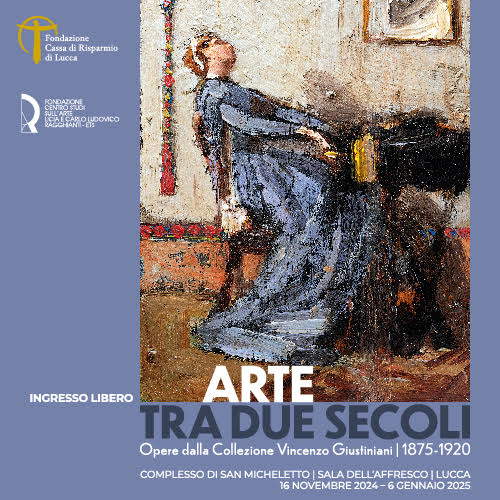Sì, è una festa divisiva. Due pensieri e un quadro per il 25 aprile
Due pensieri per un 25 aprile diverso dal solito, per una festa della Liberazione che, per la prima volta nella storia e per una sorta di beffarda ironia della sorte, ci vede tutti segregati in casa per imposizione d’una serie di decreti che tutti stiamo rispettando pur consci che hanno limitato la nostra libertà di movimento anche laddove non necessario, che hanno tolto la dignità di celebrazione anche alla morte, che hanno creato un’artificiale e brutale scissione tra la nostra vita biologica e quella sociale, affettiva e culturale.
Il primo: il 25 aprile è una festa divisiva. Con le parole di Luciano Canfora, in un’intervista pubblicata oggi su BonCulture: “quel conflitto durato diciotto mesi, fra l’8 settembre del ’43 e l’aprile del ’45, era l’ultima fase di una ostilità iniziata all’indomani della prima guerra mondiale, che si era sviluppata in una guerra civile già negli anni Venti ed era sfociata nell’avvento al potere del fascismo, con l’appoggio della corona e di un ampio schieramento di espressioni conservatrici e liberali del nostro paese. Quel conflitto non si è mai sopito. Le due Italie si sono ancora contrapposte, nei limiti in cui era possibile farlo sotto la dittatura. Con il tracollo bellico le parti sono riemerse in pieno e il conflitto ha avuto l’esito che sappiamo. D’altra parte le forme in cui il fascismo storico riemerge le conosciamo, non sono soltanto in Forza Nuova e in altre espressioni oltranziste, ci sono radici più profonde”. Il fascismo propriamente detto appartiene alla storia (segnatamente il fascismo saloino, ovvero quello cui comunemente si pensa quando si celebra il 25 aprile), ed è forse superfluo rimarcare che non ne faremo mai più esperienza. Ciò non toglie che alcune sue manifestazioni possano ripresentarsi: tocca pertanto capire da quale parte schierarsi. E questo non significa cantare Bella Ciao affacciati al terrazzo di casa: al di là della vuota e stridente retorica celebrativa (e forse introducendo una retorica d’altra natura, ma almeno con l’idea d’allargare il discorso), significa frequentare la pratica della libertà in ogni singolo momento della propria esistenza, anche semplicemente seguitando a coltivare il dubbio, abitudine tanto più preziosa in un momento come quello attuale. La si veda almeno come forma di gratitudine per chi ci ha dato questa possibilità.
Il secondo pensiero: la pratica della libertà diventa più difficile se la conoscenza storica e il pensiero critico rimangono sopiti, o ridotti a una narrazione schematica. E questo succede anche (e forse soprattutto) quando la storia viene adoperata come fosse una clava, riducendo il tutto a un discorso pubblico spesso banalizzante e celebrativo nel senso deteriore del termine. Con le parole di Gianpasquale Santomassimo, in un suo scritto del 2001: “la memoria pubblica è inevitabilmente selettiva, opera scelte, anche drastiche. Su quest’ultimo terreno operano soprattutto i protagonisti istituzionali che si assumono responsabilità durature nei quadri di riferimento che delineano di fronte alla coscienza civile del paese. In Italia non è ufficialmente riconosciuta, come altrove, la categoria della public history, intesa come storia fatta in pubblico e rivolta al pubblico da soggetti istituzionali, con un suo particolare linguaggio, una particolare e specifica retorica volta alla costruzione di una memoria collettiva”. La public history italiana è stata spesso oggetto di distorsioni massimaliste, mitizzazioni, narrazioni che ne hanno forse allargato la distanza rispetto alla ricerca storiografica. Un atteggiamento, anche questo, sommamente controproducente.
Infine, un quadro a tenere assieme il tutto, contro la vulgata che cristallizza la storia in una sorta di lotta tra schieramenti impermeabili e convincimenti granitici, e che è lungi dall’affrancare l’Italia da quell’immaturità politica che Gobetti individuava come una delle “caratteristiche costanti di grassi ceti” del nostro paese. Il quadro è la cézanniana Fucilazione di Ernesto Treccani del Museo di Palazzo Ricci di Macerata, esposta anche in quella bulimica rinuncia al ruolo del giudizio della critica d’arte che fu la mostra Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918 - 1943, tenutasi nei primi mesi del 2018 alla Fondazione Prada di Milano. È una drammatica, toccante testimonianza della guerra civile, un brano di memoria vicino alla poetica di denuncia di Picasso (Treccani, evidentemente, aveva ben presente Guernica), che evoca con crudezza ciò che per molti significò la Resistenza: una fine tragica.
All’epoca, Treccani aveva soli ventitré anni ma aveva già alle spalle una nutrita storia di militanza culturale: fondò il primo periodico, Vita giovanile, che non aveva ancora diciott’anni, lo trasformò poi in Corrente di Vita Giovanile, senza scostarsi d’un millimetro dall’adesione all’ideologia fascista nel cui alveo la rivista si muoveva, per poi mutare radicalmente orientamento nel giro di pochi mesi grazie all’afflusso di numerose personalità che scrissero sulla rivista, e le fecero perdere progressivamente il suo allineamento al regime per farla diventare un giornale critico nei confronti del regime stesso, tanto da venir chiuso per disposizione delle autorità all’epoca dell’entrata in guerra dell’Italia. Quel quadro, dunque, non è solo l’istantanea d’un momento, ma ci ricorda che le modalità, le convinzioni, le convenienze, le consapevolezze, le scelte, le ragioni che portarono molti ad aderire alla lotta contro il regime (o viceversa) furono frutto di singoli processi che pertengono forse alla sfera dell’umanità, e allo stesso modo vasta e variegata fu la platea che, da una parte e dall’altra, animò le diverse posizioni, oppure ingrossò le gigantesche fila di quanti, più semplicemente, speravano solo di sopravvivere (e che oggi sono tagliati fuori dal discorso pubblico). La storia e la storia dell’arte hanno il dovere di ricordarlo.
 |
| Ernesto Treccani, Fucilazione (1943; olio su tela, Macerata, Fondazione Carima - Museo Palazzo Ricci) |
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).