Il Tempio Malatestiano di Rimini, il sogno rinascimentale di Sigismondo Malatesta
Sembra d’entrare in un tempio pagano. Oppure in una sontuosa residenza nobiliare, se si preferisce. Quando ci s’inoltra nel Tempio Malatestiano si ha subito la netta percezione che la gloria del pantheon cristiano non fosse esattamente in cima alla lista delle priorità di Sigismondo Malatesta, il signore di Rimini che volle far costruire questa chiesa, questo monumento alle sue ambizioni. Anche se, più che di ambizioni, si potrebbe parlare di velleità. E lo stato d’incompiutezza del Tempio diventa sinonimo visivo di quel desiderio di fare della piccola, marginale signoria di Rimini uno stato forte, che riuscisse a espandersi a scapito dei suoi vicini. È vero: a Sigismondo Malatesta si potevano rimproverare la scarsa lealtà nei confronti degli alleati, l’eccessiva aggressività, il temperamento iroso, il suo agire spesso istintivo, il fatto d’essersi inimicato molti dei più potenti sovrani del Rinascimento. Ma non gli si poteva rimproverare di non amare la propria città. Al punto che, quando papa Paolo II, nel 1467, gli chiese di considerare l’ipotesi di cedere Rimini alla Chiesa in cambio d’alcuni benefici che Sigismondo aveva richiesto dopo l’infruttuosa partecipazione alla guerra in Morea contro i turchi, l’orgoglioso Malatesta considerò che mai avrebbe ceduto “quella povera città che m’è rimasta, dove sono la maggior parte delle ossa delli miei antiqui”. Sigismondo avrebbe preferito “morire con honore che di ricevere tale vilipendio”, e lo disse al papa in persona: sarebbe anzi morto mille volte, piuttosto che esser costretto a subire un’onta del genere. L’ostinazione avrebbe poi premiato Sigismondo, che alla fine dei suoi giorni, sconfitto, deluso, in dissesto finanziario, riuscì comunque a conservare la sua Rimini.
La storia, si sa, viene scritta dai vincitori. E i vincitori di Sigismondo Malatesta diffusero del signore di Rimini un ritratto a tinte foschissime, tanto che per lungo tempo è stato considerato sbrigativamente, e ingiustamente, come una specie di tiranno ignorante, rozzo, sanguinario. In realtà, poche figure del Rinascimento sono circonfuse d’un fascino paragonabile a quello che circonda Sigismondo Malatesta, un fascino che impregna ogni pietra del Tempio Malatestiano, sorto sul sito dell’antica chiesa di San Francesco verso la fine degli anni Quaranta del Quattrocento, quando Sigismondo si trovava all’apice della sua gloria. Le fortunate campagne militari gli avevano procurato ingenti guadagni, attraverso i quali il signore di Rimini aveva potuto dedicarsi a quello che forse più amava davvero: l’arte. Sigismondo radunò così in Romagna una raffinata schiera di poeti (e lui stesso fu poeta), intellettuali, letterati, artisti. Attraverso il lavoro dei suoi protetti, il Malatesta intendeva celebrare la propria famiglia, esaltarla quasi fosse oggetto di un culto, figura centrale d’una singolare religione. E, come anche altri signori del tempo, lo stesso Sigismondo cercò di legare la storia della propria famiglia, oltre che della propria persona, a un repertorio di simboli antichi. Il Tempio Malatestiano sarebbe diventato l’evidenza più folgorante di questa politica culturale, la casa edificata a gloria eterna dei signori di Rimini.



Sigismondo affidò i progetti a Leon Battista Alberti, cui spettò il compito di sistemare l’esterno, e a Matteo de’ Pasti, chiamato invece a rivedere gl’interni. Il cantiere partì dall’interno, nel 1447, e qualche anno dopo, verso il 1453, entrò in scena Alberti, che ideò un tempio dalla concezione totalmente innovativa. Per la facciata avrebbe adottato la struttura tipica dell’arco di trionfo romano, prendendo largo spunto dall’Arco di Augusto di Rimini, situato a pochi passi dall’area su cui sorge il Tempio. Nessuno prima d’allora aveva mai tentato qualcosa anche di vagamente simile: per la prima volta, la facciata d’una chiesa s’ispirava a un arco di trionfo romano. L’arcata maggiore della facciata, quella che inquadra il portale, sarebbe stata affiancata da due archi laterali che avrebbero dovuto accogliere i sepolcri di Sigismondo e della sua amata, Isotta degli Atti, poi sistemati invece all’interno della chiesa, col risultato che gli archi laterali della facciata oggi sono meno profondi rispetto a come avrebbero dovuto risultare secondo il progetto originale. E poi, a imitazione dei templi antichi, anche il Tempio Malatestiano sembra poggiare su di un alto stilobate, il piano orizzontale sul quale s’ergono le colonne. Lo stato d’incompiutezza delle chiesa non impedisce d’apprezzare quella ch’è di fatto la prima applicazione pratica delle teorie di Leon Battista Alberti, espresse anche nel suo trattato De re aedificatoria, a proposito dell’architettura ispirata direttamente all’antico, intesa come armonia, semplicità rigorosa, giustezza di proporzioni. A coronare la facciata del tempio, il fregio su cui corre la celebrazione del signore, in latino: “Sigismondo Pandolfo Malatesta, figlio di Pandolfo, realizzò per voto nell’anno di grazia 1450”. La scritta non è solo una rivendicazione: possiamo leggerla come una sorta di manifesto politico, e non solo perché Sigismondo voleva render chiaro a tutti a chi fosse dovuta l’impresa del Tempio: il 1450 fu anno giubilare, nonché anno in cui papa Niccolò V rinnovò il vicariato apostolico sia a Sigismondo che a suo fratello minore Domenico, detto Malatesta Novello, signore di Cesena. E nella stessa occasione, il papa legittimò anche i due figli maschi di Sigismondo e garantì il vicariato ai Malatesta per tre generazioni. Sigismondo considerava tutto ciò come l’investitura definitiva d’una dinastia forte, avviata a un alto destino. E il Tempio doveva esser considerato una specie di mausoleo della famiglia.
Il vicariato apostolico aveva conferito prestigio al casato, ma l’ambizioso Sigismondo voleva di più. Titoli, denaro, territori, gloria. Ma non poteva sapere che stava vivendo il suo apogeo, e che il suo destino, in realtà, era quello di vedere frustrate le sue ambizioni. Ambizioni che, proprio in quel periodo, avevano soffiato sul fuoco dello scontro tra Rimini e il papato. Il fuoco stava per diventare un incendio, ma Sigismondo non poteva saperlo. E poteva ancora permettersi di sfidare l’autorità pontificia. Anche dentro al suo tempio.
Può esser letto come una provocazione anche quel capolavoro che è l’affresco di Piero della Francesca, del 1451, che ritrae Sigismondo Malatesta in preghiera di fronte a san Sigismondo. Il santo eponimo di Sigismondo, il primo santo barbaro della Chiesa cattolica, l’antico re dei Burgundi vissuto nel VI secolo, non è raffigurato secondo la tipica iconografia, ovvero con fattezze giovanili, bensì come un uomo attempato, che tiene con una mano uno scettro e con l’altra regge un globo: san Sigismondo è stato rappresentato con i simboli tipici del potere imperiale e con le fattezze del defunto imperatore Sigismondo di Lussemburgo, che nel 1433 aveva concesso il titolo di cavaliere a Sigismondo Malatesta, all’epoca appena sedicenne, conferendo così la legittimazione imperiale al suo potere e alla sua famiglia. Il messaggio è chiaro: Sigismondo Malatesta dichiara apertamente la sua lealtà al potere imperiale, tanto più che nell’immagine compaiono anche due cani, simboli di fedeltà e vigilanza. Ma l’affresco di Piero della Francesca non era l’unica immagine con cui Sigismondo Malatesta sfidava il papato. La prima cappella di destra, la cappella di San Sigismondo, pensata come cappella funeraria di Sigismondo dopo che si risolse d’ospitare il sepolcro all’interno del Tempio, è ornata con le figure delle Virtù, splendidi lavori di Agostino di Duccio, riservate solitamente alle sepolture di re e principi, o comunque di sovrani desiderosi di richiamare con allegorie quanto di buono fatto durante il loro governo. L’idea di Sigismondo, in sostanza, era quella di presentarsi al mondo come un dominus potente, valoroso, amato.







Ovunque, tra le pietre del tempio, sugli scudi degli angeli di Agostino di Duccio, ricorrono i tipici simboli malatestiani, a cominciare dall’elefante: lo si trova come cimiero di elmi, alla base di pilastri e colonne, adoperato come elemento decorativo, e anche come sostegno del sepolcro di Isotta degli Atti. È simbolo di forza, potenza, imperturbabilità: il motto di Malatesta Novello era elephas indus culices non timet, “l’elefante indiano non teme le zanzare”, come a dire che le persone grandi non si curano dei fastidî recati da quelle piccole. E poi l’impresa delle tre teste, che richiama visivamente il nome della famiglia Malatesta perché raffigura le teste dei tre mori (quindi infedeli, teste cattive, “male teste”) uccisi dal leggendario capostipite della casata, il mitico eroe troiano Tarcone, figlio del re di Troia Laomedonte. Compare spesso la rosa canina, che s’ammira anche tra i cassettoni che ornano l’arco del sepolcro di Sigismondo: era l’effigie con cui i Malatesta s’intestavano la discendenza dalla famiglia romana degli Scipioni il cui simbolo era la rosa a quattro petali. E ovunque ricorre il simbolo della S e della I intrecciate: è la prima sillaba del nome Sigismondo, ma in passato ci fu chi ritenne, e forse ancora qualcuno lo ritiene, che si trattasse in realtà delle iniziali dei nomi di Sigismondo e di Isotta, desiderosi di suggellare il loro amore tra le cappelle del tempio. Non è così, la lettura romantica mal s’adatta agli usi del Rinascimento e alla ricorrenza di quella sillaba anche in contesti che con Isotta niente hanno a che fare. Ma gl’innamorati che sognano un amore come quello tra Sigismondo e Isotta s’accomodino: la storia del loro amore vale più d’una sillaba.
Isotta degli Atti aveva quindici anni meno di Sigismondo Malatesta. Non era di nobili origini: era figlia d’un ricco mercante d’origini marchigiane. Probabilmente i due divennero amanti quando Isotta aveva tredici anni o giù di lì, e Sigismondo ne aveva poco meno di trenta: la differenza d’età, per l’epoca, non era un gran problema. Quando poi, nel 1449, morì la prima moglie di Sigismondo, Polissena Sforza, la relazione divenne pubblica, e qualche anno dopo, nel 1456, il signore poté finalmente sposare la donna che aveva amato d’amore vero. Quello tra Sigismondo e Isotta fu uno dei rari matrimoni disinteressati del Rinascimento: sposando Isotta, Sigismondo non avrebbe tratto alcun vantaggio politico (a eccezione della legittimazione dei figli da lei avuti al di fuori del matrimonio), ma avrebbe coronato il sogno che la ragion di Stato non gli aveva permesso di veder esaudito. L’amore tra i due fu così intenso, così appassionato da far sorgere financo un filone letterario alla corte di Rimini, quello della poesia isottea. Anche a Sigismondo s’attribuisce un sonetto dedicato a Isotta (“O vaga e dolce luce anima altera! / Creatura gentile, o viso degno, / O lume chiaro angelico e benigno / in cui sola virtù mia mente spera”).
Sigismondo aveva pensato a celebrare Isotta fin dai primi progetti per il Tempio, nel 1447, quando ancora non erano sposati, quando Polissena era ancora in vita: ma all’epoca, si sa, i matrimonî non si celebravano per amore. E poi non era un mistero che il signore di Rimini coltivasse la sua relazione con Isotta fuori dai vincoli coniugali. Il sepolcro di Isotta occupa dunque una posizione preminente all’interno del Tempio: è collocato nella cappella di San Michele, dove occupa un’intera parete, ornata con uno spiccato decorativismo di matrice tardogotica che segue una delle caratteristiche peculiari del Tempio Malatestiano, ovvero il contrasto tra l’esterno compiutamente rinascimentale e l’interno ancora legato al gotico cortese. Quel sepolcro, consacrato già nel 1450, quasi venticinque anni prima che Isotta morisse, ha sollevato lunghe discussioni per la sua epigrafe con dedica “D. ISOTTAE ARIMINENSI B.M. / SACRUM MCCCL”, letta specialmente da certa critica ottocentesca come una specie di bestemmia in ragione di quella D puntata, abbreviazione di “Divae”, “divina”, e della B, da qualcuno ritenuta sigla di “Beatae”. Era come se Sigismondo avesse scritto “Consacrato nel 1450 alla beata memoria della divina Isotta di Rimini”, come se la sua amante, perché tale era ancora a quel tempo, venisse elevata al rango dei santi e dei beati, senza che il signore di Rimini fosse stato investito d’alcuna autorità da parte della Chiesa. In realtà, l’aggettivo “diva”, qualora voglia esser letto così (e non come abbreviazione di domina), era del tutto appropriato a una signora del rango di Isotta. E la “B” starebbe per bonae: “Consacrato nel 1450 alla buona memoria della signora Isotta di Rimini”.
Ad ogni modo, per il papa, il problema non era certo il sepolcro. Né probabilmente lo era il Tempio, dato che all’epoca i sincretismi non erano rari, anche se non così abbondanti come nella chiesa di Sigismondo. Il Tempio era comunque una buona scusa per dipingere Sigismondo Malatesta come un signore empio, un sovrano blasfemo e cattivo, un senzadio. E così contro quella chiesa, che somigliava più a un tempio pagano che alla casa del Dio dei cristiani, nel 1462 si sarebbe scagliato il tremendo giudizio di papa Pio II, che già l’anno prima aveva accusato Sigismondo Malatesta dei peggiori crimini, attraverso una violentissima requisitoria affidata all’avvocato Andrea Benzi. Pio II era alleato di Ferdinando I d’Aragona, che reclamava da Sigismondo un cospicuo credito. Sigismondo stentava però a onorare il suo debito: il papa lo richiamò più volte ai suoi doveri, ma il giorno di Natale del 1460, date le sue continue disubbidienze, e data soprattutto la volontà di Pio II di disfarsi d’un valoroso condottiero che aveva sempre creato problemi allo Stato Pontificio, lanciò contro di lui e contro suo fratello Domenico la scomunica e, in un concistoro convocato il 16 gennaio del 1461, celebrò una sorta di processo in contumacia durante il quale furono lanciate terribili accuse contro Sigismondo. Il signore di Rimini veniva tacciato d’essere un eretico, un bestemmiatore, un assassino e un uxoricida (il papa lo accusava d’aver ucciso le sue due prime mogli per potersi sciogliere dai vincoli matrimoniali), e di commettere regolarmente furti, incesti, stupri, violenze anche a danno dei bambini. E una personalità così deviata non poteva che far edificare un tempio a propria immagine. Nel 1462 Pio II, nei Commentarii, dipinse in questi termini il Tempio Malatestiano: Aedificavit tamen nobile templum Arimini in honorem divi Francisci, verum ita gentilibus operibus implevit, ut non tam Christianorum quam infidelium daemones adorantium templum esse videatur, “Fece costruire a Rimini un nobile tempio dedicato a san Francesco, tuttavia lo riempì di opere pagane, così che sembrava un tempio non di cristiani, ma di infedeli adoratori dei diavoli”.
Ovviamente, Sigismondo non era un satanista avanti lettera. Il programma iconografico dell’edificio è la manifestazione visiva della celebrazione d’un potere, della cultura filosofica della Rimini di metà Quattrocento, d’un’ideologia che intreccia il sacro con elementi classici e neoplatonici. Di certo, Sigismondo Malatesta non aveva intenzione d’essere irriguardoso verso la religione cristiana, anche se di fede, Cristi e santi poco s’interessava: anche perché, se così fosse stato, i frati francescani che amministravano il culto all’interno della chiesa sarebbero stati i primi a rampognare il signore. L’interpretazione di Pio II era però funzionale al suo disegno politico.





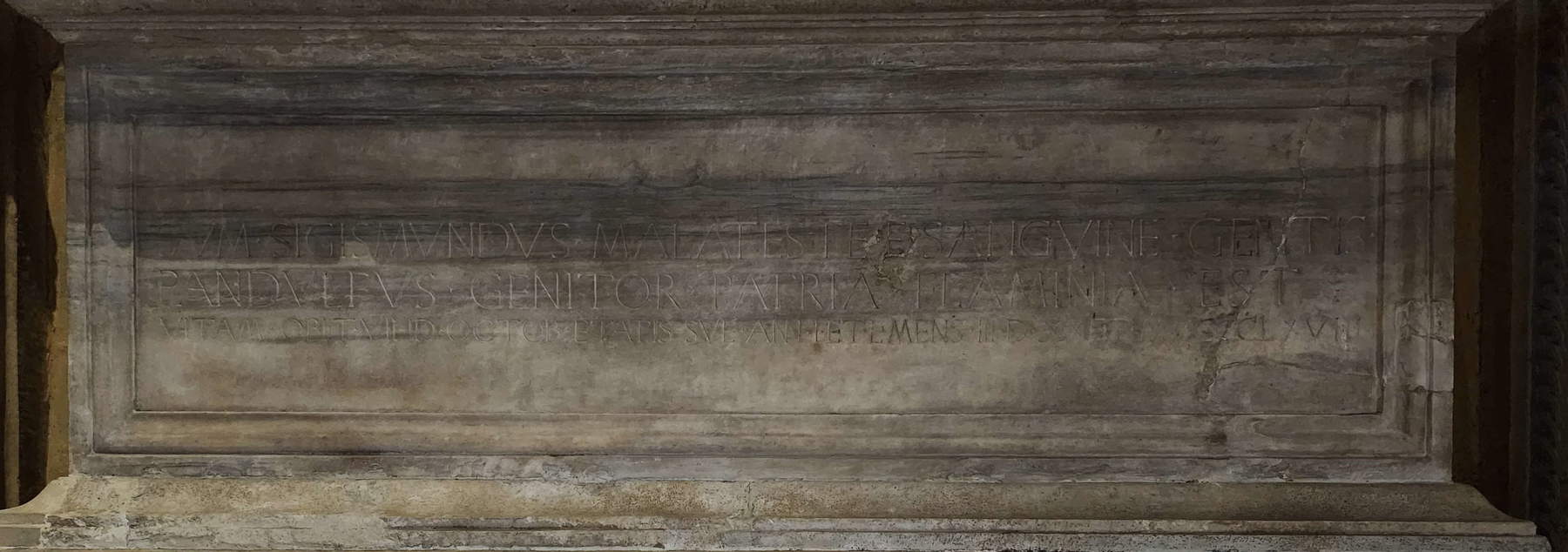




Dopo aver lanciato la sua requisitoria, il papa maledisse il signore di Rimini, lo condannò alle fiamme dell’inferno, sciolse i riminesi dal vincolo di fedeltà al signore e infine, nell’aprile del 1462, revocò ogni onorificenza donata dalla Chiesa a Sigismondo, ai suoi congiunti e ai suoi discendenti fino alla quarta generazione, e organizzò a Roma, sulla pubblica piazza, una sorta di finta esecuzione, durante la quale l’effigie di Sigismondo Malatesta, ritratto a grandezza naturale, venne arsa sul rogo. Non pago di ciò, il pontefice, che desiderava ardentemente la rovina di Sigismondo, promosse anche un’azione bellica contro il signore di Rimini. Sigismondo poteva anche fregarsene della requisitoria, delle accuse, dei roghi sulla pubblica piazza: il problema grosso, per lui, era il suo isolamento diplomatico, retaggio della sua politica estera. E si trovò praticamente solo a combattere contro il papa e i suoi alleati.
Quello stesso anno, l’armata pontificia, guidata dai condottieri Ludovico Malvezzi e Pier Paolo Nardini, occupava la valle del Cesano e marciava verso Rimini. Sigismondo Malatesta passò al contrattacco, sconfisse l’esercito pontificio comandato da Napoleone Orsini a Castelleone di Suasa e occupò Senigallia, ma durante l’estate subì una dura sconfitta alla foce del Cesano da parte del rivale di sempre, Federico da Montefeltro, conte di Urbino, alleato del papa. Nel maggio del 1463, l’esercito pontificio riconquistò Senigallia e riuscì anche a cacciare Sigismondo da Fano, città ch’era da due secoli malatestiana, e che dopo quell’episodio diventò vicariato ecclesiastico staccandosi definitivamente da Rimini. Sigismondo aveva perso la guerra.
Dopo la sconfitta, la Repubblica di Venezia, antica alleata del Malatesta, fece pressioni sul papa affinché non infierisse su Sigismondo e su Rimini: il signore, per evitare di perdere anche la città dopo che i territori della sua signoria erano stati drasticamente ridimensionati dopo la guerra, chiese e ottenne il perdono pontificio. Rimasto isolato, caduto in rovina economica e con un’immagine da riabilitare, decise di prender parte, per conto di Venezia, alla spedizione contro i turchi in Morea, impresa difficile ed estremamente rischiosa, nella quale nessun condottiero avrebbe voluto imbarcarsi: Sigismondo accettò e partì per la Grecia, ma tornò a Rimini senza aver ottenuto quel successo che sperava. Cercò allora d’ottenere qualche beneficio dal successore di Pio II, Paolo II, ma alla fine riuscì solo a conservare la sua città. E forse era abbastanza, per come s’era ridotto.
Sigismondo Malatesta morì nel 1468: quell’anno si sarebbe interrotta anche la vicenda del Tempio Malatestiano. Il cantiere, del resto, s’era già fermato all’epoca degli scontri con Pio II. Non sono rimasti né disegni, né modelli di come avrebbe dovuto essere una volta finito. Ma la grandiosità che avrebbe dovuto emanare è evocata dalla celebre medaglia di Matteo de’ Pasti, l’unico degli artisti di Sigismondo a rimanere accanto al signore fino alla fine. È la sola opera che conosciamo in cui possiamo vedere il Tempio per come avrebbe dovuto essere una volta finito: il registro superiore della facciata avrebbe dovuto concludersi con un grande arco a tutto sesto, raccordato al registro inferiore da due volute che avrebbero decorato le due alzate triangolari. E sul fondo avrebbe dovuto esserci una maestosa rotonda coronata con una cupola, simile a quella del Pantheon di Roma. Il progetto non vide mai la luce, e il Tempio rimase incompiuto, come i sogni del signore che l’aveva fortemente voluto. Un signore condannato dalla storia, e riabilitato solo in tempi recenti. La sua intelligenza e la cui gloria sono però eternate in un Tempio che porta il nome della sua famiglia. Con l’arte, avrebbe scritto D’Annunzio, il “gran tiranno” ha vinto il tempo, e Sigismondo è più vivo oggi “che allor quando correva le cittadi e le province”.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).



































