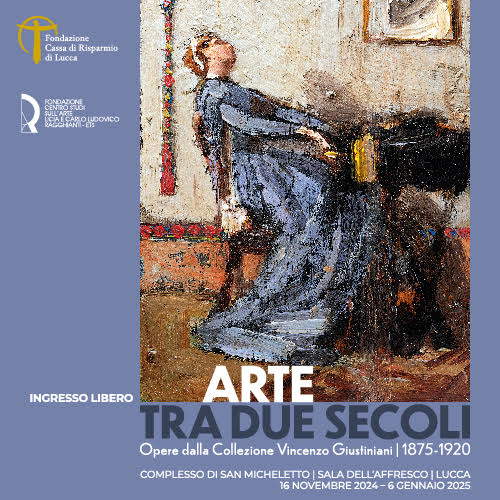Una lezione di danza nella Venezia del Settecento: la celebre opera di Pietro Longhi
Chi voglia conoscere la vita sociale della Venezia del Settecento, entrando nelle case dei nobili e dei borghesi, nei luoghi da loro frequentati, capire come trascorressero le loro giornate, quali fossero le loro attività e quali i loro passatempi, dovrebbe concedersi un’immersione tra i dipinti di Pietro Longhi (Pietro Falca; Venezia, 1701 – 1785), il pittore che più d’ogni altro, e con più costanza, ha saputo raccontare la società della Venezia del XVIII secolo, la Venezia al tramonto della Repubblica: se Canaletto ci ha mostrato le vedute d’una Venezia eternata da una luce tersa e cristallina, se Francesco Guardi ha raccontato quegli stessi luoghi venando i suoi scorci con un’aria d’inconsolabile nostalgia, Pietro Longhi è l’artista che ci spalanca le porte degli edifici dipinti nelle opere dei vedutisti. Ed entrando in una di queste case, non sarebbe stato difficile assistere a una lezione di danza come quella che Longhi dipinge in una delle sue opere più note, La lezione di danza appunto, oggi conservata alla Galleria dell’Accademia di Venezia.
All’interno di un salottino dall’arredamento piuttosto spoglio (giusto un divano foderato di raso verde, lo stesso colore delle tappezzerie, una pesante tenda di velluto sulla destra, un paio di sedute in basso e uno specchio alla parete) assistiamo a una lezione di ballo che una giovane sta ricevendo dal suo maestro, mentre un violinista impartisce il ritmo, defilato, e la madre della ragazza assiste alla scena, seduta sulla sedia. Sopra uno sgabello, il maestro ha appoggiato il suo tricorno, il tipico cappello veneziano a tre punte, e il suo spadino. La pura intimità del quotidiano.

L’opera, di cui si conserva peraltro uno studio con, su una facciata del foglio, lo schizzo della coppia che balla e sul verso le mani del maestro, fa parte di una serie di sei tele che immaginiamo dedicate alle attività giornaliere della dama veneziana: le altre sono il Concertino, il Sarto, la Toeletta, l’Indovino e il Farmacista, tutte di identiche dimensioni e stilisticamente omogenee. L’opera ebbe peraltro una certa fortuna, dal momento che ne fu tratta un’incisione in senso inverso da Jean-Jacques Flipart, e altre versioni ne sarebbero poi derivate negli anni seguenti, realizzate da mani diverse da quelle di Pietro Longhi. La lezione di danza, assieme alle tele compagne, venne poi donata alle Gallerie nel 1838 dal patrizio veneziano Girolamo Contarini (nell’atto notarile con cui la serie veniva offerta all’Accademia, il 1° settembre di quell’anno, le opere vengono indicate come Soggetti famigliari): è probabile che la dama raffigurata da Longhi sia una gentildonna della stessa famiglia Contarini, una delle dinastie nobili veneziane di più antico lignaggio. Ad ogni modo, chiunque sia la giovane che vediamo del dipinto, quel che è certo è che non si sottrae a un obbligo sociale della Venezia del tempo. Per una dama veneziana, partecipare a feste danzanti era infatti un momento fondamentale della propria vita sociale: prendere parte ai balli in società era, per una famiglia patrizia, un mezzo per ostentare la propria ricchezza (attraverso vestiti, gioielli) oltre che per tessere relazioni. Saper ballare, dunque, era requisito base per una dama dell’alta società della Venezia settecentesca.
La Lezione di danza è una delle tante scenette che Longhi ha dedicato alla vita veneziana dando luogo, com’è stato notato, a una sorta di traduzione per immagini della commedia di Carlo Goldoni, coi personaggi che sembrano quasi recitare una parte, muoversi con pose leziose, affettate, poco spontanee, sul palcoscenico della loro esistenza. Goldoni e Longhi, peraltro, si conoscevano, e c’è anche un sonetto del commediografo in cui il pittore viene citato: “Longhi tu che la mia Musa sorella / chiami del tuo pennel che cerca il vero”, un verso in cui Goldoni dimostra come intento dell’artista fosse quello di offrire al riguardante una narrazione realistica di ciò che vedeva, attraverso un’accurata indagine della realtà quotidiana. E che Pietro Longhi fosse attento alla raffigurazione della realtà lo dimostra proprio lo studio, conservato al Museo Correr, in cui l’artista cerca di provare le diverse posizioni della mano del maestro. Un’indagine, quella di Longhi, che s’esprime attraverso una grazia composta, la descrizione minuziosa degl’interni e dei costumi, una vita che sembra scorrere tranquilla.
Il pittore veneziano, ha scritto un suo quasi omonimo, lo storico dell’arte Roberto Longhi, nei suoi dipinti descrive “una cronaca paziente e tenace, in cui il momento ironico è leggero come una bolla di luce subito spenta, descrive le solite azioni della giornata: la toeletta, la opaca conversazione, la lezione di danza, il concertino, o i giochi in casa, l’esame dell’‘andrien’ nuovo portato dal sarto e, magari, preso a credenza, la passeggiata in piazza, alla bottega del caffè, la visita al ridotto”. E come ne La lezione di danza, le donne assumono un ruolo inedito, consapevoli del loro potere d’attrazione sull’uomo, e a Venezia in grado peraltro di godere d’una libertà che non era concessa alle donne che vivevano in altre realtà della stessa epoca. La ragazza al centro del dipinto delle Gallerie dell’Accademia sta prendendo una lezione, ma è lei la vera protagonista della scena, e non solo perché il bianco del suo ricco vestito di raso, bordato d’una curiosa pelliccetta rosa, risalta su questa scena dai toni cupi, rischiarata soltanto dalle luci artificiali dell’ambiente: il suo sguardo, al contempo vezzoso e provocante, incontra e al contempo rifugge quello del maestro, mentre dietro il violinista non può far altro che osservare da lontano le sue movenze. Si respira però, in questo dipinto così come in altri di Pietro Longhi, l’aria d’una società al crepuscolo, l’atmosfera d’una Venezia avviata verso il suo inesorabile, inarrestabile, ineludibile declino: e ce ne accorgiamo guardando quegli stessi personaggi, che ci appaiono così distanti, freddi, inconsapevoli. Non c’è critica, non c’è intento di denuncia nell’opera di Longhi (forse c’è un po’ d’ironia, questa sì), ma più che personaggi reali, i suoi nobili ci sembrano quasi dei manichini che si muovono sulla scena di un teatro.
“Composti in una amenità di ritratto, appena leggermente svagati, i personaggi”, scrive ancora Roberto Longhi, “lasciano che gli oggetti famigliari e l’aria stessa che li circonda dicano la loro storia, la storia senza eroismi e senza fracasso di chi tiene alla reputazione. Sono attori perfettamente responsabili della loro parte, di gesti controllati, e – se parlassero – dalla voce suasiva, raramente forzata. Sono gli attori che recitavano le commedie di Carlo Goldoni, spregiudicate senza scetticismo, spiritose senza le squisitezze del Signor di Marivaux, commosse senza lacrime. Commedie, intanto, della saggia mediocrità umana. E, difatti, non sarebbe punto arbitrario affiggere, sotto molti dei quadretti del Longhi, un titolo che fosse anche quello di certe commedie del Goldoni; o magari una sua battuta; a parte la certezza che i due artisti si considerarono fratelli nell’espressione di quel ‘vero’ che entrambi avevano in mente. Chissà dunque che un simile progetto non li abbia tentati, l’uno o l’altro, e magari tutti e due”. Conoscendo l’acutezza d’entrambi, è del tutto lecito pensarlo.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE
Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta
Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo