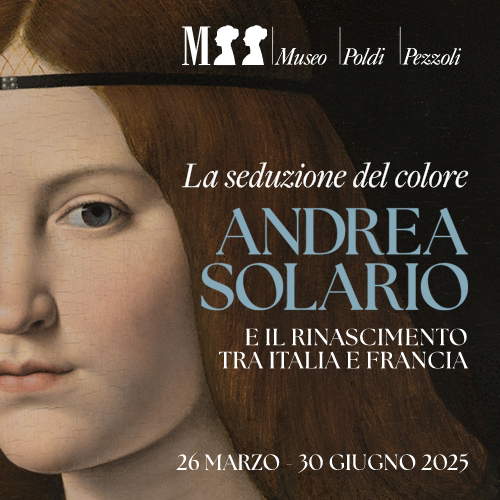Perché c'è un orso incatenato al palazzo di una città del Rinascimento?
Un orso incatenato, legato alla facciata d’un elegante edificio di marmo. Ritto sulle zampe posteriori, aggressivo, nell’atto d’attaccare. Il muso dell’animale che non è contento di quella condizione, della catena che lo tiene fermo lì, attaccato a quel muro. Chissà poi perché. Chissà cosa ci fa un orso legato a un palazzo nel centro d’una città rinascimentale. Chissà perché l’autore del dipinto, forse il romagnolo Girolamo Marchesi da Cotignola, ha deciso d’inserire questo animale, unica presenza animata, in questo dipinto, lo scorcio d’una città immaginaria, una città dove elementi ideali si mescolano a motivi realistici, quasi popolareschi.
L’insolita tavola è stata per lungo tempo conservata nella collezione degli Strozzi Sacrati, parte della quale venne acquistata dallo Stato negli anni Ottanta del secolo scorso, ragione per cui oggi possiamo vedere l’opera alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, assieme a un’altra tavoletta che le fa da pendant, e che dobbiamo immaginare parte d’una serie più estesa, nella quale forse era inclusa anche un’altra veduta, di dimensioni però un poco inferiori, che è ora nelle collezioni della Bper a Modena. Le due tavole ferraresi sono nelle prime sale del percorso della Pinacoteca Nazionale, appese alla parete d’una saletta con poche altre opere. Difficile non notarle, anche se Longhi le aveva sbrigativamente bollate come “scenografie di poca levatura”. Difficile non fermarsi davanti all’animale, provare anche un po’ di pena per lui. Difficile evitare d’immaginare d’essere lì, a camminare per le strade di questa città, inesistente ma così credibile.


Siamo su di una strada sulla quale s’affacciano edifici porticati, su entrambi i lati. Anche se l’idea d’uno scorcio urbano a prospettiva centrale ci rimanda alla cultura rinascimentale urbinate, quelli tra i quali stiamo passeggiando sono palazzi che ci chiamano alla mente l’Emilia. Il portico di legno del primo edificio sulla sinistra ci fa subito pensare a Casa Isolani, a Bologna: era tipica della cultura architettonica bolognese del tempo l’idea d’erigere loggiati di legno sopra corte basi di mattoni. Sul fondo un arco diroccato, una porta come quelle che si potevano trovare lungo le mura di Bologna o di Ferrara, e da sotto le pietre vediamo un altro varco d’accesso alla città, una Porta Galliera dalle forme un po’ più dolci. L’orso è legato a un edificio che trasuda cultura albertiana: c’è chi ha proposto un confronto con la facciata di Sant’Andrea a Mantova, ma forse non è da escludere che l’artista avesse in mente i progetti per il Tempio Malatestiano di Rimini. Nella tavola di sinistra, quella senza orso, vediamo su di un lato una chiesa, che mescola le forme di due chiese veneziane, quelle curve di San Michele all’Isola e le linee spartane e sobrie di San Giovanni Crisostomo. Sull’altro lato, ecco un elegante edificio con una targa che reca la probabile data d’esecuzione dei due dipinti: 1520. A chiudere l’orizzonte è un edificio più sobrio, più rozzo, con un terrazzino di legno sul quale vediamo anche dei panni stesi.
Non sappiamo con certezza a cosa servissero questi dipinti. Forse, ha suggerito Daniele Benati, lo studioso che ha proposto d’attribuire i dipinti al Cotignola, erano inseriti in una boiserie che doveva decorare una qualche sala della casa del committente, forse un camerino, procurando un effetto simile a quello delle tarsie lignee che riproducevano scorci cittadini, spesso attestate nell’arte dell’Italia settentrionale del tempo. Oppure, ha scritto Grazia Agostini, sono da “collegare all’ambiente del teatro e delle scenografie teatrali, probabilmente modelli per una delle scene fisse suggerite dalla tradizione classica ed elaborate alla fine del Quattrocento”. Diversi storici dell’arte hanno legato le tavole a due vedute che Sebastiano Serlio avrebbe incluso nel suo Secondo Libro di Prospettiva, pubblicato nel 1545, anche per la comune presenza d’una scaletta a due rampe che consente d’accedere al piano della strada: una Scena comica e una Scena tragica, due scenografie che il grande teorico dell’architettura aveva immaginato per le commedie e le tragedie che venivano rappresentate nei teatri del tempo. I disegni sono riprodotti anche sulle didascalie che accompagnano le tavole del 1520 nella sala della Pinacoteca. La scena comica di Serlio è un pastiche di stili diversi, di edifici dai caratteri rustici, di abitazioni di privati cittadini in una strada come tante, è l’allegro disordine dei quartieri borghesi. La scena tragica è invece una seriosa, regolare infilata di palazzi nobiliari, è il quartiere della ‘classe dirigente’, potremmo dire.
Scenografie che riflettono le ambientazioni tipiche delle commedie e delle tragedie, dunque. Ma forse non era questo l’intento del pittore che eseguì le due tavole datate 1520. Forse anche lui, come Serlio, aveva letto Vitruvio, si era lasciato ispirare dalle sue idee sulle scenografie, e poi aveva fatto come gli era parso, mescolando alto e basso. Residenze patrizie e palazzoni borghesi coi terrazzi di legno. Facciate di marmo e panni stesi. Chiese eleganti e archi in rovina. Oppure, più semplicemente, aveva attinto dai disegni della folta schiera di scenografi attivi nel primo Cinquecento, o dalle opere degli intarsiatori che lavoravano per i cori delle chiese (l’esempio cronologicamente e geograficamente più vicino alle due tavole è il coro che Paolo Sacca eseguì nel 1518 per la chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, dove non manca la veduta di città), ed ebbe l’idea di tradurre tutto in pittura. Senza la coerenza delle scene teatrali, e senza l’aura astratta delle città ideali. Forse, l’intenzione del pittore era banalmente quella di riprodurre, nel limitato spazio della sua tavola, il più grosso numero possibile di palazzi che si potevano vedere in una città del secolo XVI, probabilmente con intenti allegorici, dacché la compresenza d’edifici nuovi e strutture in rovina era un topos dell’arte ferrarese del tempo.
Sono però supposizioni. Si potrebbe sapere forse qualcosa in più se si conoscesse l’identità dell’autore. Ma, anche qui, non c’è accordo tra gli studiosi. Benati, come s’è anticipato, ha avanzato il nome di Marchesi da Cotignola sulla base delle similarità con la predella dello Sposalizio della Vergine dipinto dal romagnolo e oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna: ci sono architetture simili, e poi le vedute di Ferrara hanno un’aria vagamente onirica che poco s’addice all’indole tecnica d’un architetto. C’è chi, come Sabine Frommel, ha proposto di assegnare le opere allo stesso Sebastiano Serlio. Giuliana Marcolini, nel catalogo della collezione Sacrati Strozzi, ha messo davanti al nome delle opere la formula “Giolamo Marchesi, attribuito a, e/o Sebastiano Serlio, attribuito a”. Tradotto: il massimo della prudenza, per non escludere l’attribuzione all’uno o all’altro, e neppure una possibile collaborazione. Con Serlio che magari ha fornito i disegni, o comunque una qualche idea tracciata su carta, e Marchesi che li ha tradotti.
Ma poi, alla fine, l’orso cosa c’entra in tutto questo? C’è, effettivamente, un’opera a cui appigliarsi: è una tarsia di Damiano Zambelli, che raffigura il Battesimo di san Domenico e che venne eseguita negli anni Trenta del Cinquecento per la cappella che accoglieva le spoglie del santo nella basilica di San Domenico a Bologna. Anche lì si vede un orso legato a un palazzo: è vicino a un gruppo di artisti di strada, all’epoca non era strano imbattersi in girovaghi che portavano in giro per le città orsi ammaestrati che ballavano davanti a un pubblico. È opinione piuttosto diffusa che il disegno per la tarsia spetti a Serlio. Però è un’opera molto più tarda delle due tavole di Ferrara: risale, è stato notato, alla stessa epoca in cui Baldassarre Peruzzi, amico di lunga data di Serlio, lavorava per la famiglia Cesarini, che nello stemma aveva un orso legato alla colonna. Sono però vicende che risalgono almeno a dieci anni dopo le tavole di Ferrara. L’orso di Ferrara potrebbe comunque essere un elemento utile per ricondurre le due tavole a Sebastiano Serlio. Solo che per adesso non parla. Non sappiamo se sia un’allegoria, se si riferisca a uno stemma gentilizio, se sia collegato alla tarsia di San Domenico e dunque sia una nota di colore, l’animale di una compagnia di artisti di strada, oppure banalmente il guardiano del palazzo, come ha suggerito lo studioso Richard J. Tuttle. È sicuro che l’artista non lo ha inserito per caso. Ma il motivo ancora ci sfugge.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).