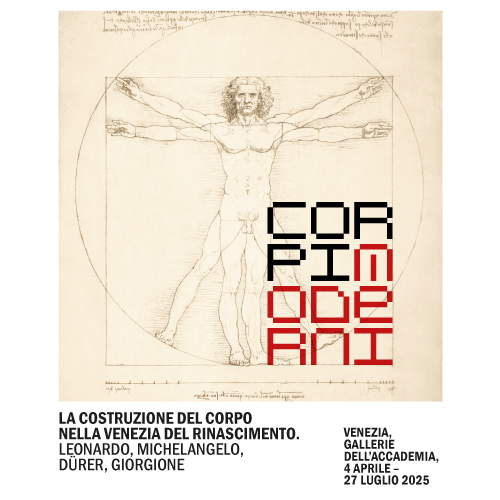La Madonna di Simone dei Crocifissi e un volo di fantasia tra le pagine di Marco Santagata
Esistono davvero gli affreschi attorno ai quali ruota tutta la vicenda del romanzo che, nel 2003, è valso a Marco Santagata il Premio Campiello, Il maestro dei santi pallidi. Decorano due piccole chiesette di montagna nell’Appennino modenese: le figure dell’oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano nel villaggio di Riva sono, nella finzione, le prime che il piccolo Cinìn vede in vita sua e che, fin dal primo incontro, lo infiammano d’amore per la pittura. Gli affreschi della chiesetta di Monteforte sono invece quelli che Cinìn dipingerà verso la fine del racconto, dopo aver conosciuto una serie di circostanze fortuite che trasformeranno il povero guardiano di vacche in un maestro riconosciuto e appassionato. Sono modesti cicli di mani ignote, opere di due distinti pittori che lavorarono verso la metà del Quattrocento, attestandosi su di un linguaggio marcatamente vernacolare, da pittori montanari ancora legati a modi arcaici, sostanzialmente esclusi da quanto accadeva nello stesso torno d’anni nelle città di pianura, o tutt’al più in grado d’avvertirne solamente un’eco fioca e ovattata. Non conosciamo i nomi del maestro della Riva e del maestro di Monteforte: è Marco Santagata che s’è inventato una storia per loro, tratteggiando le personalità di Giberto della Porretta e del suo allievo, il povero Cinìn, che diventerà l’apprezzato maestro Gennaro e che, a seguito d’una lunga sequela di traversie da romanzo picaresco, troverà la prima occasione importante della sua carriera nella decorazione ad affresco del minuscolo oratorio di Monteforte, su commissione della contessa di Renno.
Ma prima d’entrar nella bottega di maestro Giberto, il giovane Cinìn era entrato a far parte della servitù della contessa. E se n’era innamorato: e per lui, che nel frattempo aveva preso a esercitarsi nel disegno replicando ovunque le figure della chiesa di Renno, col carbone, su qualunque sasso gli capitasse a tiro, la contessa era diventata una specie di fissazione monomaniacale. “Smise di copiare santi e animali, e su tutte le superfici che trovava cominciò a disegnare con furia ossessiva l’immagine della Madonna: il viso ovale, gli occhi grandi, il naso dritto e un punto nero in mezzo alla fronte”. Per buona parte del romanzo, l’unico disegno che Cinìn traccia sulle pietre è il volto della Madonna, che assume le sembianze del profilo nobile e delicato della bionda contessa.
Volendo far decollare un volo di fantasia, si potrebbe pensare di dar delle sembianze reali alla contessa, trovando un suo corrispettivo in una qualche Madonna dell’epoca di Cinìn. E ce ne sono diverse che si potrebbero imbarcare su questo volo: si potrebbe scegliere, per esempio, una delle tante dipinte da Simone dei Crocifissi. Come quella, splendida ed elegante, conservata alla Galleria Estense di Modena: quella che tiene tra le mani un Gesù bambino dispettoso, che guarda la madre con uno sguardo complice mentre smanaccia toccando il volto di uno degli angeli.
 |
| Simone dei Crocifissi, Madonna col Bambino in trono fra angeli (1390-1399 circa; tempera su tavola, 96 x 59; Modena, Galleria Estense) |
È vero: è un’opera che precede d’una cinquantina d’anni la storia raccontata da Santagata, e Simone, al contrario di Cinìn, è un pittore di città, che vive pertanto in un mondo totalmente diverso rispetto a quello del protagonista del romanzo. Ma Simone dei Crocifissi ha qualcosa da condividere con il Cinìn “dei santi pallidi”: le origini tutt’altro che altolocate (per Francesco Arcangeli, Simone era “il rustico figlio del calzolaio Filippo”), la prolificità, la curiosità, l’avvicinamento ai modi dei pittori toscani coevi, e financo la composizione della clientela, dato che il Cinìn di Santagata lavora sia per le chiesette del contado, sia per i signori che d’estate si bagnano alle terme di Porretta. E poi, il “maestro dei santi pallidi” aveva la sua mesticheria a Bologna: ci piace dunque pensare che, recandosi in città, possa aver visto qualcosa di Simone.
La tavola di Modena appartiene all’ultima fase della produzione di Simone, quella più seriale e forse scontata, ma anche quella più fortunata, dacché era diventato uno dei pittori più richiesti di Bologna ed era riuscito ad avviare una bottega che licenziava opere di continuo: e per questo Simone fu, con tutta probabilità, il pittore più produttivo di tutto il Trecento bolognese. Ciò nondimeno, riusciva ancora a esprimere una pittura che sapeva raggiungere esiti qualitativi che s’innalzano sopra la produzione dello stesso periodo, degli anni Novanta del Trecento: e questa tavola gli è sempre stata riconosciuta come d’una qualità e d’una finezza maggiori rispetto alle altre opere che andava eseguendo in quello stesso tempo. È anche firmata: alla base del trono vi leggiamo, in caratteri gotici minuscoli, “Simon fecit hoc opus”, formula che il pittore bolognese adoperò svariate volte. Per Daniele Benati, il continuo ricorso alla firma è sintomo d’un “surplus d’intelligenza autopromozionale” (così scrive nell’introduzione alla prima monografia su Simone, opera di Gianluca Del Monaco pubblicata nel 2018), e l’artista appone il suo nome a opere d’impegno vario, ma sempre mirando “a rimarcare la propria pretesa eccellenza”. Per lo studioso, il nome così frequente è anche alla base del suo nomignolo “dei Crocifissi”, che gli viene “appioppato” (così lo stesso Benati) in età di Controriforma, e che tuttora lo distingue. Addirittura Simone, fa sapere Del Monaco, arrivava a firmare anche opere di bottega dall’esito tutt’altro che felice, con l’obiettivo di “venire incontro alle richieste del mercato”.
Nella tavola della Galleria Estense, Simone non lesina sull’oro: evidentemente l’opera era destinata a un committente che poteva permettersi di non curarsi delle spese. L’oro abbonda anche sugl’indumenti della Vergine: sulla veste oltremare, sul manto bianco elegantemente foderato di rosso che, nonostante la rovina della superficie pittorica, ancora ci trasmette la sapienza dei trapassi di luce e ombra, e poi ancora sulle fini bordature, sul drappo che gli angeli sollevano per coprire lo schienale del trono. La figura della Vergine assisa tocca vertici di monumentalità anch’essi tipici dell’ultimo Simone. Ma è un Simone che, nonostante sia in grado di restituirci una Madonna dal profilo aristocratico e quasi austero, certo una delle Madonne più nobili della sua pittura, non abbandona la sua vivace espressività, sintomo più evidente della sua formazione bolognese vicino a Vitale degli Equi. E il suo Bambino che guarda la mamma, come soddisfatto per il suo scherzo all’angelo, che peraltro non fa una piega, strappa sorrisi a chiunque ammiri questa tavola. Un dettaglio che conferisce all’atmosfera quel senso d’intimità familiare che non doveva dispiacere al committente, probabilmente un ricco borghese di Bologna, che per mezzo dei due angeli che suonano una viella e un chitarrino avrà di sicuro desiderato celebrare la felicità della sua esistenza anche per tramite della musica.
Simone tuttavia si distingue da Vitale per il più marcato ed evidente senso plastico che caratterizza le sue figure, inclusa la bionda Madonna della Galleria Estense, col suo viso ovale, i suoi grandi occhi a mandorla, il suo naso dritto, e con la sua figura imponente. Come il Cinìn di Santagata, alla metà del Quattrocento, non si dimostra insensibile a Masaccio e alla Trinità di Santa Maria Novella conosciuta durante un viaggio a Firenze, così Simone non rimase impermeabile alla lezione giottesca, accolta col tramite d’altri artisti felsinei, sebbene modulata secondo il suo gusto conservatore. Un gusto che lo portava a popolare le sue tavole di madonnine che sapevano essere dolci e signorili come quella di Modena. A quell’epoca, a Bologna non c’era una corte: eppure, forse la ricercatezza e l’affabilità di certe tavole bolognesi, come quella di Simone, potrebbero suggestionarci e far correre l’immaginazione a quelle storie di bovari che diventan pittori, di contese feudali tra signorotti della montagna, di contesse che compaiono nei volti delle Vergini, di figure che affascinano i fedeli degli oratorî di campagna, in due parole a quel mondo di meraviglie quasi fiabesche evocato dalle pagine del romanzo di Santagata.
Se ti è piaciuto questo articolo, leggi i precedenti della stessa serie: il Concerto di Gabriele Bella; la Ninfa rossa di Plinio Nomellini; l’Apparizione di Cristo alla madre del Guercino; la Maddalena di Tiziano; le Mille e una notte di Vittorio Zecchin; la Trasfigurazione di Lorenzo Lotto; il Tobia e l’angelo di Jacopo Vignali; il Profumo di Luigi Russolo; Novembre di Antonio Fontanesi; i tondi di san Maurelio di Cosmè Tura.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).