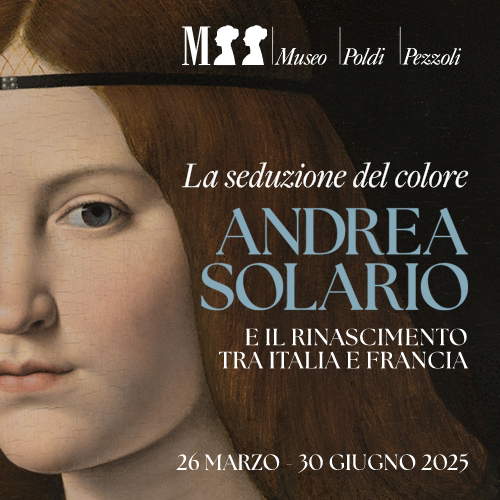L'immagine del potere. Il ritratto di Eleonora di Toledo a Pisa
L’immagine più celebre di Eleonora di Toledo, nata Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, moglie di Cosimo I de’ Medici e duchessa consorte di Toscana, è sicuramente quella dipinta dal Bronzino e oggi conservata agli Uffizi: il Ritratto di Eleonora di Toledo con il figlio Giovanni de’ Medici è del resto uno dei capolavori della ritrattistica cinquecentesca, uno dei ritratti più celebri della storia, immagine eloquente del potere mediceo e testimonianza dell’eleganza della corte fiorentina. Non è però l’unico ritratto della duchessa: a Pisa, il Museo Nazionale di Palazzo Reale conserva un altro celebre ritratto di Eleonora, che si fa raffigurare, assieme al figlio Francesco, erede del ducato di Toscana, sempre dal Bronzino, qui coadiuvato dalla sua bottega. Qual era il significato di queste immagini? Si trattava, sostanzialmente, di ritratti di Stato, ritratti ufficiali che ricoprivano un importante ruolo politico nella Firenze ducale, all’indomani della caduta della Repubblica fiorentina il 12 agosto del 1530. In questo contesto storico, ha spiegato lo studioso Philippe Costamagna, venne “sconvolta quella che era stata la funzione stessa dell’opera pubblica, e in particolare del ritratto: le raffigurazioni allegoriche del nuovo capo della nazione dovevano legittimarne la presa di potere”. Sono da leggere in questo senso i ritratti del primo duca, ovvero Alessandro de’ Medici, come quello dipinto da Giorgio Vasari nel 1534, in cui il giovane regnante viene raffigurato in armatura per sottolineare il suo ruolo di difensore della patria, e assieme a numerosi elementi che dovevano farsi simbolo delle sue qualità e del dominio mediceo sulla Toscana. Dalla ritrattistica allegorica, legata a esigenze di legittimazione del nuovo potere mediceo, si passò poi nel volgere di pochi anni a una più “istituzionale”, se così si può dire, ritrattistica di Stato: l’esigenza non era più quella di “legittimare l’ascesa al potere del duca attraverso un ritratto allegorico”, spiega Costamagna, “ma piuttosto di veicolare l’immagine di un principe regnante”. È in questo secondo ambito che ricadono i ritratti di Eleonora.
La svolta è da collocare all’inizio degli anni Quaranta del Cinquecento, quando il Bronzino attese alla realizzazione del primo ritratto di Eleonora di Toledo, destinato alla residenza di Poggio a Caiano, e oggi identificato come il quadro che si trova alla Národní Galerie di Praga, risalente al 1543. Si trattava, tuttavia, non di un ritratto ufficiale, ma di un’immagine destinata a una visibilità privata, alla residenza del duca: ciò nondimeno, questo ritratto, sensibilmente più piccolo rispetto a quelli più noti come il ritratto degli Uffizi o il ritratto di Pisa, fu il primo modello per l’immagine della duchessa. Di lì a poco, il Bronzino avrebbe messo a punto l’iconografia ufficiale della coppia regnante, presentando al duca i due “prototipi” della ritrattistica di Cosimo ed Eleonora, ovvero il Ritratto di Cosimo I in armatura oggi alla National Gallery of South Wales di Sydney, e il celeberrimo ritratto di Eleonora col figlio Giovanni conservato agli Uffizi. Fissata l’iconografia ufficiale, le repliche (autografe, eseguite dalla bottega o da altri artisti) avrebbero decorato le residenze ducali, le sedi governative toscane, o sarebbero state inviate in Europa a titolo di dono diplomatico. Sono dunque numerosissime le repliche del duca, mentre minore è il numero delle repliche del ritratto di Eleonora, ma il ritratto di Pisa ha un ruolo ancora diverso in questo contesto.

Nel gennaio del 1550, infatti, il Bronzino stava lavorando al prototipo di un nuovo ritratto ufficiale, nel quale la duchessa sarebbe stata raffigurata assieme al figlio Francesco, il primogenito della coppia e dunque erede al trono ducale (sul quale sarebbe salito a ventitré anni, nel 1564). Il ritratto era destinato al vescovo di Arras, Antoine Perrenot de Granvelle, personaggio di spicco della corte imperiale: era infatti uno dei più fidati consiglieri dell’imperatore Carlo V. Sappiamo che, il 21 dicembre 1549, il segretario di corte fiorentino, Lorenzo Pagni, scriveva da Pisa al maggiordomo di Cosimo, Pierfrancesco Riccio, per informarlo che “per commodità del Bronzino, et per più celere speditione de’ ritratti […] che il vestimento della duchessa non si facci di broccato riccio ma di qualche altro drappo ornato che facci bella mostra”. L’opera dunque era all’epoca ancora in fase di realizzazione (il Bronzino, come appare anche da questa lettera, era tanto meticoloso da risultare... lento agli occhi dei committenti). La scelta del figlio con cui Eleonora si faceva accompagnare nei ritratti dipendeva essenzialmente dall’obiettivo politico dell’icona. Scegliendo il secondogenito maschio, Giovanni, che compare nel ritratto degli Uffizi, i Medici volevano sottolineare un aspetto fondamentale della loro politica, ovvero la continuità dinastica, dal momento che il secondogenito era considerato, secondo la mentalità del tempo, una sorta di assicurazione sul primogenito. E una dinastia della quale veniva garantita la continuità era anche sintomo di stabilità politica: questa l’idea che il ritratto intendeva trasmettere. La scelta del primogenito Francesco che si vede nel ritratto di Pisa era invece funzionale a far risaltare la figura stessa dell’erede al trono. Inoltre, gli stessi gesti di Francesco, che indica se stesso ma rivolge anche la mano verso il ventre della madre, vogliono sottolineare non soltanto il suo ruolo di erede al trono e quindi di futuro duca, ma intendono anche esaltare il ruolo di Eleonora come genitrice premurosa che garantisce, ancora, la continuità dinastica: la vediamo infatti probabilmente incinta del settimo figlio, Ferdinando.
Oggi non sappiamo se il dipinto di Pisa è da considerare come il ritratto eseguito per il vescovo di Arras o, com’è più probabile, una replica autografa eseguita per una residenza ducale, ma certo è che si tratta d’uno dei più squisiti ritratti del Bronzino, sebbene condotto con aiuto di bottega per ragioni di urgenze di consegna. Nell’elaborazione dell’immagine, un ruolo non secondario era ricoperto dalle vesti indossate. Gli abiti dovevano infatti comunicare lusso, eleganza e potere. Per il ritratto degli Uffizi era stato scelto il famoso abito di “broccato riccio”, il tessuto più lussuoso, ma anche quello più difficile da dipingere. Per il dipinto di Pisa, come si apprende dalla lettera del segretario ducale, serviva un abito che consentisse al Bronzino di eseguire il dipinto più rapidamente. Gli abiti di Francesco furono scelti direttamente da Eleonora di Toledo, che per il piccolo erede, all’epoca di nove anni d’età, scelse un saio di velluto rosso da coprire con un soprabito di raso, possibilmente bordata d’ermellino o di martora (scelta poi non rispettata, come si vede dall’immagine, perché il soprabito non ha bordature in pelliccia). Il vestiario, lo stesso che Francesco probabilmente indossava l’anno prima a Genova durante un ricevimento in onore del principe spagnolo Filippo II, al quale il piccolo venne presentato: era la sua prima missione ufficiale. L’idea era dunque quella di commissionare al Bronzino un ritratto che riflettesse, ha scritto lo storico dell’arte Bruce Edelstein “il nuovo ruolo pubblico del principe quasi novenne e una nuova fase nella carriera della duchessa”, ovvero una educatrice attenta e ferma (qualità sottolineata anche dalla sua posa ben eretta), il cui ruolo nel governo era indispensabile per preparare il figlio ad assumere in futuro la carica di duca.



Per se stessa, Eleonora scelse invece una zimarra, una veste lunga, priva di tagli alla vita, caratterizzata da maniche ampie con rigonfiamenti all’altezza della spalla, di origini orientali (venne probabilmente introdotta in Europa a partire dalla Spagna) e all’epoca non ancora molto diffusa in Toscana, dove arrivò proprio con Eleonora che, com’è noto, seppe anche stabilire mode nel vestiario. Sotto alla zimarra, Eleonora indossa una sottana, da non intendersi tuttavia nel senso contemporaneo del termine: all’epoca, la sottana era una lussuosa veste di velluto con applicazioni in raso che s’indossava sotto al soprabito (ovvero sotto alla zimarra, in questo caso). Sopra alla sottana ecco invece una gorgiera fatta con una rete d’oro e perle cucita sopra un tessuto di lino bianco, ideale per coprire la pelle.
Il Museo Nazionale di Palazzo Reale a Pisa conserva una “sottana con la coda” del 1560 circa che si vuole appartenuta a Eleonora di Toledo, e che è simile a quella che la duchessa indossa nel dipinto. Opera della bottega di Agostino da Gubbio, uno dei maggiori sarti del tempo, oltre che sarto di Eleonora (la sua attività è documentata dal 1533 al 1566), l’abito, in velluto rosso cremisi, era parte del corredo di una statua lignea della Vergine Annunciata che si trovava nella chiesa di San Matteo a Pisa. La famiglia aveva uno stretto rapporto con il convento di San Matteo, vicino al quale la famiglia risiedeva. Eleonora, poi, aveva un rapporto molto stretto con Pisa: era qui che si trovava la residenza invernale dei Medici (scelta da Cosimo in ragione del clima più mite nella brutta stagione, rispetto a quello di Pisa), in quello che è oggi il Palazzo della Prefettura, e inoltre fu a Pisa che venne organizzato il primo corteo nuziale per la coppia quando Eleonora sbarcò nel 1539 per la prima volta in Toscana.
Restaurato nel 2000, quando venne restituito alla sua forma originale, l’abito è probabilmente tra le tante sottane che Eleonora possedette (particolarmente frequenti quelle rosse, colore tipico di chi regna, anche se erano in maggior numero quelle in raso rispetto a quelle in velluto), ma non siamo certi del fatto che appartenesse proprio alla duchessa: forse, ha ipotizzato la studiosa Roberta Orsi Landini, per quanto simile agli abiti appartenuti a Eleonora di Toledo (la sottana di Palazzo Reale differisce infatti per alcuni dettagli dalle sottane che sappiamo essere appartenute alla duchessa: per esempio, si nota un minor impiego dell’oro), potrebbe essere stato all’epoca indossato da qualcuno della “famiglia” ducale, quindi una delle figlie, una damigella oppure qualche donna della servitù di Eleonora di Toledo: Agostino da Gubbio, infatti, realizzava vestiti non soltanto per la duchessa, ma per tutta la corte. Si tratta ad ogni modo di un abito di lusso, confezionato a partire da modelli in tela o in carta, e che finì nella chiesa di San Matteo come probabile ex voto. E poi, si tratta di una importantissima attestazione della moda femminile alla corte di Cosimo I, che si può vedere tuttora esposta al Museo di Palazzo Reale vicina al ritratto di Eleonora, nella Sala degli Arazzi.


Nel ritratto di Pisa, ha notato Orsi Landini, Eleonora e il figlio condividono lo stesso schema vestimentario: “velluto per il saio di lui e la sottana di lei, raso per la roba di lui e la zimarra di lei, rispettivamente in cremisi e ‘pagonazzo’. Per entrambi le decorazioni sono in oro: galloni per il bambino, ricamo in applicazione di vergola o treccia d’oro a disegno di intrecci per Eleonora, uguali o molto simili per i due distinti capi che compongono l’abbigliamento maschile e femminile, secondo il gusto consolidato a corte in quegli anni”. La scelta del colore “pagonazzo”, un rosso cremisi, risponde più a necessità artistiche che a esigenze di realismo, dal momento che il rosso degli abiti veri era leggermente diverso rispetto a quello che osserviamo nel dipinto, dal momento che all’epoca la duchessa preferiva altre tonalità. Naturale dunque pensare che il rosso del dipinto, più acceso rispetto a quello degli abiti veri, dovesse avere funzioni rappresentative e simboliche.
Come riusciva, infine, la duchessa a non urtare la sensibilità dei fiorentini esibendo sempre vesti sontuose, costosi gioielli e ricchissimi ornamenti? Se, in effetti, all’inizio i fiorentini furono diffidenti nei confronti di quella duchessa arrivata dalla Spagna, presto cominciarono ad apprezzare Eleonora, e i rapporti tra la duchessa e i sudditi furono sempre buoni. Il punto è che, nonostante le apparenze e nonostante l’immagine di Eleonora di Toledo che si è fissata nei nostri ricordi, la duchessa, nel suo quotidiano, conduceva una vita relativamente modesta anche per non intaccare la propria immagine, per non scalfire quell’idea di virtù che voleva trasmettere ai suoi sudditi. Allora come oggi, la costruzione dell’immagine d’un politico non tralasciava alcun elemento, dal comportamento nel pubblico e nel privato fino ai ritratti ufficiali.
Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!
La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERGli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta
Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo