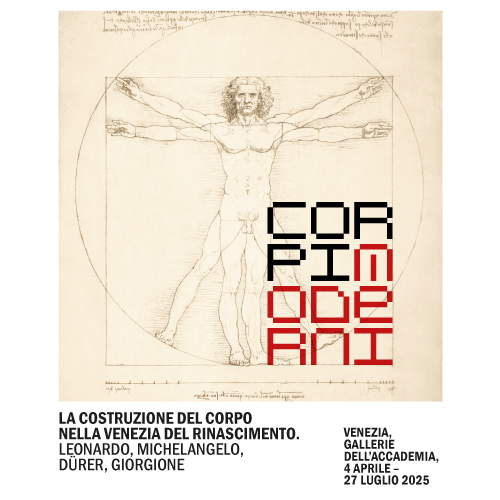Un capolavoro di seta e damasco: Tobia e l'Angelo di Jacopo Vignali
Esiste una precisa ragione, teologica e politica, che motiva la frequente presenza d’opere che hanno per protagonisti Tobia e il suo angelo in pressoché tutte le raccolte italiane che includano un cospicuo numero d’oggetti del Seicento. Il fatto è che le ali più intransigenti della Riforma protestante avevano rifiutato la credenza nella custodia angelica del singolo fedele, ch’era invece uno dei più solidi fondamenti della chiesa romana, affermato con convinzione fin dai tempi della patristica. Nella sua Instutio, Calvino aveva espressamente negato l’idea che ogni cristiano abbia il proprio angelo custode, discutendo tutti i passaggi dei testi neo e veterotestamentarî sui quali i cattolici s’erano basati per sostenerla. Se Gesù Cristo, nel vangelo di Matteo, aveva detto che gli angeli dei bambini vedono di continuo il volto di Dio, ciò non significa che ogni piccolo abbia il proprio. Se negli Atti degli Apostoli i compagni di Pietro riconoscono l’angelo che gli è stato assegnato, ciò non significa che quell’angelo fosse il suo custode perpetuo. E via dicendo: su questi assunti, la discussione sarebbe proseguita a lungo anche nel secolo diciassettesimo. E ai testi dei teologi riformati, i cattolici romani opponevano con fermezza il racconto contenuto nel libro del profeta Tobia, premurandosi di farlo adeguatamente illustrare dagli artisti. Sculture, affreschi, dipinti, opere a stampa: non c’era mezzo che non venisse impiegato per diffondere la storia del leggendario, avventuroso viaggio che il giovane Tobia intraprese assieme al suo angelo guardiano, l’arcangelo Raffaele, per curare il padre Tobi.
Nel 1622, quando Jacopo Vignali eseguì il suo Tobia proveniente dalle collezioni del cardinal Carlo de’ Medici e oggi conservato nella Pinacoteca di Palazzo Mansi a Lucca, la vexata quaestio della custodia angelica era ancora tema d’attualità, e nella Firenze dei primi decennî del Seicento si continuava a praticare una luminosa pittura d’evidente ispirazione controriformata. Non di rado poi i dipinti assumevano ulteriori accezioni: l’opera di Lucca appartiene a una serie di varianti dello stesso tema, la più significativa delle quali è la tela dipinta l’anno successivo da Vignali per la Spezieria di San Marco, in un ciclo centrato sulle guarigioni miracolose, quale fu la cura che, nel libro di Tobia, permise al padre del profeta di riacquistare la vista perduta. Il primo biografo di Vignali, Sebastiano Benedetto Bartolozzi, autore d’una Vita di Jacopo Vignali pittor fiorentino scritta, menziona l’opera come un “arcangiolo Raffaello che col giovinetto Tobiolo separa il pesce acquistato sulle rive del Tigri per trarne il medicamento con cui dovevasi risanare dalla sua cecità il vecchio Tobia”. Ed è questo, in effetti, il momento che l’elegante pittore di Pratovecchio coglie: il giovane Tobia (o “Tobiolo”, alla fiorentina, com’eran soliti nominarlo i testi antichi per non confonderlo col padre quasi omonimo) è intento ad aprire il pesce con un coltello, per estrarne l’unguento medicamentoso: sotto il gomito ha già pronto il vasetto dove sarà riposto il fiele miracoloso. L’angelo guida lo aiuta nell’operazione, tenendogli un lembo della pelle del pesce, e il fedele cagnolino, che accompagna Tobia e Raffaele lungo il viaggio, guarda con viva ed evidente curiosità, poggiando le zampette sulla roccia dove il profeta ha sistemato il grande pesce, che l’aveva assalito durante il cammino, e contro il quale, spronato da Raffaele, Tobia aveva combattuto, per poi al fine sconfiggerlo e, sempre dietro suggerimento dell’angelo custode, privarlo delle interiora per trarne il singolare farmaco.
 |
| Jacopo Vignali, Tobia e l’angelo (1622; olio su tela, 132,8 x 164,5 cm; Lucca, Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi) |
Sino a questo punto, potrebbe esser la descrizione d’uno tra i tanti dipinti che nel Seicento affrontarono il soggetto di Tobia colto mentre lavora il pesce per trovare la cura che avrebbe permesso al padre di continuare a vedere. Ma Vignali, pittore devoto, riesce a esaltare un tema divenuto ordinario confezionando un dipinto d’equilibrata grazie e impareggiabile eleganza, ammantandolo di quella ricercata raffinatezza che sempre avrebbe costituito il tratto più distintivo del suo pennello, tanto che per alcuni Vignali potrebbe apparire un artista lezioso, eccessivamente languido, troppo vicino al sentimentalismo e alle morbidezze devozionali d’un Francesco Curradi, pittore cui Vignali s’era avvicinato proprio nel secondo decennio del Seicento, a un segno tale da portare uno storico dell’arte come Carlo Del Bravo a indicare, nel Tobia e l’angelo, il prodotto d’un’eccessiva cessione alle “minuterie” del più anziano collega. Un temperamento malinconico, quello che traspare dalla tela lucchese, che anche Franca Mastropierro riconosceva a Vignali: e lo riconosceva come evidenza d’una temperie condivisa con Curradi.
Eppure Vignali è un pittore che sorprende per la varietà della sua tavolozza, per la resa tattile dei tessuti di seta che abbondano nei suoi dipinti e per l’inventiva con la quale sempre seppe abbigliare i suoi eleganti personaggi, e poi ancora per le sue originali ricerche sulla luce, per gli ombrosi brani di paesaggio nei quali le figure vengono inserite. Nel dipinto lucchese, ad esempio, Vignali dimostra d’essere uno dei più originali interpreti del Guercino a sud di Bologna: i brani di luce viva, modulati secondo intensità diverse, che s’alternano a pesanti macchie di penombra con trapassi repentini, convivono armoniosamente col preziosismo della pittura del Seicento fiorentino, che Vignali seppe far suo, e lo dimostrò anche nel dipinto di Palazzo Mansi. E anche questo preziosismo, che si traduce in un trattamento quasi edonistico delle stoffe, lussuose, verosimiglianti e descritte con una minuzia che quasi poteva scadere nell’eccentrico, ha alla base precise motivazioni. Da una parte quelle storiche, e cioè il diffondersi della conoscenza in Toscana della pittura del Correggio e dei Carracci, dai quali i pittori fiorentini mutuarono una ricercatezza condotta fino agli esiti più minuti. Dall’altra quelle sociali, dacché neppure tra Cinque e Seicento, in pieno clima controriformato, la nobiltà fiorentina volle rinunciare a quei ricchi abiti confezionati con velluti, sete e damaschi pregiati il cui mercato, agli albori del nuovo secolo, era anzi alquanto fiorente. E la ricerca di questa produzione di lusso non poteva non riflettersi sulla pittura coeva.
Ed ecco dunque perché due personaggi biblici, anche nel mezzo d’un viaggio lungo, solitario e pericoloso, non perdono la loro eleganza: anzi, sono pulitissimi, neppure recano in volto segni di stanchezza, ma si muovono con sciolta naturalezza nei loro abiti ricercati. Tobia indossa una mantella damascata, scarlatta, stretta in vita da una raffinatissima sciarpa auriserica verde, quasi dello stesso colore della tunica, anch’essa di seta, che scende formando pieghe nette. L’angelo è ancora più riccamente abbigliato: una tunica di seta gialla, fermata sulle spalle con una borchia decorata con un rubino, lascia intravedere elaboratissime maniche a sbuffo di prezioso tessuto perlaceo, ricamato con motivi floreali in seta dorata. E poi, il collare bianco alla moda secentesca, e la coperta blu a motivi dorati, anch’essa di seta spessa, con la quale Raffaele siede sulla roccia per non sporcare il prezioso abito di sartoria: squisite finezze del Seicento fiorentino.
Ed è per Lucca una fortuna che Vignali sia stato un pittore prolifico e che per di più abbia redatto diverse varianti dello stesso dipinto: altrimenti, forse la raccolta di Palazzo Mansi non avrebbe mai ricevuto il Tobia e l’angelo dopo l’annessione della città murata al Granducato di Toscana. Era successo che Carlo Ludovico Borbone, sovrano di quel Ducato di Lucca creato nel 1815 al Congresso di Vienna, a spregio della pluricentenaria storia repubblicana della città, per debiti di gioco s’era venduto gran parte delle raccolte ch’erano depositate a Palazzo Ducale, frutto di secoli di collezionismo privato e committenze religiose. Dopo l’annessione, i lucchesi supplicarono il granduca di Toscana, Leopoldo II, affinché ristorasse Lucca delle perdite, regalando alla città opere che, seppur non direttamente legate alla storia del collezionismo locale, potessero rimpiazzare degnamente quanto l’improvvido duca s’era giocato. Leopoldo acconsentì, anche perché lo ritenne politicamente vantaggioso. E di quelle ottantadue opere che il granduca donò e che oggi compongono la Pinacoteca di Palazzo Mansi, faceva parte anche il capolavoro di Jacopo Vignali.
Se ti è piaciuto questo articolo, leggi i precedenti della stessa serie: il Concerto di Gabriele Bella; la Ninfa rossa di Plinio Nomellini; l’Apparizione di Cristo alla madre del Guercino; la Maddalena di Tiziano; le Mille e una notte di Vittorio Zecchin; la Trasfigurazione di Lorenzo Lotto.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).