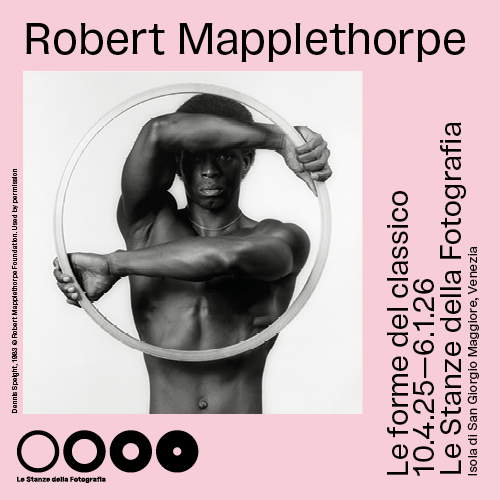Il Museo delle Sinopie di Pisa: viaggio in un patrimonio unico
Ci sono storie che emergono attraverso la tragedia e immagini che affiorano solo quando la materia che le copre viene strappata via con forza. È il caso delle sinopie del Camposanto Monumentale di Pisa: opere che non erano mai destinate ad apparire, e che oggi formano una delle collezioni più rare e affascinanti al mondo. L’attuale Museo delle Sinopie di Pisa si trova in un edificio di grande valore storico: l’antico Spedale della Misericordia, costruito nella seconda metà del XIII secolo su progetto dell’architetto Giovanni di Simone. L’edificio stesso è una testimonianza del passato, un esempio dell’architettura gotica pisana, con le sue arcate a tutto sesto e la sobrietà delle sue linee. Restaurato dopo i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale, è stato scelto per ospitare le sinopie provenienti dal Camposanto Monumentale: un atto simbolico di rinascita culturale e artistica dopo la devastazione del conflitto.
Ma cosa rende il museo così importante? Il suo oggetto di studio e di esposizione: le sinopie. Con il termine si indicano i disegni preparatori realizzati dagli artisti direttamente sull’intonaco grezzo del muro (detto “arriccio”) prima di procedere alla stesura dell’affresco vero e proprio. Il pigmento usato era solitamente la terra di Sinope, un’argilla rossa proveniente dall’omonima colonia greca sul Mar Nero, da cui deriva appunto il nome.
Le sinopie rappresentano il “rovescio” dell’affresco, la genesi silenziosa di alcune tra le più note pitture murali della storia dell’arte italiana. E il museo che le conserva racconta, oltre alla nascita dell’immagine pittorica, una vicenda di perdita e recupero. Le sinopie rappresentano la prima fase creativa del processo pittorico: sono il momento in cui l’artista dà forma alla propria visione, abbozza figure, sperimenta proporzioni, decide composizioni. Sono il pensiero che si fa segno. Durante il medioevo, i pittori raramente realizzavano disegni su carta o pergamena: i materiali erano costosi, e la pratica della progettazione su supporti mobili era ancora limitata. Per questo motivo, le sinopie assumono oggi un valore inestimabile e presentano uno sguardo diretto sulla mano dell’artista, sulle sue incertezze, sulle sue intuizioni. Normalmente, le tracce venivano coperte dall’intonaco più fine, l’intonachino, su cui si dipingeva a fresco.



Una volta completata l’opera, la sinopia restava per sempre nascosta sotto i colori. È proprio per questo che la loro sopravvivenza rappresenta un evento inedito: una finestra aperta sulla mente dell’artista, sulla genesi dell’opera. È con questo gesto che artisti come Bonamico Buffalmacco, autore del Trionfo della Morte, o Taddeo Gaddi e Pietro di Puccio da Orvieto, iniziarono a raccontare le storie dell’Antico e del Nuovo Testamento sulle pareti del Camposanto pisano. Proprio Pietro di Puccio fu il primo a cimentarsi con il ciclo delle Storie del Vecchio Testamento, che verrà poi completato da Benozzo Gozzoli, maestro rinascimentale noto per la sua vivacità narrativa. Quel ciclo rappresenta oggi il più ampio esempio di grafica tre-quattrocentesca conosciuto al mondo. Il Museo delle Sinopie ospita quindi la più ampia collezione di disegni murali medievali esistente, testimonianza diretta dell’atto creativo degli artisti. I tratti preparatori, spesso realizzati con slancio immediato, permettono di cogliere la mano dell’autore in tutta la sua spontaneità. In molti casi è possibile riconoscere stili diversi all’interno dello stesso ciclo pittorico, anche quando l’opera finita appare stilisticamente omogenea. È il caso, ad esempio, della Crocefissione attribuita a Francesco Traini. Il museo conserva anche sinopie di cicli più tardi, risalenti alla fine del Trecento e al Quattrocento, tra cui le Storie di Giobbe di Taddeo Gaddi, le Storie di San Ranieri dipinte da Andrea Bonaiuti e le narrazioni veterotestamentarie affrescate da Benozzo Gozzoli.
Ma se le sinopie erano originariamente destinate a rimanere nascoste sotto gli strati pittorici, cosa le ha riportate alla luce? Fu un evento drammatico a renderle visibili. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel corso dei bombardamenti su Pisa, un incendio devastò gran parte del Camposanto. Le fiamme, alimentate dal calore dell’esplosione, colpirono anche gli affreschi storici. L’unico intervento possibile per preservare le parti meno compromesse fu il distacco tramite la tecnica dello strappo, un metodo che consente di rimuovere solo lo strato più superficiale dell’affresco, spesso appena due o tre millimetri. L’operazione si rivelò efficace: già nel 1948, l’architetto Paolo Sanpaolesi poteva confermare il successo dei primi interventi riguardanti gli affreschi del Trionfo della Morte, della Tebaide e di cinque scene particolarmente danneggiate del ciclo di Benozzo Gozzoli. Nonostante le difficoltà stagionali e le differenti condizioni degli affreschi, scriveva Sanpaolesi, “sono perfettamente riusciti”. La natura stessa della tecnica, meno invasiva rispetto ad altri metodi più antichi come lo stacco a massello, che comporta la rimozione di ampie porzioni di parete, ha reso possibile la scoperta: le sinopie sottostanti agli affreschi del Camposanto.
Il ritrovamento inaspettato ha spalancato agli studiosi l’accesso a un patrimonio artistico nascosto, presentando così nuove interpretazioni sui processi creativi degli artisti tra Medioevo e Rinascimento. Fino alla metà del Quattrocento, infatti, la sinopia era il principale metodo di progettazione pittorica, prima di essere gradualmente soppiantata dalla tecnica dello spolvero, più rapida e funzionale. Con la stessa tecnica dello strappo, anche le sinopie vennero rimosse dalle pareti e salvate dalla distruzione. Nel 1979, trovarono infine casa nel museo a loro dedicato, un luogo che permette di leggere il pensiero dell’artista prima della sua trasformazione in immagine definitiva.
A custodire la collezione è un edificio storico che a sua volta racconta una lunga e articolata vicenda. Sorto probabilmente sull’area di un preesistente ospedale medievale, la struttura è nota come Spedale della Misericordia o, successivamente, di Santa Chiara. Fu progettato da Giovanni di Simone, l’architetto che avviò i lavori del Camposanto stesso. Costruito in laterizio tra il 1257 e il 1286, ospitava originariamente il Pellegrinaio degli Infermi, un vasto ambiente rettangolare destinato all’accoglienza di poveri, pellegrini e malati. Quest’ultima accoglieva malati, poveri e pellegrini in transito per Pisa, prestando assistenza a chiunque ne avesse bisogno. Negli anni Settanta del Novecento, l’edificio aveva ormai cessato la sua funzione ospedaliera, e venne destinato a nuova vita attraverso un intervento di recupero volto a trasformarlo nella sede museale. I lavori di restauro, condotti tra il 1975 e il 1979 su progetto degli architetti Gaetano Nencini e Giovanna Piancastelli, portarono all’inaugurazione, nello stesso 1979, del Museo delle Sinopie di Pisa.



La struttura del museo si distingue per la copertura a capriate lignee e per la decorazione interna in finto marmo bicromo, testimonianza della sobria eleganza dell’architettura pisana medievale. Nel 2005, un nuovo allestimento museale e la nuova illuminazione progettata dall’azienda Targetti ne ha ridefinito le funzioni: oggi il museo delle sinopie integra le esigenze espositive con spazi dedicati all’informazione e alla comunicazione, mantenendo intatto il legame tra memoria storica e fruizione contemporanea. Dopo la loro scoperta, le sinopie furono delicatamente rimosse dalle pareti danneggiate e trasferite su nuovi supporti, con l’obiettivo di assicurarne la conservazione nel tempo. Il cantiere, come ha sottolineato lo storico dell’arte Luca Ciancabilla, rappresentò “una pagina di notevole importanza per la storia del restauro e della conservazione dell’antico patrimonio pittorico italiano”. Si trattò infatti di un vero e proprio laboratorio sperimentale, che segnò un punto di svolta nella prassi estrattista: per la prima volta, l’intervento non riguardava solamente il distacco degli affreschi, che vennero trasferiti su supporti in eternit, ritenuti più sicuri rispetto alla ormai superata tela, ma si estendeva anche alle sinopie sottostanti. Anch’esse furono oggetto delle stesse cure conservative e analitiche, fino a essere valorizzate anche in chiave museografica ed espositiva. Un approccio del tutto nuovo “mai durante i tre secoli che avevano segnato l’evoluzione tecnica e storica della pratica estrattista”, scrive ancora Ciancabilla, “si era cercato di riportare alla luce anche il disegno sottostante il dipinto murale. A Pisa i bombardamenti non solo avevano causato un disastro a cui si era cercato di porre rimedio attraverso il capillare distacco delle pitture coinvolte, ma avevano favorito la scoperta e quindi il conseguente trasporto delle sinopie, facendo sì che quelle particolari testimonianze dell’arte antica divenissero, anche nelle altre realtà italiane, oggetto di nuovi e mai battuti studi artistici. I disegni preparatori, testimonianze della fase creativa dell’artista, iniziarono così a suscitare un interesse mai visto prima, dando il via a nuovi studi anche in altre realtà italiane. “Quel cantiere”, continua Ciancabilla, “segnerà infatti per sempre i decenni successivi aprendo in maniera netta e decisa alla più importante e generalizzata campagna di rimozione di affreschi e sinopie che il nostro paese abbia conosciuto nella sua storia recente; una fase che rappresentò il culmine della fiducia in quella particolare tecnica conservativa”.
All’interno del museo ogni sinopia è accompagnata da pannelli esplicativi che illustrano il contesto storico e artistico, permettendo ai visitatori di comprendere l’importanza di questi disegni nella realizzazione degli affreschi. Le sinopie, infatti, rivelano anche le loro scelte, i ripensamenti e la loro visione progettuale. Testimonianze preziose, che restituiscono il gesto creativo nella sua forma più immediata.
Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!
La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia
Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.