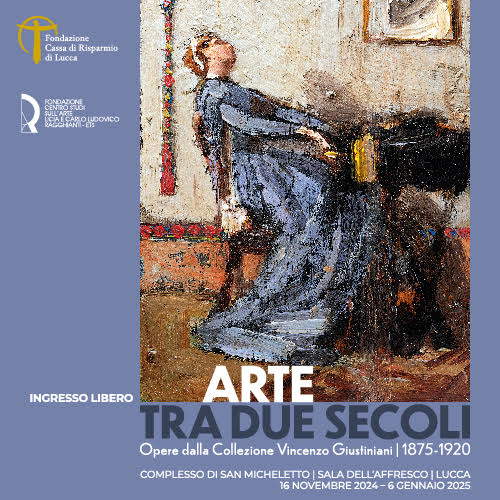“Un artista sogna la materia e va al fondo delle cose”. Conversazione con Laura Patacchia
Laura Patacchia nasce a Terni nel 1974, frequenta l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, nel 1999 si diploma in Pittura, sempre nel 1999 frequenta la cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bilbao seguendo il corso di Ángel Bados. Nel 2001 partecipa al un workshop in Bosnia nell’ambito della Biennale dei Giovani artisti dell’Europa e Mediterraneo. Ha esposto in diverse mostre in Italia e all’estero. La sua ricerca si contraddistingue per l’uso di materiali come fili, stoffe e vetri che spesso arrivano a riempire l’intero spazio espositivo. Una sorta di “disegno spaziale” che rende la sua arte particolarmente interessante. Laura Patacchia ce la racconta in questa conversazione con Gabriele Landi.
Laura, ti chiedo per iniziare uno scavo nella memoria: spesso i primi “sintomi” di appartenenza all’arte si manifestano nella prima infanzia. È stato così anche per te?
Pensando all’infanzia il mio pensiero va inevitabilmente al tempo con il suo trascorrere, e come questo mi conduce a fare le cose che sto sviluppando ora. Forse si parla di destino? L’infanzia è uno “stare al mondo”, non ha mai abbandonato il mio modo di sentire e percepire le cose, tutto è concentrato sull’occhio e lo sguardo. Occhio come desiderio di trasformazione in uno spazio immaginifico, guardare e amare un’immagine attraverso l’incantamento per cercare qualcosa che va oltre a quello che si vede. Con gli occhi di un bambino qualsiasi immagine è sempre una metafora nuova, perché è nutrita da mistero e magia. Mi viene in mente una frase di Hillman: “... dobbiamo prestare particolare attenzione all’infanzia, per cogliere i primi segni del daimon all’opera, per afferrare le sue intenzioni e non bloccargli la strada”. Allora posso raccontarti un aneddoto, un racconto di mia madre di cui mi parlava spesso. Negli anni Settanta, quando ero piccola, la tv era in bianco e nero ma io vedevo chiaramente tutte le immagini a colori. Andavo su tutte le furie quando qualcuno mi parlava di assenza di colore, perché non capivo come fosse possibile che gli altri vedessero le immagini, e quindi il mondo, in modo così anemico. Così ho sempre guardato tutto il resto delle cose, in modo immaginifico, forse è un codice per me.
C’erano delle immagini o delle situazioni che eccitavano la tua immaginazione più di altre?
Ero incuriosita da tutto, qualsiasi cosa poteva essere fonte di fantasticheria, tutto era un’occasione di fuga dalla realtà. L’ Ambiente intero in cui viviamo ci nutre e stimola continuamente la nostra immaginazione. In particolare amavo osservare, scrutare, fissare le persone (i loro abiti, i modi di muoversi e parlare…) per scavare la loro umanità; così come spesso fissavo il cielo, ero attratta dall’infinita profondità spaziale, intesa come spazio fisico e astronomico, la profondità della notte, in cui ogni cosa è misteriosa e nascosta, forse anche parallela. Durante la notte e nel buio avevo molte visioni, che forse erano inizialmente stimolate dai riflessi di luce quando i fari delle macchine illuminavano la strada di passaggio, e la luce attraversava i fori della serranda abbassata, un vetro, un lampadario… Le forme luminose diventavano provvisorie, mutevoli, spaziali.





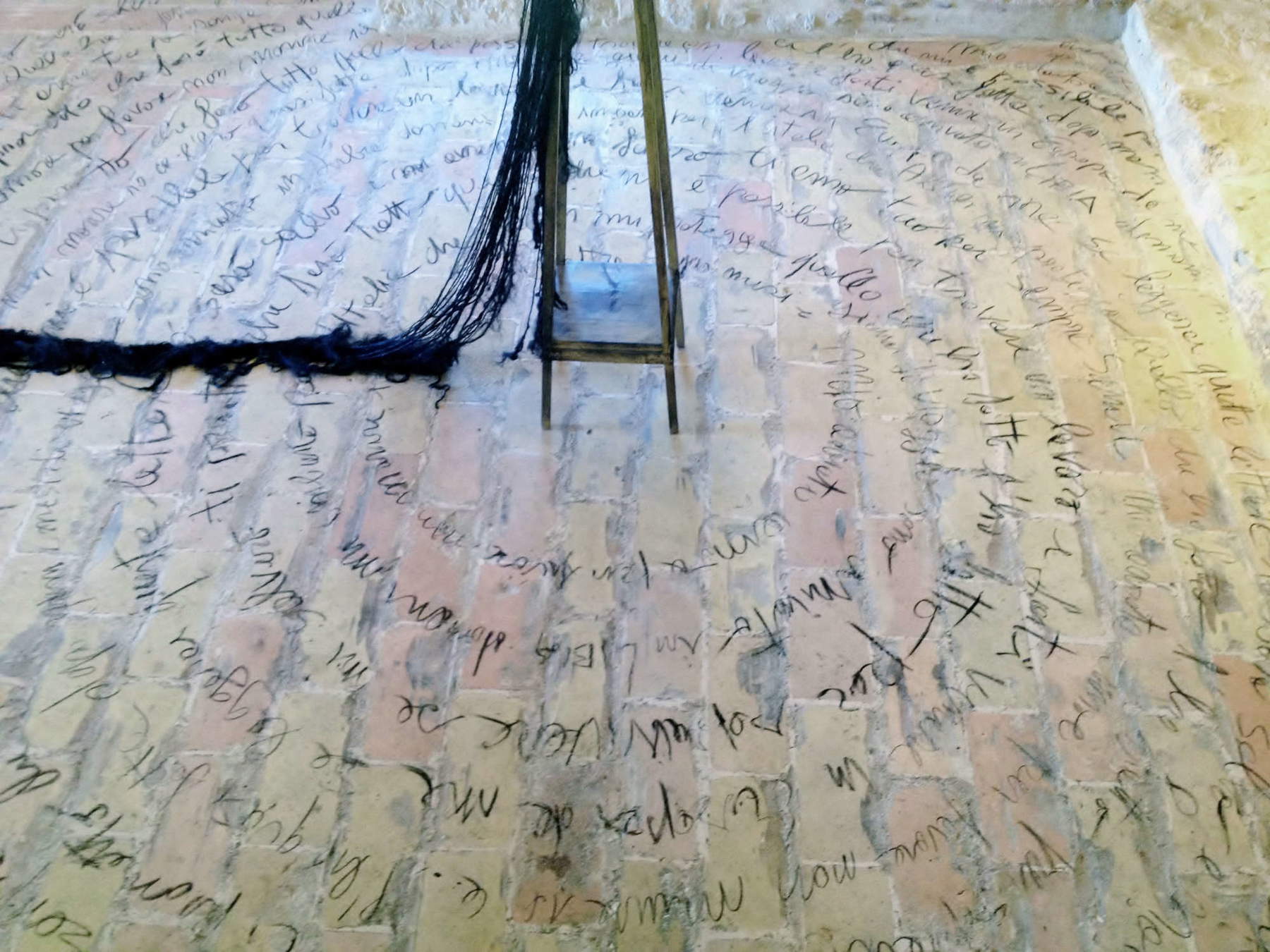

Quello che mi racconti in questa risposta mi fa venire in mente qualcosa di simile che è successo anche a me nel corso della mia infanzia e che grazie alle tue parole è uscito dal “cassetto” in cui lo avevo riposto. Gaston Bachelard parla di rȇverie, credo che sia un buon termine per definire questi accadimenti, ti volevo chiedere se anche oggi continui a coltivare quest’atteggiamento...
Mi fa piacere avere evocato qualcosa di lontano Gabriele. La rȇverie è pane quotidiano, diciamo che è il pasto principale attraverso il quale prendo nutrimento vitale, amo Bachelard, il suo pensiero. Generalmente nel lavoro è così e nella vita anche. Non riesco a essere diversa, tuttavia ho la sensazione a volte di esserne allontanata da forze maggiori. Sai, l’attività immaginativa esige attenzione assoluta e la realtà nel tessuto sociale ci costringe a pratiche di vita diverse; quindi ci allontana dal gioco germinale, dalla nostra vera natura, dall’immagine del cuore.
Già è proprio così! La cosa più difficile non è quella di fare le cose ma quella di calarsi nello spirito giusto per poterle fare, sei d’accordo?
Si sono d’accordo con te, caro Gabriele, e quello giusto, per me, è lo “spirito sognatore”, anche da adulti dobbiamo continuare a giocare con le cose che ci attraversano. Perché giocare vuol dire desiderio di conoscere attraverso l’esperienza diretta, vuol dire esistere, sentire e lavorare con il corpo, preservando l’aspetto magico, misterioso e segreto delle cose. Un artista sogna la materia, la sua materia, e va al fondo delle cose. Potrebbe sembrare una contraddizione ma credo fortemente nella centralità del corpo come estensione verso le cose, il mondo è corpo umano, “fin dove si estende la mia presenza, là si estende il mio corpo” (Galimberti). Non è l’“io penso” a far muovere le cose ma “l’io sento”, e se siamo in grado di ascoltarlo ci guida verso un mondo fatto di materia viva ma anche di archetipi lontani, simboli, miti e magie. È come camminare in una condizione funambolesca e come dice, a proposito, Bachelard, “chi sogna troppo smarrisce lo sguardo chi fedelmente disegna ciò che vede perde i sogni del profondo”.
Partirei proprio da questa considerazione di Galimberti per chiederti di parlare della presenza di alcune immagini archetipiche che ricorrono nel tuo lavoro, come quella della casa ad esempio, o ultimamente quella del veliero...
È vero Gabriele, queste immagini archetipiche sono spesso presenti nel lavoro: la casa, il cerchio, il veliero, hanno lo stesso contenuto con forme diverse. Sono tutti simboli complessi del ritorno al primordiale, all’intimità. Tutto parte dal “corpo” come idea di prima dimora, la nostra vera casa è il nostro corpo, il corpo è il primo spazio abitato. La casa è un rifugio naturale, l’intima dimora, è la caverna misteriosa del nostro essere più profondo. La casa è un contenente e un incavo, un ambiente, una cavità, una coppa, un grembo. Il cerchio è il rifugio circolare dove risiede l’immagine del ventre, il cerchio e il suo centro sono il simbolo del rannicchiamento materno, nel centro troviamo l’ombelico della terra (Jung). Anche Bachelard parla di rannicchiamento come “un essere nascosto, un essere restituito alla profondità del suo mistero”. In alcuni miei lavori la circolarità è nata anche dalla necessità di rendere rituale il gesto ripetitivo e trasformarlo in una sorta di meditazione purificatoria, facendo riferimento alle “tonsure” dei clerici, per lavorare anche sul senso di colpa e l’autoflagellazione. Tornando alla casa e il cerchio: anche la dimora sull’acqua è un rifugio naturale. La barca è una dimora acquatica, culla dei viventi e ci riporta all’intimità acquatica, quindi si ricollega al rifugio circolare del ritorno alla madre (al ventre della terra). Il veliero è anche inteso come ventre digestivo, perché, come la casa caverna, ha la forma della coppa e del vaso, è quindi una cavità profonda; un contenente e un contenuto. Questi contenuti si rincorrono in modo circolare e tantrico.











Ti volevo chiedere di parlare più diffusamente dell’aspetto rituale che ritorna nella tua pratica di lavoro...
La ritualità sta nel gesto e nel tempo. Seguo il ritmo ciclico del tempo che suona all’interno del luogo esplorato. Anche la materia su cui lavoro è uno spazio/luogo da esplorare proprio come lo sono le stanze che accolgono un’installazione. Cerco di pormi in una posizione di ricezione e di ascolto, cercando di seguire cosa sussurrano, senza forzare. Tutto è già suggerito e in una condizione di “preghiera” il lavoro si manifesta, parlo di preghiera intesa come spazio interiore del se e che segue il ripetersi gestuale dove le cose ciclicamente nascono per finire. Credo fortemente nella voce mistica delle cose, che appaiono o spariscono per ribaltarsi su se stesse, in una continua ciclicità temporale. Tutto muore per rinascere, è questa la ritualità che inseguo con il lavoro. Forse perché ho paura della morte e cerco di esorcizzarla come posso, nel mio stare al mondo in relazione con la vita, ho bisogno di sentire che tutto si trasforma. Mi piace pensare la lavoro come alla Luna perché essa è prima di tutto misura del tempo ed ogni cosa è legata alle fasi lunari, la natura, la terra, gli esseri viventi. Ma la Luna è, anche, contemporaneamente misura del tempo e promessa esplicita dell’eterno ritorno, e con il suo continuo divenire ciclico esorcizza il tempo. Inoltre il simbolismo lunare regala una visione bipolare del mondo perché il suo ritmo è scandito da una ripetizione temporale di continua rinascita e scomparsa, la ritualità è data dalla continua successione di alternanza di contrari: morte e rinnovamento, luce e tenebre. Il suo mostrarsi luminoso è un’epifania rassicurante, ma allo stesso tempo drammatica perché è inevitabilmente seguita dalla sua scomparsa, ma vive solo di questa dualità, qui sta la ritualità che inseguo. “Essa è vivente e inesauribile nella sue rigenerazioni” (Gilbert Durand). Ecco allora che il tempo è reso possibile dall’esistenza dei contrari. Qual è il volto della luna quando scompare? Potrebbe nascondere enormi fauci pronte a divorare il mondo?
Il simbolo per affermarsi in tutta la sua verità ha bisogno di essere vivo, ti interessa l’aspetto esoterico?
No, almeno fino ad ora non mi sembra, non ho mai indagato questo aspetto. Penso che ogni cosa vive del suo Eco; Ma chi era Eco? Lei venne lacerata dai pastori per aver rifiutato Pan, le sue membra cantanti vennero disperse in tutte le direzioni, quindi Pan parlava in questi pezzi echeggianti che nei momenti di spontaneità presentano la consapevolezza che la natura ha di se stessa. Eco non ha corpo, non ha una sua esistenza. Nel rapporto con Pan essa non era che lui stesso ritornato su se stesso, una ripercussione della natura che riflette se stessa (James Hillman, “Saggio su Pan”).


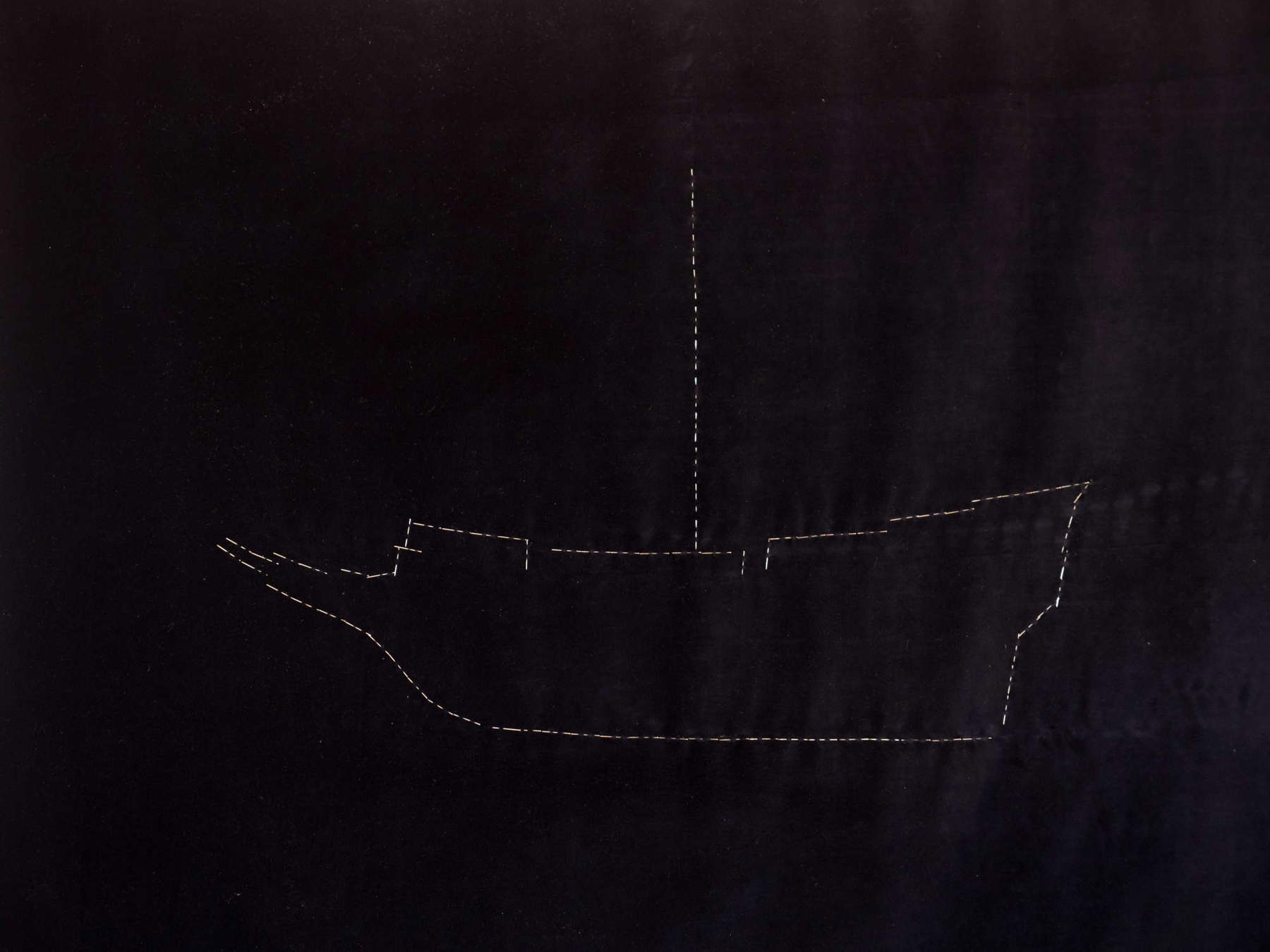



Parliamo del lavoro. La prima cosa che ti vorrei chiedere riguarda il disegno che importanza e che ruolo ha nella tua pratica lavorativa.
Il disegno è pensiero, mi placa l’ansia, mi fa da specchio. Senza il disegno il mio lavoro non potrebbe esistere, è una pratica per me, infatti, quando riprendo un discorso o intraprendo una nuova ricerca vado subito al mio diario, è da li che parte tutto, ci scrivo, disegno e prendo appunti di libri. Ho bisogno di lavorare sulla provvisorietà della carta, di usare varie dimensioni, abbozzo un’idea, incollo, strappo e rincollo, non butto mai niente; amo anche le superfici molto grandi perché le sento come spazio. Per ogni lavoro realizzato esiste una serie di studi su carta, ma non sempre mi fermo allo studio analitico, spesso il disegno continua ad evolversi e prende una sua vita autonoma dal progetto iniziale. Ogni segno ha la sua eco e nel ritornare su se stesso diventa sempre “altro“, in questi nuovi lavori la vibrazione parte da dentro la carta, vivono da dentro, e ci si annidano; lo studio analitico, invece, è una percorrenza di pensiero sulla superficie della carta.
Ecco un punto su cui mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa di più, questa idea della vibrazione che parte da dentro la materia, “vivono da dentro, e ci si annidano” è vera non solo per la carta ma anche per il velluto, i bozzoli di filo elastico o il vetro insomma per tutte le materie che impieghi?
Sì, è vera anche per gli altri materiali. Lavorando si fanno molte azioni, noi siamo gli artefici di legami e separazioni, ma alla fine è il materiale che decide. Non si può forzare, non ha senso, quando questo accade siamo di fronte ad una questione puramente formale, e si vede. Quando il gesto giusto incontra la materia giusta nasce una vibrazione interna, forse questi generano un nucleo vitale che tiene sempre vivo quel lavoro. Nel fare, nel gesto, c’è pensiero, corpo, occhio e spirito, errori e incidenti di percorso che ci regalano una visione laterale delle cose, e sono proprio questi eventi non voluti a generare vibrazioni, in quanto usciti dal nostro controllo vivono di materia pura. Molti dei miei lavori, velluti, vetro, cavi, sono stati solo attraversati da segnali e sono rimasti freddi studi analitici. Altri invece sono veri, vibrano, proprio come le parole vere o false. Credo sia un processo di lavoro. Quando s’intraprende un percorso di ricerca si aprono infinite strade e possibilità di sviluppo, si fanno molti tentativi ma quelle vere si riconoscono, vibrano perché sono vive, e sopravvivono al tempo; anzi più depositano una memoria lunga e più prendono forza. Qualche volta tendiamo a ripetere un lavoro ben risolto, ma alla fine suona a vuoto.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Gabriele Landi
Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.