Nuove prospettive per lo studio dei rapporti tra arte e politica nel '900. Intervista a Michele Dantini
Nuove prospettive per lo studio dei rapporti tra arte e politica nel ’900. Intervista a Michele Dantini
Arte e politica in Italia tra fascismo e Repubblica (Donzelli, 2018) è l’ultimo libro di Michele Dantini, storico dell’arte contemporanea, docente all’Università per Stranieri di Perugia e visiting professor alla Scuola Imt Alti Studi di Lucca. Il volume, si legge nella quarta di copertina, intende approfondire “le continuità sociali e culturali, in Italia, nel passaggio tra fascismo e Repubblica, in un momento dunque di profonde discontinuità politico-istituzionali”, e ancora il modo in cui si collegano o si disgiungono le due metà del Novecento separate dalla seconda guerra mondiale, oltre alle “rimozioni” della storiografia postbellica e successiva. Il tutto attraverso tre saggi (dedicati a Edoardo Persico, Giuseppe Bottai e Renzo De Felice) dai quali emergono importanti considerazioni sulle “liturgie politiche” dell’epoca analizzate nel loro dispiegarsi attraverso la storia dell’arte del tempo: si tratta di un volume che introduce nuove prospettive per lo studio dei rapporti tra arte e politica nel Novecento offrendo un’analisi inedita e di sicuro interesse, soprattutto per quanti studiano o s’avvicinano all’arte del XX secolo. Abbiamo approfondito i temi del libro parlando con Michele Dantini. L’intervista è a cura di Federico Giannini.
 |
| Michele Dantini. © Livia Cavallari, Firenze |
FG. Arte e politica in Italia tra fascismo e Repubblica è un libro che intende affrontare i temi della “liturgia politica”, sotto profili eminentemente storico-artistici, considerati nei loro sviluppi tra le due metà del Novecento separate dalla seconda guerra mondiale, offrendo strumenti per un’analisi che possa portarci a riconsiderare gli sviluppi dell’arte stessa nel dopoguerra e che riesca anche a legarsi a temi quanto mai attuali. Vorrei però cominciare questa intervista cercando di inquadrare questo contributo, dal momento che si situa nell’ambito di ricerche finora poco affrontate: qual è dunque la base sulla quale s’innesta Arte e politica in Italia?
MD. Il libro nasce da una constatazione storiografica. Noi abbiamo narrazioni eccellenti sul modo in cui determinati repertorî o laboratorî artistici, architettonici, musicali, letterarî tra le due guerre si preoccupano di maturare quella “nazionalizzazione delle masse” di cui parla Mosse, cioè di diffondere e radicare un sentimento di appartenenza, se possibile (ma non sempre) in chiave eroica. Ecco: ci manca la narrazione relativa al contributo che le arti figurative vanno definendo. E questo per un motivo semplice: la storiografia artistica del secondo dopoguerra, anche quando ha cercato di recuperare momenti importanti del Ventennio o addirittura anteriori, come il futurismo legati a doppio filo col fascismo, lo ha fatto in chiave apologetica. Cioè ci si è preoccupati di dimostrare che questo o quello non è stato così tanto fascista, ci si è occupati di difendere Marinetti, Prampolini, Fontana, e di escludere ogni compromissione. A me interessava poco tutto quello che fosse apologetico, nel senso che ormai dovremmo aver conquistato una distanza tale da considerare la cosa stessa senza necessità di schierarsi a difesa di questo o quello. Soprattutto mi sembravano chiari alcuni aspetti: primo, che la “politicità” dell’immagine italiana tra le due guerre è molto più diffusa di quanto noi pensiamo; secondo, che questa politicità non significa necessariamente fascismo; terzo, che bisogna sempre chiedersi quale fascismo e nel caso che cosa significhi; quarto, e cosa più importante: il fascismo nelle immagini non è semplicemente da cercare nei quadri con Mussolini a cavallo. È troppo semplice: non è che un quadro è fascista o prende posizione, lambisce, fiancheggia o simpatizza perché ritrae Mussolini a cavallo. No: bisogna cercare le narrazioni identitarie (il che può significare fasciste, ma anche non fasciste o addirittura antifasciste) e le implicazioni politiche dell’immagine nelle pieghe dell’immagine, sia quando il tema appare ideologicamente esplicito, sia quando non lo è. Faccio un esempio: la natura morta sembrerebbe a tutta prima uno dei generi in cui il discorso politico nazionalista o patriottico o di fiancheggiamento o addirittura di militanza fascista non si dovrebbe mai dare. Questo è profondamente sbagliato, perché la natura morta mette in scena un’immagine dell’Italia che ha implicazioni politiche di volta in volta da ricostruire ma spesso molto precise (l’Italia come “patria della bellezza”, l’Italia come “terza via” tra i due sistemi produttivistici degli Stati Uniti o dell’Inghilterra da una parte e dell’Unione Sovietica dall’altra, l’Italia come luogo sovratemporale dove gli dèi continuano ad abitare). Anche la natura morta ha implicazioni geopolitico-culturali che si dovrà poi capire dove portano: spesso dunque una natura morta contribuisce alla “liturgia politica” senza necessità che ci sia un Mussolini a cavallo.
Il tema della liturgia politica emerge anche in maniera sostanziale dalla prima figura che il libro affronta, che è quella di Edoardo Persico: Arte e politica in Italia tra fascismo e Repubblica è infatti un libro, per così dire, “tripartito”, dal momento che è suddiviso in tre saggi, dedicati a Persico, a Giuseppe Bottai e a Renzo De Felice, volti a rilevare quali continuità possano esserci tra la prima e la seconda metà del Novecento. Una prima continuità potrebbe essere tracciata sondando i propositi di rinnovamento di Persico sul tema dell’arte sacra: partendo quindi dai suoi allestimenti (nel libro si parla della Sala delle Medaglie d’Oro di Persico e Nizzoli alla Mostra dell’Aeronautica del 1934, o del Salone d’onore alla Triennale di Milano del 1936, quindi saloni che nel libro vengono definiti “liturgici”), si potrebbe giungere fino agli ambienti di Lucio Fontana...
Questo infatti è quello che mi propongo di fare: una percezione più complessa e più matura del modo in cui le immagini, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi vessillo, partecipano a un processo che oggi diremmo di nation building, cioè di costruzione di senso di appartenenza, ci permette di rintracciare e ricostruire determinate continuità che altrimenti vanno perse. In questo caso quelle tra Persico e Fontana e soprattutto quelle tra il primo e il secondo Fontana, che a oggi rimangono altrimenti del tutto dimenticate o passate sotto silenzio. Anche se ignorassimo la posizione politica di Fontana tra le due guerre e gli studî recenti sulla sua appartenenza politico-partitica negli anni in cui era in Argentina, il suo rapporto con Persico, così formativo per lui, così importante per la sua prima affermazione come artista sulla scena milanese, va tutto nel senso di una collaborazione d’ambienti e del recupero di una tradizione barocca d’immagini che si apre alla luce: Persico è una figura di enorme rilievo, è un cattolico antifascista, anche se il suo antifascismo non si lascia ben descrivere dalle categorie dell’antifascismo repubblicano a venire, come per lunghi anni abbiamo fatto seguendo la scia interpretativa di Giulia Veronesi. L’antifascismo di Persico è l’antifascismo di un cattolico integralista che crede nel primato del Vaticano, che crede nell’esistenza di una nazione italiana soprattutto intesa come nazione cattolica, quindi al tempo stesso fortemente localizzata e cosmopolita. È chiaro che Persico rinnova gli allestimenti defascistizzando esempî eminenti di liturgia politica fascista, e mi riferisco al Sacrario dei Martiri alla Mostra del decennale della Rivoluzione fascista, da cui Persico rimane fortemente colpito, in bene e in male, in bene perché è indubbiamente un allestimento potente, in male perché lo infastidisce quella che lui stesso chiama “violenza pubblicitaria”, e perché questo conferimento di dimensioni religiose a un movimento politico turba la sua coscienza di cattolico del non expedit. Ecco, la Sala della Vittoria in Triennale è una sorta di Sacrario dei martiri completamente defascistizzato: la potenza religiosa, il richiamo alla basilica paleocristiana e alle sue diverse componenti, in primis luminosità e altare, ci parlano di un dialogo di Persico stesso con l’“ambiente” sacro tipo che gli italiani conoscono e di cui hanno esperienza (e cioè la chiesa). Lì c’è un razionalismo reclutato da chi non è affatto un razionalista ma vuole usare il razionalismo per costruire ambienti in cui l’esperienza del sacro si rinnova e rinnovandosi si preserva. Mi sembra che siamo molto vicini, anche se non esattamente nello stesso punto, a quello che Fontana, con altra sensibilità, si proporrà di fare con gli ambienti. Ricordo che ancora nell’Autoritratto di Carla Lonzi del 1967, Fontana non fa altro che formulare istanze di rinnovamento dell’arte sacra: non si tratta di derubricare, ma di rinnovare. E lo fa da un punto di vista chiaramente identitario: cioè l’identità dell’artista italiano (o meglio latino) sta tutta nell’essere un artista sacro, un artista metafisico, un artista radicato non nella cronaca politica, non nella denuncia, non nella protesta, ma nell’adorazione di immagini numinose. E questo mi sembra ancora Persico.
 |
| Marcello Nizzoli e Edoardo Persico, la Sala delle Medaglie d’Oro alla Mostra dell’Aeronautica del 1934 fotografata da News Blitz (1934; Milano, Fondo Archivio Fotografico della Triennale di Milano) |
Nel saggio su Persico viene anche concesso ampio spazio alla sua idea di modernità. Nella Lettera a Sir J. Bickerstaff, Persico scrisse che “la crisi dell’arte moderna consiste nella sua astensione dalla vita: l’artista che non sente attorno a sé il suo pubblico è indotto a creare opere senza destinazione”. Appellandosi dunque a un’arte che potesse “parlare il linguaggio di tutti” per “intendere certi problemi e preoccuparsi delle loro soluzioni”, Persico sottolineava che la circolazione delle conoscenze, leggiamo nel libro, non poteva che portare a una conversazione e anche a uno stile europeo, perché, citando ancora Persico, “nulla impedisce alle parole, ai colori, a volumi e suoni di oltrepassare le frontiere”. Ecco, sarebbe interessante approfondire quali siano i termini dell’europeismo di Persico...
Questa è una bella domanda, nel senso che è un problema cruciale che si è prestato ai più confortevoli fraintendimenti, sempre in quella chiave apologetica e assolutoria, un po’ superficiale e un po’ strumentale, della storiografia artistica italiana nel secondo dopoguerra, nel senso che è stato facile prendere i termini e impugnarli un po’ come clave, senza pensare che le parole sono sempre fondamentalmente ambigue e senza pensare che Persico conosce bene le tecniche dell’appropriazione culturale di tradizione ecclesiastica, e quindi è perfettamente in grado di reclutare un dizionario avversario per poi riempirlo di contenuti proprî, talvolta persino divergenti. È chiaro che quando Persico parla di europeismo si rivolge ai lettori de Il Baretti, perché ne parla per la prima volta su Il Baretti (la terza rivista fondata da Piero Gobetti), e quindi ne parla a un pubblico molto ideologicamente distante, laico, liberale, nord-italiano. Lui invece è un integralista cattolico, “clericale” come si definisce lui stesso, meridionalista, borbonico e antiunitario: non potremmo quindi immaginare una distanza maggiore, nell’Italia del tempo, tra la platea de Il Baretti e Persico, che anche in quest’occasione è un outsider molteplice, la persona giusta nel posto sbagliato, come sarà praticamente sempre. E questa è parte del suo fascino e della difficoltà di decifrare i suoi mimetismi e le sue dissimulazioni: quando parla di europeismo su Il Baretti, lui intende qualcosa di completamente diverso da ciò di cui parlerebbero Sapegno o Gobetti stesso, perché il suo europeismo coincide di fatto con un regionalismo inteso in senso corretto (c’è l’antropologia del luogo, ci sono le sottoculture popolari che per lui significano soprattutto le culture devozionali dei luoghi, a costituire il patrimonio profondo, e da dover restituire di volta in volta con i dizionarî della più aggiornata attualità internazionale, ma a fini di preservazione). Questo Persico è vicino al Montale antigentiliano che scrive su Il Baretti in nome dello “splendore” delle fedi tradizionali. Ed è più vicino a Malaparte che ai barettiani: è un momento in cui nella cultura italiana si disegna una strana coincidenza non tra “nazione” e Mondo, ma tra regione (o “provincia”) e Mondo, e dobbiamo tenerlo presente.
Il secondo saggio è dedicato, come detto, alla figura di Giuseppe Bottai. Il rapporto tra arte e politica, nel libro, sottende un’interpretazione originale del corporativismo fascista, dal momento che, cito dall’introduzione del libro, “l’intera concezione dello Stato corporativo, o meglio i suoi presupposti pretecnici, non sono pienamente comprensibili senza riferimento all’arte e alla letteratura nazionali intese come nutrimenti mitici”. Il progetto di Bottai prende forma molto presto, perché già nel 1919 scriveva che “solo l’arte è la possibilità di salvare l’Italia”, e che “gli artisti sono i suoi figli più appassionati”, e di conseguenza per lui lo Stato stesso avrebbe dovuto essere considerato un’opera d’arte, tanto che gli artisti ne avrebbero dovuto assumere il governo. Quali sono le implicazioni storiografiche di questa lettura del corporativismo fascista?
Noi abbiamo oggi ricevuto un’interpretazione di Bottai di origine defeliciana (condivisa anche da molti degli allievi di De Felice), che spezza la carriera politica o politico-culturale di Bottai, in tre tronconi che non comunicano: il Bottai futurista, artista, scrittore e interventista, il Bottai sottosegretario e poi ministro delle Corporazioni, e quindi il Bottai tardo del Ministero dell’Educazione e delle leggi sul paesaggio e sul patrimonio. Questi tre tronconi non comunicano nell’interpretazione ricevuta, nel discorso corrente: si dice che Bottai nasce come vociano-sofficiano, e che come tale partecipa alla guerra, tornando carico di furori patriottici, è molto vicino ai futuristi ed è parte del movimento futurista, condirige Roma Futurista, dopodiché concepisce l’idea (marinettiana in origine) che gli artisti debbano andare al governo. La rivoluzione nazionale (non chiamiamola ancora “rivoluzione fascista”, ché vuol dire tante cose, anche se agli occhi di Bottai sarà sempre più chiaro che la rivoluzione nazionale sarà una rivoluzione fascista), quella che permetterà di cambiare l’élite, di avvicinare governanti e governati e di congedare definitivamente le classi dirigenti liberali prebelliche, classiste, conservatrici, incapaci, profondamente corrotte e via dicendo (questa chiaramente è l’opinione di Bottai), sarà futur-fascista e installerà gli artisti al governo: questo non per un semplice golpismo degli artisti, ma perché, ai suoi occhi, gli artisti hanno quei requisiti di disinteresse, abnegazione, forte motivazione e fede che devono connotare le classi dirigenti, a prescindere dalle origini delle singole persone (nell’accezione marinettiana, i geniali possono anche essere proletarî, ma devono essere caratterizzati da immaginazione, probità, veemenza, determinazione, progetto, visione, eccetera). Quando questo progetto fallisce (e fallisce per iniziativa di Mussolini che sposta a destra il fascismo e condanna i futuristi all’irrilevanza spostandosi su posizioni filomonarchiche), ecco che Bottai (e qui inizierebbe il Bottai puramente tattico, il Bottai che in qualche modo cerca il potere) segue Mussolini, esce dal futurismo, congeda queste ambizioni ormai diventate futili, e inizia una carriera al ministero delle Corporazioni: fine del rapporto con l’arte, fine del rapporto con gli artisti. Alla fine del regime, quando Bottai sarà tagliato fuori ancora da Mussolini, nel contesto della riforma corporativa dello Stato fascista, ritornerà in maniera quasi rassegnata, crepuscolare e marginale ai suoi interessi umanistici di una volta. Questa ricostruzione, in realtà, fa un eccessivo torto alle motivazioni di Bottai e all’importanza che il dibattito sulle arti figurative ha avuto all’interno del progetto fascista e persino all’interno del discorso corporativista. Il senso del mio discorso è questo: la storia dell’arte e gli artisti offrono fin da subito a Bottai i materiali per comporre una sua antropologia politica. Quel “disinteresse” dell’artista italiano di tradizione, quell’ostinazione e quel desiderio di perfezione pressoché religioso, quella capacità di vivere in povertà pago della sua arte e della sua fede: questi sono determinati caratteri nazionali che Bottai ascrive agli antichi Maestri e che di fatto compongono un’antropologia politica dell’“italiano nuovo”, rigenerato dalla “rivoluzione corporativa” (una sorta di Riforma, agli occhi di Bottai). Tutta la nazione, per Bottai, potrà fare propri costumi di frugalità e opporsi alla ricchezza di nazioni rette dal denaro. Nutrendosi di ideali di fede e di un senso profondamente religioso dell’esistenza. Non ci interessa adesso stabilire quanto questo punto di vista di Bottai sia stato velleitario (e lo è stato certamente molto). Ci interessa prima di tutto cogliere determinate origini di un “consenso” che si è sviluppato particolarmente tra artisti, scrittori, intellettuali: i “geniali” sono sempre in qualche maniera in prima fila nel discorso bottaiano. Non è che poi alla fine Bottai torna agli artisti perché Mussolini lo ha fatto fuori da un qualsiasi potere reale: ci ritorna perché ci crede, e ritorna poi a combattere la sua battaglia che aveva combattuto nel futurismo e in cui gli artisti avevano il ruolo di un’avanguardia etico-politica, non semplicemente culturale.
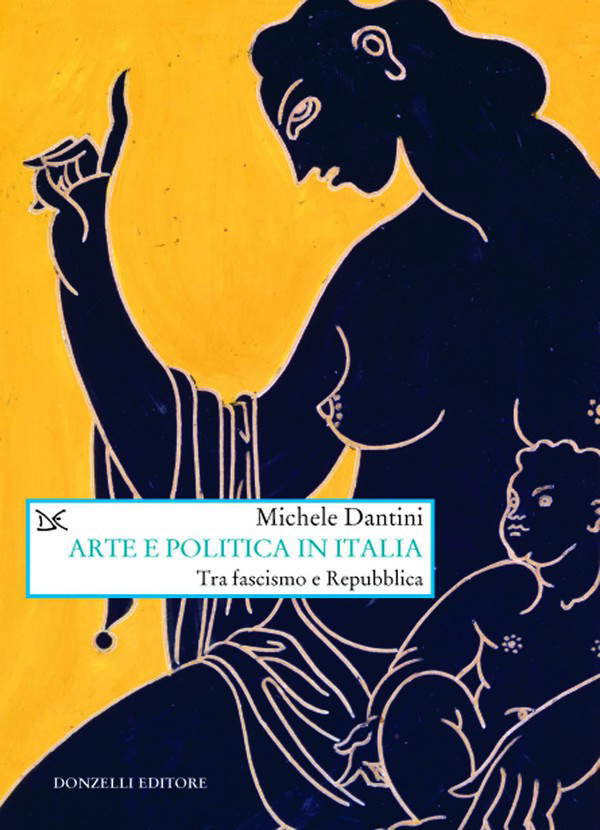 |
| La copertina del libro Arte e politica in Italia tra fascismo e Repubblica di Michele Dantini |
Nell’articolo intitolato Fronte dell’arte e pubblicato nel 1941, Bottai, richiamandosi alle origini “rivoluzionarie” del fascismo, rivolgeva agli artisti un appello a schierarsi, esortando in particolar modo i giovani, premurandosi di evidenziare che, citando dal testo, “il miraggio d’un’arte estranea alla storia non potrà sedurre nessuno che abbia il senso del tempo”. Torna dunque il motivo dell’inscindibilità tra arte e politica che, ha scritto Michela Morelli nel suo articolo sull’ultimo numero della rivista piano B, dedicato proprio alle continuità e discontinuità nell’arte e nella cultura italiana tra le due metà del Novecento, avrebbe trovato in Guttuso la figura che parrebbe raccogliere con più consapevolezza questo assunto... ma nello specifico questi propositi bottaiani di “reclutamento” quali conseguenze avrebbero avuto nel Dopoguerra?
Hanno avuto conseguenze secondo me molto vaste: questo leaderismo politico attribuito agli artisti, soprattutto agli artisti giovani, secondo me favorisce, incoraggia, nutre una sopravvalutazione del ruolo civile e sociale che gli artisti possono avere. E questo è un qualcosa che accade solo in Italia. Io non vedo in altre nazioni europee questo stesso equivoco, questa stessa sopravvalutazione, che è una sopravvalutazione di medio e lungo periodo, perché partendo da Bottai (o forse partendo da Marinetti per essere ancora più giusti), quindi partendo dalla prima chiamata o dal primo reclutamento degli artisti di avanguardia, degli “artisti giovani”, come nuova classe dirigente, noi arriviamo fino agli Appunti per una guerriglia di Germano Celant. Francamente non mi interessano gli autoposizionamenti e le autoconsapevolezze: facendo storia, e andando oltre ciò che le persone dicono di sé e le testimonianze individuali, è evidente che c’è un’infrastruttura mitografica e autopromozionale, che dura almeno quattro o cinque decennî. Dal mito di Rosai, creato negli anni Trenta e a cui contribuì anche Persico con Berto Ricci (mito che è alle origini dell’immagine di artista leader, gufino prima e antifascista poi, che Guttuso deposita sulle pagine di Primato), arriviamo tranquillamente, passando per gli artisti di Corrente, all’Arte Povera, o almeno al packaging curatoriale di Arte Povera, ma anche alla postura di alcuni artisti che fanno parte del gruppo. È una sopravvalutazione all’origine di autoinvestiture discutibili; e di reputazioni da rivedere.
Giusto a proposito di Arte Povera, nel testo si menziona un passaggio di Luciano Fabro che, in qualche modo, afferma che critici e storici si muovono nell’ignoranza delle motivazioni più riposte del processo creativo. Occorrerà quindi tornare a studiare buona parte dell’arte del dopoguerra alla luce di queste considerazioni, anche perché gran parte della critica s’è concentrata sullo studio dei rimandi tra arte italiana ed altre esperienze, su tutte probabilmente quella americana, senza però soffermarsi sulle spinte interne che ci sono e che sono forti perché, cito dal Suo libro, nell’arte del dopoguerra persistono “istanze di animazione interna, numinosità, o trascendenza dell’immagine”. Si fa l’esempio della propensione estatica e della disponibilità pressoché cultuale all’immagine di certi movimenti, dallo spazialismo all’Arte Povera. Tutto questo deriva da una “memoria” che, cito ancora, “attende di essere restituita in parole”... cosa fare dunque per restituire questa memoria?
Fare storiografia, cioè scrivere storia, non significa parafrasare, genuflessi per lo più, quelli che gli storici chiamano gli ego-documenti, cioè le autotestimonianze, la memorialistica corrente, e le dichiarazioni rese dai protagonisti o dai loro contemporanei. Questa è una preliminare avvertenza di metodo. Fare storia significa vagliare criticamente non solo i documenti primarî ma anche i documenti secondarî, cioè la memorialistica e le autotestimonianze. Noi tendiamo spesso, come storici dell’arte contemporanea, a impugnare il microfono con cui l’artista parla: questo non è fare storia, ma è contribuire più o meno consapevolmente a una mitografia. Non sta su un piano scientifico, non sta su un piano di memoria finalmente accettata e condivisa. Il passaggio per me importante su determinate sopravvivenze che legano primo e secondo Novecento è legato a un’estetica in qualche maniera religiosa, se non a un’antropologia cattolica, cristiana, consapevolmente tale dell’artista italiano o latino (come ancora Penone si è autodefinito pochi anni fa). L’immagine italiana (e i monocromi italiani sono lì a testimoniarlo, così come certe opere di Paolini), suscita venerazione, adorazione, si attende un atteggiamento che Longhi definirebbe “affettuoso” o adorante. Gli “antichi Maestri” sono qui Giotto, Piero della Francesca, il Raffaello della Madonna Sistina. Gli incunaboli di una simile tradizione sono cultuali, non prossimi al giornalismo. Se alle tue origini hai Hogarth è chiaro che è diverso. E su questo, fino agli anni Settanta, si è molto riflettuto, al di là di antitesi del tutto estemporanee come quella tra fascismo e antifascismo che di certo aiuta a comprendere ben poco della storia dell’arte italiana del Novecento che, nella seconda metà, soprattutto fino a una certa data (fino cioè al cavallo appeso al soffitto di Cattelan che congeda tutto, e congeda un qualsiasi tragico inscritto nelle pratiche artistiche), è una storia di resistenza e tentativo di sopravvivenza, molto abile, nel senso che si tratta sempre di inoculare attitudini divergenti all’interno di un international style che si tratta di volta in volta di aggiornare. È un’operazione tutt’altro che banale e ovvia, di cui noi sembriamo non sospettare minimamente la portata né la difficoltà.
Il saggio su De Felice è utile anche per fornire un’inquadratura di quello ch’è stato il rapporto tra artisti e intellettuali e “idea di nazione”, un rapporto sofferto dal momento che l’Italia del dopoguerra si è misurata con la difficoltà nel trovare elementi o tratti che potessero dar vita a un senso d’appartenenza. Le conseguenze di queste difficoltà si fanno sentire ancor oggi, tanto che questo processo di unificazione, o almeno di reperimento di motivazioni comuni, non sempre è andato per il verso giusto. Qui mi viene in mente la mostra di Palazzo Strozzi dell’ultima primavera, dove Luca Massimo Barbero sosteneva la tesi dei primi anni Sessanta come “momento di rinascita per l’Italia” e momento in cui “la nazione si riconosce nelle arti e nella loro contemporaneità”. Una tesi che mi è parsa un po’ semplicistica, dal momento che le divergenze allora erano molte: qui vorrei citare Emilio Gentile che, nella sua recente Intervista sul Risorgimento, ha al contrario sottolineato come già nei primi anni Sessanta fosse evidente quello che lui definiva “l’oblio del senso di unità nazionale”, una carenza che, secondo Gentile, sarebbe andata accentuandosi negli anni. Possiamo individuare in queste difficoltà e queste carenze un insieme di tensioni che hanno portato, tra le altre conseguenze, a una sostanziale marginalità, per non dire irrilevanza, dell’arte nell’attuale dibattito politico?
Non c’è dubbio che Gentile colga un problema reale. D’altra parte come potrebbe essere altrimenti per una nazione che, considerata sotto profili artistici e culturali, ha avuto una storia così illustre per duemila anni, ma considerata geograficamente, e lacerata la bolla (perché di bolla si è trattato: in senso geopolitico, economico, militare) dell’“Impero” fascista, si scopre divenuta marginale? Per forza si crea una tensione tra due “nazioni”, quella artistico-culturale da una parte e quella politico-istituzionale dall’altra: una tensione molto forte che non esiste in nessun’altra nazione occidentale, neppure in Germania. Quindi l’idea che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta una “nazione” si rinasca per via artistica e si erga così su solide basi è davvero improbabile. Trovo qui una coda abbastanza esausta dell’atteggiamento apologetico (o “militante”) di cui sopra: che toglie alla storia dell’arte (o alla curatorship) una qualsiasi inquietudine e brillantezza critica. E’ vero invece che tra Sessanta e Settanta, come mi auguro di dimostrare in saggi di prossima pubblicazione, emerge e diviene esplicito, se non un rifiuto della Repubblica come tale, certo la contestazione dell’antifascismo repubblicano. Sulla traccia magari di un’estrema sinistra anti-PCI e alla luce di un impegno pedagogico che i governi del centro-sinistra avevano preso dopo i fatti del 1960 e il pericolo di svolta autoritaria a destra del governo Tambroni. Solamente nei primi anni Sessanta si desta una coscienza dei limiti di un certo antifascismo, del moderatismo di un certo antifascismo repubblicano che, in nome di una pretesa eredità resistenziale, si era in realtà guardato bene dal fare i conti con il Ventennio.
 |
| Sala della mostra Nascita di una nazione a Firenze, Palazzo Strozzi, 16 marzo - 22 luglio 2018 |
Una lettura più approfondita, peraltro, ci consentirebbe anche di affrontare l’attualità in maniera più raffinata e più ponderata.
Ci permetterebbe di non stupirci se vediamo che ancora oggi si va delineando il pericolo di un crollo dello stato unitario, con un governo in cui componenti meridionalistiche e nordistiche stanno insieme in maniera abbastanza funambolica sullo sfondo di un’Italia che certamente ha due velocità, due tempi, due antropologie, due sistemi di distribuzione della ricchezza e di usi o culture del potere. D’altra parte gli anni Venti e Trenta sono decennî in cui, a differenza di oggi, si discute liberamente sul problema dell’unificazione, su quella che al tempo si chiamava la “conquista regia”, mostrandone i limiti di sostanziale annessione dinastico-militare che non aveva assolutamente preparato, né prima, né subito prima, né nei decennî successivi, una coesione culturale. Gian Enrico Rusconi, che certamente non è un fascista ma è uno storico e sociologo moderato, di grande competenza e preparazione, alcuni decennî fa parlava di “motivazioni dello stare insieme”, cioè l’essere fedeli, reciprocamente corretti, onesti, pagare le tasse, portarsi reciproca fiducia: tutto questo in Italia manca, e non possiamo davvero pensare che il problema non esista o non debba essere o nominato o che tanto meno l’arte degli anni Sessanta-Settanta l’abbia risolto. Sono fantasie che fanno ridere, fumetti per adolescenti.
Infine, per concludere, nel saggio su De Felice si avanza il problema della sopravvivenza della “religione politica o patriottica o civile” nel dopoguerra, un problema di ampia portata e che pertanto, si sottolinea nel libro, nello spazio di un saggio breve può essere affrontato solo in maniera preliminare. Si tratta quindi di un preludio a nuovi lavori e nuovi studî su questo tema, che dovremo aspettarci in futuro?
Sì, si tratta di un preludio, e infatti nell’introduzione presento questo libro come le prime giornate di un ampio affresco a venire. O anche: i saggi del libro sono tre tarsie, tre tessere di un mosaico che si sta costruendo nel tempo. Adesso sono in uscita due saggi nuovi su due riviste di fascia accademica ma che entro breve saranno raccolti in libro sul mito dell’“artista giovane”, un mito transideologico a cavallo tra anni Venti e Trenta (io analizzo soprattutto il consenso che si forma attorno a Rosai da una parte e la narrazione racchiusa nel testo Via Solferino di Persico: le ideologie implicate sono diverse, ma di fatto convergenti). A breve ne seguiranno altri, tra cui una rilettura in chiave storico-politica di Carla Lonzi.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Piazza dei Miracoli dietro le quinte: parla Gianluca De Felice, segretario dell'Opera della Primaziale

“Peggy Guggenheim: una donna gentile, aperta e semplice”. Parla Živa Kraus, artista, gallerista e collaboratrice di Peggy







































