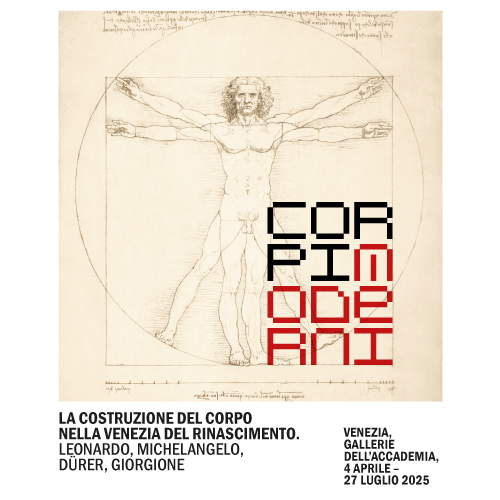Isao Sugiyama. Quarant'anni in Italia, alla ricerca del dialogo tra uomo e natura. L'intervista
Nato a Shizuoka, in Giappone, nel 1954, Isao Sugiyama è un artista che dal 1983 vive e lavora in Italia, a Carrara. Il suo percorso comincia dall’arte figurativa per approdare poi ai Santuari, la serie che dal 1989 caratterizza il suo lavoro, e che Sugiyama non ha mai abbandonato. Artista molto apprezzato dal mercato, presente in diverse edizioni delle fiere più prestigiose (da Art Basel ad Art Brussels, da Arte Fiera alla FIAC di Parigi), con i suoi Santuari ha sperimentato un linguaggio che propone al pubblico occidentale diversi elementi del modo di guardare alla natura dei giapponesi. In questa intervista di Federico Giannini abbiamo ripercorso la carriera di Isao Sugiyama, che tra pochi giorni tornerà in Giappone dopo aver trascorso quasi quarant’anni in Italia, e abbiamo approfondito il suo linguaggio.

FG. Com’è nata la Sua passione per l’arte e come ha deciso di diventare un artista quand’era ancora in Giappone?
IS. Avrei voluto diventare architetto, quando studiavo al liceo. Ho seguito allora corsi di matematica, fisica e materie simili: avevo in mente di percorrere quella carriera. Tuttavia l’ultimo anno di liceo cambiai idea: il fatto è che pochi architetti in Giappone all’epoca erano in grado di arrivare al massimo, e per me sarebbe stato difficile, seguendo quella carriera, esprimermi al meglio. Ho deciso allora di dedicarmi alla scultura per essere più libero. Prima di entrare all’Università di Belle Arti di Tokyo-Zokei e studiare scultura, ho studiato storia dell’arte e sono rimasto affascinato da una scultura di Picasso, She-Goat: mi pareva molto più realistica quella di ciò che l’arte naturalista aveva prodotto. Non riesco però a spiegare perché: mi sembrava però molto reale, e allora decisi che la scultura sarebbe diventata la mia forma d’arte. E poi m’interessava più la terza dimensione della bidimensionalità della pittura. All’università ogni giorno modellavo con la creta, anche dal vero, e ho fatto questo per quattro anni. Poi, all’ultimo anno di studi, cominciai a scolpire il granito, rimanendo sempre su uno stile figurativo. Dopo la laurea ho seguito un corso di specializzazione, e l’ultimo anno ho partecipato a un simposio a Tokyo: fu allora che un mio professore mi consigliò di andare in Italia, perché riteneva utile che io guardassi un altro mondo. All’epoca già lavoravo: avevo fatto il camionista e stavo facendo l’insegnante, guadagnavo abbastanza, e quindi non volevo andare in Italia, non mi interessava andare all’estero.
Cos’è invece L’ha spronata poi a seguire il consiglio del Suo docente?
Il mio professore aveva... spinto molto per mandarmi in Italia. Poi due persone che conoscevo erano state a Carrara e avevo ascoltato la loro esperienza. Decisi allora di trasferirmi e di iscrivermi all’Accademia di Belle Arti di Carrara. È stato un cambiamento totale della mia vita .
Cosa pensava di trovare a Carrara?
Volevo intanto cambiare il mio modo di lavorare: non avevo mai scolpito il marmo, avevo lavorato soltanto sul granito, quindi era un’esperienza del tutto nuova. All’inizio non è stato facile, e parlo proprio del rapporto con Carrara. Non avevo soldi, non ero ricco, non ero neanche bello, e ho trovato delle difficoltà ad ambientarmi. Poi appena arrivato a Carrara sono stato derubato, e anche truffato: avevo preso un fondo in affitto, e con il proprietario ci eravamo accordati per fare lui io il contratto per la luce e lui quello per l’acqua, perché nel fondo non c’era ancora niente. Io ho fatto subito il contratto e ho iniziato a pagare, lui invece non ha fatto niente per la sua parte per più di due mesi, e io ero davvero arrabbiato per questa cosa. Poi per fortuna alcuni abitanti mi aiutarono e quella storia si chiuse. Trovai allora un altro laboratorio, che però era pieno di infiltrazioni d’acqua, quando pioveva si allagava sempre. Lavoravo assieme al proprietario del fondo, che faceva lo sbozzatore, e parlava soltanto in dialetto carrarese, poi bestemmiava di continuo. Tutti i giorni parlava al telefono con la madre e le chiedeva di andarlo a prendere finito il lavoro: le prime frasi che ho imparato in italiano sono una in dialetto che lui diceva a sua madre tutti i giorni (“O ma’, ven’m a piar’”, cioè “Mamma vieni a prendermi”), e poi le bestemmie. Però era una bravissima persona, simpatica, gentile, che mi ha insegnato anche come si usano gli strumenti per lavorare il marmo. Dopo poi trovai un terzo laboratorio, decisamente più confortevole. Nel frattempo continuavo a frequentare l’Accademia, ma diciamo che passavo in laboratorio all’incirca il 70% del mio tempo. All’epoca continuavo a fare arte figurativa, perché comunque il marmo era per me una materia nuova.



È stato difficile imparare a lavorare sul marmo?
Sì, io ero abituato a usare un granito nero del Giappone che è un materiale molto forte, che ha una forte resistenza. Il marmo invece è più morbido e ha un aspetto completamente diverso. Era difficile per quello che volevo esprimere, le mie opere di quel tempo trasmettevano anch’esse un’idea molto forte. Col marmo però ebbi modo di cambiare stile, resi meno spigolose le mie opere, lavorando di più sui piani. Per modificare il mio stile figurativo studiavo i maestri italiani moderni: studiavo le opere di Marino Marini, Pericle Fazzini, Emilio Greco, Giacomo Manzù, artisti del nuovo figurativo italiano che avevo già visto in Giappone. Vedere tutto dal vivo fu un grande shock, perché prima in Giappone guardavo più all’arte francese, come Rodin e Maillol, e nell’arte italiana del tempo trovavo una maggiore libertà, e poi la trovavo più innovativa. Anche questa fu una ragione del mio trasferimento in Italia. Fui deluso dal fatto che non riuscii a conoscere nessuno di loro di persona, perché alcuni di loro erano morti da poco quando mi trasferii in Italia e Manzù, che era l’unico ancora in attività, non riuscii a incontrarlo, nonostante il mio professore a Carrara fosse in contatto con lui. Poi capitai in un periodo in cui (arrivai in Italia nel 1983) l’arte del momento era la transavanguardia, non c’era rivista d’arte che non ne parlasse: io però preferivo guardare anche all’Arte Povera, che avrebbe poi avuto un certo impatto sul mio stile. Mi piaceva molto, per esempio, Giuseppe Penone (e mi piace tuttora!): mi impressionava il suo modo di scavare i tronchi lasciando solo l’involucro. Mi sento dunque molto vicino ai poveristi, anche a Mario Merz, per esempio.
Qual è invece il suo rapporto con l’arte antica?
Quando ero all’Accademia giravo spesso per vedere l’arte antica. C’è da dire che sono sempre stato un pessimo studente (mi interessava più la pratica della teoria) quindi in Giappone non mi ero mai interessato più di tanto all’arte italiana. Però quando sono arrivato in Italia ho cominciato a studiare la storia dell’arte italiana (su libri giapponesi, perché capivo poco l’italiano). Ho girato allora per tanti musei, per vedere tutta l’arte, da quella greca e romana a quella rinascimentale, da quella moderna a quella contemporanea. Girai per diverse settimane: Roma, Firenze, Venezia, Milano... ma dopo aver visto le opere dei grandi maestri del passato provai enorme sconforto, pensavo che non si potessero superare. Ero arrivato al punto di pensare che avessero già detto tutto loro e quindi non sentivo la necessità di aggiungere la mia arte figurativa.
Fu questo allora il motivo che la portò a cambiare completamente linguaggio abbandonando il figurativo?
No, in realtà a quel tempo non volevo cambiare linguaggio... volevo proprio smettere! Mi sentivo deluso, demoralizzato. Per qualche tempo sono stato fermo, volevo tornare in Giappone, sconfitto. Però prima di tornare in Giappone volevo vedere anche i musei francesi: non ero mai stato al Louvre e al Pompidou, erano due musei che volevo vedere. Prima di ripartire allora feci un viaggio a Parigi, e dedicai tutto il primo giorno al Louvre. Non riuscivo a staccarmi dalla Gioconda, rimasi trenta minuti davanti a lei, vicino, da mezzo metro di distanza, perché all’epoca ci si poteva avvicinare più liberamente di adesso. Quella visita accentuò quel senso di sconfitta che provavo, perché rimasi impressionato da quel lavoro. Poi il giorno dopo andai al Pompidou, e vedendo le opere astratte e non figurative cambiai idea: all’epoca ero ossessionato dal trovare delle nuove strade nel figurativo, e non avevo preso in considerazione l’idea di esprimermi con un linguaggio diverso. Mi domandai se potessi allora fare qualcosa di più personale, se potessi cercare un altro modo di esprimere il mio sentimento e le mie idee. Tornai allora a Carrara e cominciai a provare tante altre cose, e mi presi un anno per sperimentare con il marmo. Così a un certo punto iniziai un altro percorso.







Com’è cambiata allora la Sua arte in seguito?
Iniziai a interessarmi ai linguaggi postmoderni. Pensavo che voi occidentali avete secoli di storia a cui guardare, per noi giapponesi invece è più difficile: dopo la rivoluzione Meiji [1866-1869, ndr] si cominciò a “importare” dall’estero anche l’arte. Lo stesso concetto di “arte” in Giappone è nato centocinquant’anni fa. Nella nostra cultura non esisteva prima un concetto di “arte” simile a quello occidentale, e dovevo quindi cercare un punto di riferimento nella nostra storia, pensando a quello che avevo studiato in Giappone. Inoltre, pensavo che dovessi tornare a ciò che mi piaceva da bambino: ero appassionato di modellismo, e questa passione mi ha ispirato per l’ossatura della mia nuova arte (mi piace pensare alla mia arte come costituita da un’ossatura). Ho creato così la mia prima opera nuova, agganciando una struttura di legno al marmo: l’avevo pensata semplicemente guardando a una finestra. Mi sembrava di aver creato un santuario: è cominciata così la serie dei Santuari, alla quale lavoro tuttora.
Come ha influito l’Arte Povera sui Santuari, se in qualche modo ha influito?
Sicuramente ha avuto un impatto, ma è difficile per me da spiegare. Si tratta essenzialmente di un fatto di materialità: trovo che l’Arte Povera sia molto materiale. Prima, quando facevo figurativo, per me l’arte era essenzialmente un problema di forme e di significati, e trascuravo un po’ troppo il materiale. L’Arte Povera mi ha fatto cambiare idea su questo aspetto, il materiale adesso per me è fondamentale. Il materiale parla: una struttura di legno parla, un pezzo di marmo parla. Anche per questa ragione ho scelto di lavorare lasciando spesso le forme al naturale (per creare i santuari scelgo con cura i pezzi di marmo direttamente alle cave e su quelli poi costruisco i santuari): è un dialogo tra natura e struttura. Un altro tema poi è quello del tempo: il marmo è un minerale, il legno è vegetale, e col passaggio del tempo la parte del legno marcisce e sparisce, mentre il marmo rimane. Quando il legno sparisce, rimane un marmo con un buco: è il segno del passaggio del tempo. Ci ho pensato quando ho visitato per la prima volta Roma e i suoi resti archeologici: anche l’archeologia, in questo senso, mi è piaciuta e mi ha ispirato.
Perché lascia le forme al naturale quando crea i Santuari?
In Giappone abbiamo un grande rispetto per la natura. Quando costruiamo un edificio o un tempio facciamo in modo che l’intervento sulla natura sia il minimo possibile. Se c’è una pietra nel luogo dove va costruito qualcosa, non togliamo la pietra: ci giriamo attorno, oppure ci costruiamo sopra, ma senza alterarla, e se proprio si deve, l’intervento sarà minimo. L’idea è che una volta che l’architettura non ci sarà più, l’elemento naturale si dovrà vedere esattamente com’era prima che venisse costruita. Dopo essere arrivato in Italia ho avvertito molto la differenza con l’Occidente: gli occidentali cercano soprattutto di conquistare la natura, e hanno semmai dei ripensamenti dopo. Gli orientali invece prima chiedono alla natura. Secondo la religione giapponese, lo shintoismo, esiste un dio per ogni elemento della natura (un albero, una montagna, la luna, tutto ha una sua divinità), e ogni volta che si costruisce bisogna chiedere il permesso alla divinità: si fa una cerimonia, si fanno offerte agli dèi, si prega, e questo ci mette in forte rapporto con la natura.
E dopo aver iniziato i Santuari è iniziato anche il successo.
Sì, il lavoro è letteralmente decollato, volevo lavorare continuamente a questo progetto, avevo molte idee. Ho cominciato a fare le prime mostre: la prima alla Galleria del Naviglio di Milano, nel 1989. C’erano tre sale nella loro sede: me ne concessero una, mentre nelle altre due, nello stesso periodo, c’era un importante maestro del figurativo. Inizialmente provai un po’ di sconforto perché io riuscii a vendere solo tre pezzi, mentre l’altro artista riuscì invece a vendere l’80% di quello che aveva portato in mostra, e pensavo che per me non ci sarebbero state altre possibilità, pensavo di non avere futuro. Chiesi comunque al direttore della galleria, Renato Cardazzo, se potessi continuare a collaborare con lui, e un po’ inaspettatamente mi disse di sì: “tu produci tanti santuari”, mi disse. Allora mi misi al lavoro e dopo qualche tempo mi propose di portare le mie opere ad Art Basel. Non sapevo che fosse una fiera così grande e così importante: la galleria mi propose alla commissione della fiera e loro mi accettarono, così ebbi l’occasione di fare una mostra personale allo stand del Naviglio, riuscendo anche a vendere il 70% delle opere. Dopo quell’occasione, che fu un successo, ricevetti tantissime richieste: c’erano 30 o 40 gallerie che volevano rappresentarmi, e accettai alcune offerte, per esempio quella della Galerie Claude Bernard di Parigi. E poi tanti collezionisti si interessarono al mio lavoro: così ebbi modo di entrare nel mondo dell’arte anche... dal punto di vista economico, che era una cosa diversa rispetto a quello immaginavo, perché pensavo che l’aspetto artistico fosse del tutto staccato da quello economico. Ma in realtà la verità è che se non vendi non puoi produrre. Nel mio caso sono stato fortunato, perché sono entrato nel mondo del collezionismo che mi ha permesso di continuare per tutta la vita il mio lavoro.







Ci sono persone che ha incontrato durante il Suo percorso in Italia e che ricorda con particolare piacere?
Sì, ce ne sono diverse. Inizierei con Ottavio e Rosita Missoni. Conobbi Rosita alla fiera di Bologna: comprò una mia scultura come regalo di compleanno per Ottavio Missoni. Dopo la fiera di Bologna, in una mia personale a Milano, la incontrai proprio nel giorno del compleanno di Ottavio, e dopo la festa molti invitati vennero in galleria a vedere il mio lavoro, dopo che avevano visto il regalo. Alcuni poi sono diventati miei collezionisti. Poi ho un ottimo ricordo di Fausta Squatriti, che fu mia professoressa dell’Accademia di Carrara: mi ha dato molti suggerimenti, ed è grazie a lei che sono arrivato a Milano. Andavo spesso da lei anche dopo le lezioni perché gli argomenti che spiegava per me erano ostici e volevo approfondire. In uno di questi incontri mi chiese se avessi mai esposto le mie opere in una mostra. Io risposi di no, perché non ero rappresentato da nessuna galleria, non conoscevo nessun gallerista. Lei all’epoca mi presentò ad alcune gallerie: la prima che mi rappresentò fu lo Studio 111 di Milano, che era gestita da Vittoria Marinetti, figlia di Filippo Tommaso Marinetti, e poi la seconda fu il Naviglio. Ho un ottimo ricordo anche di Renato Cardazzo, che era allora direttore del Naviglio, aveva grande carisma. Ricordo un episodio particolare legato allo Studio 111: Vittoria Marinetti appena vide le mie opere mi chiese di portarne subito tre a Milano, e riuscii a venderle immediatamente. Col Naviglio invece il successo non fu così immediato. Però riuscii a sfiorare la Biennale di Venezia: nel 1990 la Biennale aveva anche una sezione per gli artisti sotto i 35 anni, si chiamava Aperto ‘90. Cardazzo conosceva uno dei curatori, e gli presentò il mio lavoro proponendolo per la Biennale, che piacque al curatore. Era il 1989, Aperto ‘90 era in preparazione: io avevo appena compiuto 35 anni, ma quando la Biennale sarebbe cominciata, ne avrei avuti 36... quindi non potei partecipare. Fu allora che il Naviglio, forse anche per mitigare un po’ la delusione, mi propose la prima personale. Infine, due critici e giornalisti: Giorgio Soavi e Sebastiano Grasso, che hanno scritto i primi testi per le mie opere. Con i loro scritti hanno fatto in modo che tanti si interessassero al mio lavoro e venissero a vedere le mie opere alle mostre. Quindi lo devo anche a loro se a tanti a quell’epoca il mio lavoro è piaciuto.
Chiudiamo con una domanda forse difficile: cos’è per Lei l’arte?
Quand’ero giovane avrei risposto in tanti modi diversi. Ora però dico che, secondo me, l’arte è un desiderio. Quando si progetta qualcosa, quando s’immagina gli effetti che può suscitare, quando si crea qualcosa e si vede realizzato quello che si pensava, si prova un’emozione forte, che non saprei descrivere, ma che per me è più forte di emozioni che si provano per esempio quando si mangia o si fa l’amore, che sono anche questi desideri, ma l’arte è un desiderio più emozionante, perché per un artista l’effetto è molto più forte. È come un’estasi. E quindi continuerò a progettare e a realizzare anche per cercare di provare questi momenti di estasi.
Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!
La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).