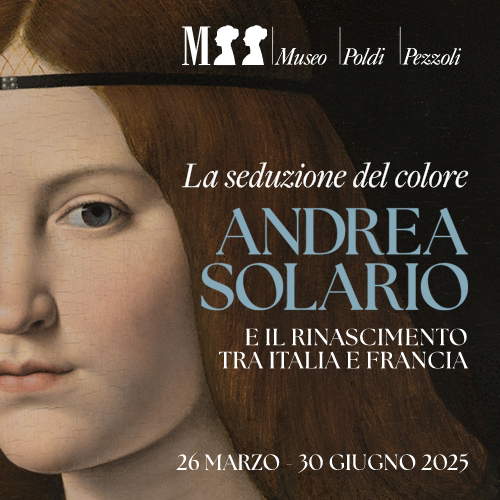Qatar e non solo. Come si fa ad avere un Padiglione alla Biennale di Venezia?
Il Qatar avrà un suo padiglione permanente ai Giardini della Biennale di Venezia: sarà centralissimo, a cavallo tra quello della Finlandia, quello della Danimarca, il padiglione centrale, e il padiglione del libro di Stirling. Lo ha annunciato il 12 febbraio, in un comunicato che ha sollevato qualche perplessità tra le fila dell’opposizione veneziana dato che non c’è ancora stata autorizzazione a costruire né concessione del terreno demaniale. Il presidente di Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha invece commentato la notizia così: “Nello spirito della curiosità, dell’esplorazione e dei sinceri scambi tra popoli che caratterizzano Venezia e la sua Biennale, desidero dare il benvenuto al Qatar nei nostri Giardini, come potente fonte globale di creatività e comprensione tra diverse culture”. Ma, retorica celebrativa a parte, come mai al Qatar, che finora non ha mai partecipato a una Biennale veneziana, è stato concesso (o meglio sarà concesso, ormai è una formalità) di costruire un padiglione permanente ai Giardini, mentre tanti altri paesi non ce l’hanno?
Una breve sintesi di contesto per chi conosce poco i Giardini della Biennale, a Castello, il luogo in cui la fiera nacque nel 1895. Un nuovo padiglione permanente lì è un fatto davvero molto, molto eccezionale. Gli unici due stati, negli ultimi 50 anni, in cui è stato concesso di costruire ai Giardini sono stati l’Australia (1987) e la Corea del Sud (1995). Per una ragione di spazi, ormai decisamente limitati, ma anche di ambiente storicizzato: i padiglioni nazionali, cresciuti uno dopo l’altro soprattutto nella prima metà del Novecento, allo stabilizzarsi di quella che inizialmente era una normale fiera internazionale d’arte, rappresentano gli Stati che, in una fascia temporale che arriva ai primi anni Sessanta e al periodo dell’indipendenza delle ex colonie, avevano peso a sufficienza per ottenere il rilascio di una concessione demaniale di lunga durata dal Comune di Venezia stesso, a volte proprietario del terreno, altre volte proprietario anche del padiglione stesso. Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Russia, Stati Uniti, e poi Brasile, Jugoslavia, Polonia... L’unico stato africano rappresentato ai Giardini è l’Egitto, ospitato dal 1952 in un edificio costruito nel 1932. Per esporre ai Giardini con un padiglione permanente, c’è insomma bisogno di una concessione demaniale specifica: di norma sono di lunghissima durata (per il nuovo padiglione del Qatar si parla di 90 anni) e per costi simbolici, tanto che nel 2023 il sindaco Luigi Brugnaro aveva manifestato la necessità di rivederle al rialzo, anche perché molte erano e sono scadute.



Per fare spazio a tutti gli stati che ai Giardini non ci stanno, la Biennale ha riconvertito già dal 1980 l’area dell’Arsenale, dove espongono altre decine di nazioni. In questo caso serve, per avere un padiglione lì, una convenzione con Biennale (che ha in gestione l’area per conto del Comune), a cifre da concordare. Altrimenti è possibile esporre dove si preferisce in giro per la città: palazzi, ex magazzini, chiese sconsacrate, possono chiedere affitti importanti per fare spazio a padiglioni nazionali temporanei. Insomma, se la partecipazione degli stati nazionali alla Biennale di Venezia (qualora questi stati siano riconosciuti dal Governo italiano) è completamente gratuita, il problema è il costo per ottenere uno spazio espositivo, tanto più se lo si vuole non marginale.
Avere un padiglione permanente quindi fa un’enorme differenza, a livello economico ma anche simbolico. Motivo per cui, facendo un certo scalpore, nel 2024 la Bolivia ha potuto partecipare perché ospitata gratuitamente nel padiglione (permanente) della Russia ai Giardini, centralissimo e molto spazioso: tutto regolare, lo Stato che è titolare della concessione (la Russia) può farci quel che vuole, anche non partecipare e ospitare altri. In questo modo, volenti o nolenti, i Giardini di Biennale sono diventati, o sono sempre stati, uno spazio anche di geografia politica, quantomeno artistica: forze emergenti, quali l’Arabia Saudita (presente all’Arsenale), la Nigeria, la Costa d’Avorio (queste ultime due invece con padiglioni temporanei in spazi in città), non ci sono. Mentre le potenze del Novecento ci sono tutte, anche quelle nel frattempo... un poco depotenziate.
Il Qatar, in quel nuovo padiglione (altezza massima 8 metri, secondo le bozze della concessione) potrà quindi non solo esporre la nuova scena artistica qatarina, ma anche esercitare un soft-power su tutti quei paesi e artisti arabi e non che un padiglione alla Biennale non possono permetterselo, e potranno essere ospitati. Ma in breve, tornando alla domanda d’apertura, come ha fatto a ottenere una concessione a costruire che non veniva concessa da 30 anni, in uno spazio in cui ne sono state date, letteralmente, cinque dagli anni Settanta ad oggi? Una risposta ufficiale non c’è, ma sappiamo che ha scelto di stringere i legami con tutte le istituzioni veneziane.
Firmando un protocollo, portando nuovi investimento sull’aeroporto, e un volo Doha-Venezia, ma soprattutto donando 50 milioni di euro al Comune di Venezia, nel 2024: non c’è un legame ufficiale e dichiarato tra la “donazione” e il padiglione (nell’atto si chiarisce invece che per i 50 milioni il Qatar dovrà essere definito “benefattore” per 30 anni e la ministra Sheikha Al Thani riceverà la cittadinanza onoraria di Venezia) ma appare essere stata determinante, dato che il padiglione viene proposto proprio nel momento della donazione.
Cambia la geografia dell’arte contemporanea, cambia e cambierà anche quella, fisica, della Biennale di Venezia. Come, e quanto velocemente, è difficile a dirsi, dato che le regole, come visto, sono quasi tutte basate su convenzioni e accordi stipulati caso per caso.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Leonardo Bison
Dottore di ricerca in archeologia all'Università di Bristol (Regno Unito), collabora con Il Fatto Quotidiano ed è attivista dell'associazione Mi Riconosci.