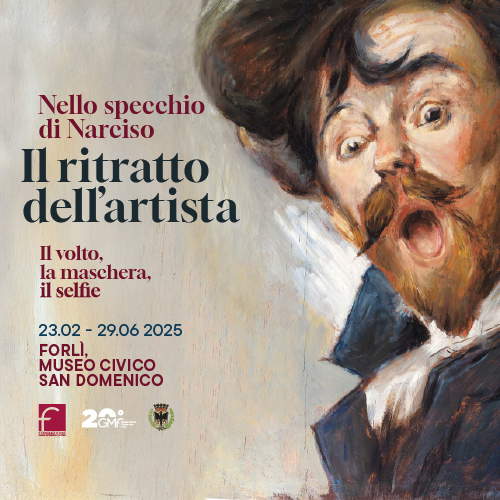Il Louvre restaura le Quattro Stagioni di Giuseppe Arcimboldo
Importante restauro al Louvre che fa risplendere una serie di Giuseppe Arcimboldo (Milano, 1526 – 1593), le Quattro Stagioni, dopo un intervento durato otto mesi, da maggio 2023 a fine gennaio 2024, e realizzato da Roberto Merlo del laboratorio Arcanes, nell’ambito del laboratorio del Centre de recherche et de restauration des musées de France – C2RMF (Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia). Le “teste composte” hanno ritrovato uno sfondo nero solido e profondo che permette loro di esprimersi al meglio, ma non solo: l’intervento ha rivelato una tavolozza luminosa e variegata, che conferisce ai volti un’espressione più sottile e ambigua. Il dialogo immaginato da Arcimboldo tra le quattro stagioni ne risulta quindi molto più animato e vivace. Una volta terminato il restauro, le cornici sono state adattate dal laboratorio di corniciatura-doratura del museo, in coordinamento con il reparto Dipinti, al fine di migliorare la presentazione delle opere restaurate. Il pubblico può ammirare i quattro dipinti nella Grande Galerie a partire da mercoledì 5 giugno.
I quattro dipinti del ciclo delle stagioni di Arcimboldo presentavano un aspetto ingiallito, dovuto all’ossidazione delle vernici di restauro che presentavano anche sbiancamenti. Si è deciso per il restauro al fine di ottenere una migliore leggibilità delle opere e una gamma cromatica più vicina a quella desiderata dall’artista. Le specifiche iniziali prevedevano una semplice riduzione della vernice. Ma presto è sorta la questione del trattamento della ghirlanda di fiori che ricopriva i bordi delle composizioni. Si sapeva che si trattava di un’aggiunta successiva di Arcimboldo, che disegnava sempre le sue teste composte su fondi neri pieni. Questi festoni erano stati sicuramente dipinti in occasione della modifica del formato delle tele originali, tagliate e poi ingrandite ciascuna su due lati, uno verticale e uno orizzontale, una prima volta nel Settecento e una seconda volta verso la fine del XIX secolo o l’inizio del XX secolo. Durante il restauro, l’analisi chimica dei pigmenti ha indicato che queste ghirlande erano meno antiche di quanto si credesse e risalivano nella migliore delle ipotesi al XVIII secolo. Inoltre, l’imaging scientifico (radiografia e riflettografia infrarossa) ha dimostrato che questi fiori coprivano circa 4 centimetri del dipinto originale su tutti e quattro i bordi, nascondendo non solo lo sfondo nero pieno, ma anche le parti significative del dipinto, e cioè le teste composte, così come lo stemma con l’arma di Meissen sull’Inverno, simbolo dell’elettore Augusto di Sassonia, primo destinatario delle opere.
I restauratori del Louvre hanno anche capito che i cambiamenti di formato, apportati a partire dal XVIII secolo, avevano sconvolto il perfetto allineamento delle teste e del loro sguardo. Con queste nuove scoperte si è pertanto deciso di rimuovere le ghirlande per ritrovare il materiale dell’Arcimboldo. Per i due lati della tela originale che non erano stati tagliati è bastato rimuovere il bordo floreale per mettere in luce lo strato pittorico sottostante, ben conservato. È così che sotto le ridipinture sono stati ritrovati diversi fiori che incoronano il capo della Primavera. Per gli altri due lati precedentemente tagliati, invece, il restauratore Roberto Merlo ha ripristinato gli elementi mancanti basandosi su una serie di copie molto fedeli, realizzate probabilmente nel XVII secolo. La rimozione della ghirlanda ha conferito alle figure leggibilità, ma anche un respiro e una monumentalità sorprendenti.
Ancora, il restauro ha evidenziato un ottimo stato di conservazione del materiale pittorico, con una tavolozza chiara e brillante. L’unica alterazione irrimediabile riguarda il pigmento blu che col tempo è diventato marrone. Arcimboldo lo ha usato nella Primavera per certe parti dei capelli e per l’iride che emergeva dal petto. Possiamo ora apprezzare la finezza della tecnica pittorica dell’artista che modula il colore così come l’ombra e la luce per descrivere con precisione le piante e dare loro rilievo creando così l’illusione del movimento e dell’espressione. Al termine del restauro, la disposizione delle cornici dei dipinti ha permesso di ritrovare l’allineamento delle vedute delle Quattro Stagioni, il cui dialogo può adesso nuovamente fiorire.




La storia delle Quattro Stagioni del Louvre
La storia delle Quattro Stagioni del Louvre, acquistate da un mercante d’arte nel 1964, potrebbe essere ripercorsa grazie a due indizi: le spade incrociate di Meissen, lo stemma della Sassonia che appare sul manto dell’Inverno, e la data 1573 incisa sulla spalla dell’Estate sotto la firma dell’artista. Thomas DaCosta Kaufmann collegò questi dati ad una nota del 28 luglio 1574, nei registri dei pagamenti della corte imperiale, in cui è annotato un pagamento di sessantacinque fiorini ad Arcimboldo per dipinti commissionati dall’imperatore Massimiliano II (1527 -1576) per l’elettore Augusto di Sassonia (1526-1586). La relativa imprecisione di questo documento è fortunatamente compensata dagli inventari della Kunstkammer di Dresda del 1595 e del 1610 che citano diverse composizioni dell’Arcimboldo tra cui le Quattro Stagioni. Nel 1629 le notò anche il viaggiatore Philipp Hainhofer e Tobias Teubel nel 1683.
Dopo questa data non c’è più traccia dei dipinti, che forse furono rimossi dalle collezioni di Dresda nel XIX secolo. DaCosta Kaufmann ha esposto chiaramente le circostanze politiche in cui le Stagioni di Arcimboldo furono offerte ad Augusto di Sassonia. Nel 1570 e nel 1573, questo principe protestante soggiornò alla corte cattolica dell’imperatore, per difendere la sua posizione di elettore contro le pretese di suo cugino Johan Wilhelm di Sassonia-Weimar. Da parte sua, Massimiliano II, ansioso di equilibrare le forze cattoliche e protestanti all’interno del suo impero, favorì i rapporti con questo sovrano che sostenne anche nel 1573 l’elezione di suo figlio Rodolfo a re dei Romani.
Di origine milanese, Giuseppe Arcimboldo si stabilì a Vienna nel 1562, al servizio dell’imperatore Ferdinando I d’Asburgo (1503-1564) poi del figlio Massimiliano II (1527-1576), per il quale assunse la funzione di ritrattista di corte. Sebbene dipinse i ritratti di diversi membri della famiglia imperiale, divenne presto famoso grazie a una serie di teste composite che rappresentavano le stagioni, gli elementi, le professioni e le personalità dell’epoca. Ogni dipinto è costituito da un insieme di piante, animali o oggetti vari che formano abilmente un busto e una testa, e che devono consentire il riconoscimento dell’identità del soggetto.
La prima serie delle Stagioni fu dipinta nel 1563 per l’imperatore Ferdinando I (oggi è conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna), poi fu ripetuta più volte. L’imperatore ne possedeva almeno due copie, e ne inviò alcune, oltre ad Augusto, al cugino Filippo II di Spagna. Le Stagioni adottano i codici della ritrattistica con una presentazione dei volti di profilo che cerca di attivare un dialogo con le immagini dell’antichità, come le monete della Roma imperiale. Capaci di suscitare stupore e divertimento, le composizioni di Arcimboldo nascondono tuttavia anche un significato politico molto raffinato. Una poesia di Giovanni Battista Fonteo offerta all’Imperatore nel 1569, contemporaneamente ad una serie di Stagioni e ad un’altra sugli Elementi, dà voce alle teste allegoriche che, ciascuna, rivela come la potenza dell’impero si sostanzi nell’infinito, durante l’eterno ciclo delle stagioni.
Le Stagioni ad ogni modo offrono particolarità formali che le distinguono dagli Elementi. Il fiore, frutto o verdura che si erge con chiarezza dal petto, come un gioiello prezioso, ha una presenza nella composizione che gli ornamenti piatti degli Elementi non hanno. Ma soprattutto sono le espressioni molto diversificate dei capolini a stabilire l’originalità iconografica delle Stagioni. Queste evocano le quattro età dell’uomo: infanzia, adolescenza, maturità e vecchiaia. Esprimono anche il temperamento legato ad ogni stagione: il carattere sanguigno della Primavera, collerico dell’Estate, malinconico dell’Autunno e flemmatico dell’Inverno. Questa triplice identità delle Stagioni ci invita a continuare il gioco delle corrispondenze con le altre parti della natura come i quattro elementi, i quattro principi, e così via. Questa concezione del funzionamento della natura per corrispondenza è caratteristica dello spirito del Rinascimento e si ritrova in altre opere o decorazioni dell’epoca. La singolarità delle Stagioni di Arcimboldo sta nella ingegnosa condensazione di queste corrispondenze in un’immagine unica, coerente e indipendente.
Augusto di Sassonia poté ammirare alla corte imperiale le invenzioni dell’Arcimboldo e comprenderne il significato simbolico e politico. Nella serie che gli veniva proposta scoprì una nuova versione dei dipinti in cui i simboli imperiali sono sostituiti dai suoi (le spade incrociate di Meissen). Le corrispondenze tra microcosmo, macrocosmo e potere politico, illustrate nelle Stagioni e negli Elementi e rivelate dal poema di Fonteo, si organizzavano ora attorno alla figura di Augusto,. Lusinghiera allegoria politica, le Stagioni erano anche suggestive immagini della discordia concors e dovevano indubbiamente illustrare agli occhi dell’elettore di Sassonia la volontà pacifica di Massimiliano, capace di riunire in una coerente unità le diversità del suo impero. Le Stagioni del Louvre si differenziano dal modello originale del 1563 (Vienna, Kunsthistorisches Museum) per la natura del supporto, essendo il legno sostituito da tela forse scelta per comodità di trasporto al destinatario. Il confronto con i dipinti di Vienna rivela lievi differenze nella composizione. Nell’Estate del Louvre il carciofo è più corto e non troviamo i due chicchi piccoli sotto la pannocchia. L’intreccio dei rami dell’Inverno è diverso nella versione viennese, e l’apertura della cavità che forma l’occhio è leggermente più aperta. L’inverno parigino, con questo occhio socchiuso, sembra più vivo o sveglio di quello viennese
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE