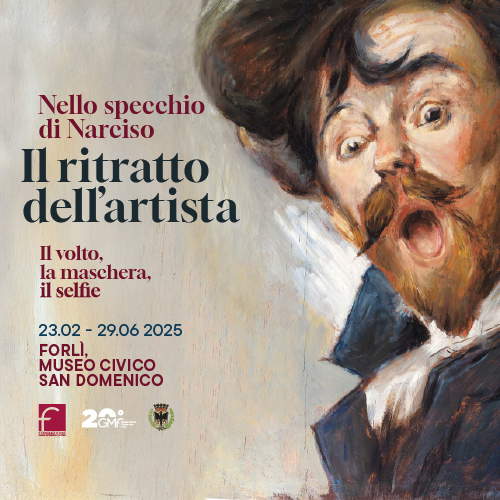Firenze, a TourismA 2025 il futuro degli scavi archeologici tecnologici e innovativi
Costellazioni di satelliti, droni, intelligenza artificiale e georadar stanno rivoluzionando il modo di esplorare il sottosuolo, permettendo di individuare siti archeologici senza la necessità di scavare. Questa trasformazione agevola la tutela del patrimonio storico e riduce sensibilmente i costi e i tempi per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere, evitando imprevisti a lavori già avviati.
Il tema sarà al centro degli appuntamenti organizzati dall’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) nell’ambito di tourismA – Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in programma a Firenze dal 21 al 23 febbraio 2025 presso il Palazzo dei Congressi (con ingresso gratuito). L’evento offrirà una panoramica sui nuovi strumenti tecnologici che stanno trasformando la professione dell’archeologo, rendendolo una figura chiave nei cantieri accanto a ingegneri e architetti.
Una rivoluzione tecnologica per la tutela e l’innovazione
L’archeologia preventiva è diventata uno strumento essenziale per conciliare sviluppo e conservazione, permettendo di individuare aree di interesse storico prima che i cantieri prendano il via. Questa pratica ha radici nella Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata alla Valletta (Malta), si è imposta come un metodo efficace per ridurre il rischio di ritrovamenti inaspettati che potrebbero bloccare i lavori.
Oggi, l’adozione di tecnologie non invasive sta rendendo sempre più accessibili le analisi archeologiche preliminari. Droni, remote sensing, prospezioni geofisiche e immagini satellitari consentono di ottenere informazioni dettagliate senza intaccare il suolo, preservando così i reperti. Inoltre, l’uso dell’intelligenza artificiale, grazie a sofisticati software di analisi e a enormi banche dati, permette di elaborare previsioni sempre più accurate. Questo approccio innovativo ha un impatto significativo anche sulla gestione economica dei progetti: l’integrazione dell’archeologia nella fase di fattibilità delle opere pubbliche riduce le spese impreviste e previene ritardi. Gli archeologi, oggi, affiancano i tecnici nei computi metrici e nei quadri economici, assicurando che la progettazione tenga conto della possibile presenza di siti di interesse storico.

Un nuovo modello per la ricerca archeologica
L’obiettivo dell’archeologia preventiva è quello di evitare ritrovamenti che potrebbero bloccare i cantieri, ma anche di minimizzare l’impatto sugli stessi reperti. Le indagini tradizionali, infatti, comportano scavi che possono danneggiare i manufatti e rendere necessarie complesse operazioni di restauro e conservazione. Le moderne tecniche di diagnostica predittiva e i dati forniti da agenzie aerospaziali consentono di avere una visione più ampia e meno invasiva, salvaguardando il patrimonio storico.
Nonostante il rapido sviluppo di queste metodologie, l’archeologia preventiva deve ancora superare alcune difficoltà. Tra le principali criticità, la necessità di aggiornare i percorsi formativi universitari, ancora troppo focalizzati sulla ricerca piuttosto che sugli aspetti tecnici e normativi del settore. Inoltre, questa pratica innovativa fatica a essere adottata su larga scala dai piccoli enti locali, mentre è ormai uno standard nelle grandi committenze.

Il dibattito a tourismA 2025
Questi temi saranno approfonditi sabato 22 febbraio alle 16.00 nella sala 4 del Palazzo dei Congressi di Firenze, in un convegno patrocinato da Confprofessioni, che metterà a confronto esperti del settore sulle prospettive dell’archeologia preventiva. Il giorno precedente, venerdì 21 febbraio alle 16.35, sempre in sala 4, il professor Paolo Gull dell’Università del Salento presenterà il suo volume Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti. Norme, problemi, soluzioni (Ed. Legislazione Tecnica), un testo che analizza le sfide normative e operative della disciplina.
Tra gli eventi di spicco, domenica 23 febbraio alle 11.00, presso lo stand dell’ANA, sarà lanciata la seconda call for papers per la collana ANALYSIS. Archeologia – Professione – Ricerca, un’iniziativa volta a promuovere studi e ricerche sulle nuove applicazioni della tecnologia nel settore.
“L’archeologia preventiva è indispensabile per aiutare lo sviluppo infrastrutturale del Paese e conciliare ad esso la costante salvaguardia del patrimonio archeologico italiano”, afferma Marcella Giorgio, presidente di ANA. “È per questo che, nel rispetto dei principi della Convenzione Europea della Valletta, è sempre più evidente come sia necessario che tali procedure siano ampliate anche al settore privato, prevedendo aiuti economici e la defiscalizzazione dei costi sostenuti dai privati: una necessità che già alcune regioni italiane stanno prevedendo in forme autonome. Si delinea un panorama in cui è nettamente cambiato il ruolo dell’archeologo, divenuto consulente in costante dialogo tra le parti politiche, gli enti statali, la cittadinanza e i portatori di interesse, progettisti e specialisti dell’assetto del territorio, al fine di collaborare attivamente alla costruzione di politiche di pianificazione efficaci e non lesive di parte del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico italiano: un patrimonio che è fonte della nostra memoria collettiva di popolo e come tale va tramandato alle future generazioni. In questo momento, quindi, la sfida più grande si articola su due binari: il primo riguarda la formazione che ancora troppo spesso, a 20 anni dall’inizio delle procedure di archeologia preventiva, non prepara adeguatamente gli archeologi, ed il secondo è la mancata applicazione della procedura stessa, soprattutto da parte degli enti locali, anche a seguito di un carente aggiornamento dei progettisti o per pregiudizi di settore”.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE