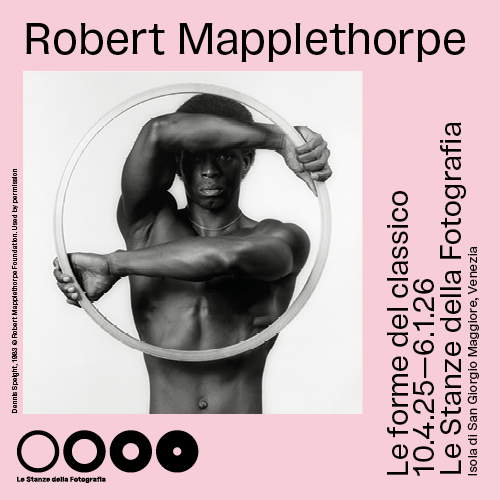Il Diario del Pontormo: la tormentata personalità di un genio
La nota
2009, Nona puntata
Grazie a un diario che il Pontormo scrisse negli ultimi anni della sua vita, oggi conosciamo molti aspetti della sua personalità, anche quelli più inaspettati. Con questo articolo Ambra ci offre una bella panoramica sul carattere del Pontormo e ci fa capire quali furono i motivi per i quali i contemporanei e la critica successiva non apprezzarono Jacopo Carucci, riscoperto soltanto nel Novecento. Anche per questa puntata un articolo da leggere con vivo interesse!
Scoperto in data piuttosto recente, il cosiddetto "Diario" di Jacopo Pontormo,
unico suo scritto autografo conosciuto col titolo aggiunto di "Diario di
Jacopo da Pontormo", fu scritto sugli stessi fogli di carta adoperati per i
disegni che l'artista compì nella chiesa fiorentina di San Lorenzo.
Il diario, oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, venne
scritto dall'artista durante i suoi ultimi tre anni di vita e lasciato incompiuto a
causa della sua morte avvenuta il 31 dicembre 1556.
Nel 1554, anno in cui si apre il "Diario", lo scritto viene inaugurato da un
trauma. Una domenica di gennaio Pontormo cadde, probabilmente
precipitando dall' impalcatura posta in San Lorenzo, così come successe a
Michelangelo durante i lavori della Sistina.
Pontormo racconta di essersi lussato una spalla, rotto il braccio e di aver per
tale sciagura trovato ricovero a casa del suo allievo Bronzino per sei giorni.
"Poi me ne tornai a casa e stetti male insino a Carnovale che fu adi' sei di
febraio 1554".
Dal diario emerge con grande chiarezza una personalità ipocondriaca, bizzarra e lunatica che viveva in una specie di tugurio reso da lui stesso inaccessibile agli estranei da un piccolo ponte levatoio. Leggendo i suoi scritti si comprende un'ostinata volontà nel segnalare con meticolosa precisione la sua dieta quotidiana, la sua miseria, i suoi tumulti gastro-intestinali: "Cenai la sera con Bronzino pollastrini morti dalla faina". E ancora: "Carnaccia" e "minestraccia", "farciglioni, gallinelle d' acqua e sanguinacci", pane al rosmarino, vitella, castroni, stinchi, fegatelli e porci, vermicelli, insalata invidia e frittate d' uovo persino più del Pereira di Tabucchi. Per non parlare dei "capogirli" e dello "spurgo", delle diarree (le "uscite"), della bile ("colera sanguigna e biancha") e della "cosa apicata" alla gola.
Anche Vasari ne "Le Vite" ci parla del giovane artista, fornendo inizialmente
un ritratto entusiasta del giovane Pontormo poiché era molto promettente, una
specie di bambino prodigio nella pittura; anche il grande Michelangelo
riconosceva l'eccezionale talento del Pontormo e gli aveva per questo previsto
una luminosa carriera artistica. Il Vasari stesso narra che Pontormo, nel 1510
dipinse una piccola Annunciazione per un amico e quando Raffaello,
trovandosi a Firenze vide l’opera, la lodò molto, cosa di cui l’artista
sedicenne sembra sia andato molto fiero tanto che, secondo il racconto
vasariano, ne "menò gran vanto".
Ma proprio questa profonda considerazione di sé, secondo Vasari lo avrebbe
portato successivamente ad abbandonare i buoni modelli della pittura
provando e riprovando innovazioni che al tempo non vennero comprese, ma
al contrario molto spesso giudicate bizzarre, smodate ed eccessive.
Vasari, inoltre sottolinea la sua incontentabilità e la sua solitudine che
neanche gli amici fraterni riuscivano a scalfire: "...domenica fu picchiato
alla porta da Bronzino, e poi il dì da Daniello; non so quello che si
volessino..." come scrive lui stesso.
Vasari infine non si esime dal giudicare negativamente il ciclo figurativo di
cui Pontormo parla nel suo diario, cioè i perduti affreschi nella chiesa di San
Lorenzo a Firenze. L’incarico fu affidato al pittore dal duca Cosimo I,
intorno al 1546, ma sopraggiunta la morte del pittore, l’affresco rimase
incompiuto e fu ben presto concluso da Bronzino. Purtroppo l’intera
composizione non ebbe lunga vita poichè fu distrutta in seguito ad alcuni
lavori di ristrutturazione del coro. Secondo il Vasari, in quell’opera non fu
"osservato nè ordine di storia, né misura né tempo... né alcun ordine di
prospettiva; ma pieno ogni cosa di ignudi".
Sottolineando la sua ricerca della perfezione e la costante insoddisfazione, il
Vasari dice: "Si travagliava il cervello che era una compassione, guastando
e rifacendo oggi quello che aveva fatto ieri". Si comprende come il giovane
artista fosse alla ricerca di un proprio stile ma forse, anche di una propria
poetica artistica. Si ritiene infatti che l'influenza sulla sua pittura di due
famosi artisti come Durer e Michelangelo lo avesse particolarmente
condizionato nel suo tentativo di evolvere una pittura personale all’altezza di
questi grandi maestri.
Il Pontormo, che pure ebbe protettori importanti come i Medici, non ebbe nel
tempo l'apprezzamento che invece fu tributato a suoi contemporanei come
Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo o il Franciabigio. Dopo le note del Vasari,
che non ne apprezzò le opere più mature, le citazioni di Pontormo furono per
molti secoli rare e poco interessate, segno del disinteresse che fino ai primi
del Novecento caratterizzò questo pittore e le sue opere.
Intorno ai primi anni del Novecento infatti, alcuni importanti saggi
dimostrano una inversione di tendenza. E' il caso ad esempio di un breve
scritto dello storico d'arte Frederik Clapp a suscitare un nuovo interesse per il
Pontormo.
Solo a quel tempo infatti, dopo il fiorire dell'impressionismo e delle avanguardie successive cominciarono ad essere rivalutate le anticipazioni del linguaggio pittorico moderno, liberato dall'obbligo di riprodurre fedelmente la realtà. Della maturità di Pontormo vennero così apprezzate le prospettive audaci e irreali, i gesti stilizzati ed innaturali, le vesti con i loro drappeggi artificiosi, le espressioni impaurite o pensose dei suoi ritratti, caratteristiche considerate a suo tempo del tutto negative, anche dallo stesso Vasari.
Ambra Grieco