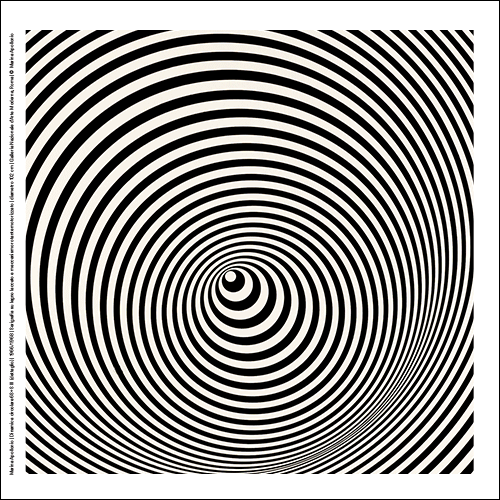Musei, non basta parlare di valorizzazione. Che cosa dovrebbe essere un museo?
A seguito della conferma delle nomine da parte del ministro dei beni culturali Dario Franceschini dei direttori di tre delle più importanti collezioni del paese (cioè il Museo di Capodimonte di Napoli, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e le Gallerie degli Uffizi di Firenze, musei autonomi che hanno fortemente accentrato la maggiorparte delle entrate private e pubbliche degli scorsi anni) insieme alla pubblicazione della Top 30 dei musei italiani che hanno ospitato ben 55 milioni di visitatori nel 2019, non si può non fare una riflessione e provare a fare un po’ di chiarezza sulla retorica della valorizzazione e del ruolo educativo dei musei.
 |
| Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Ph. Credit Finestre sull’Arte |
Una delle tendenze della contemporaneità, che le politiche museali non dovrebbero in alcun modo assecondare, è quella di promuovere una visione di pubblico come insieme di persone più o meno omogeneo e passivo che riempie spazi vuoti senza veramente sviluppare un proprio senso critico e visione più approfondita su ciò che si è visto. Succede oggi che le varie figure professionali coinvolte nel settore della cultura si facciano quasi irrevocabilmente portatrici di una prassi manageriale astratta spesso accompagnata da un pensiero sulla cultura incentrato sul profitto. È chiaro come le criticità di questo approccio non derivino dal modello “aziendale” in sé (dal quale oggi sarebbe praticamente impossibile separarsi del tutto data la quasi totale assenza di finanziamenti e investimenti pubblici), ma dai suoi obiettivi e dalle sue politiche che cambiano totalmente nel momento in cui la gestione diventa incentrata sul marketing fine a sé stesso. Semplicemente perché si cambia il pensiero sul visitatore. Quando parliamo di “mettere al centro le persone”, tuttavia, in che misura si rischia di avvicinarle in gran numero ma in modo superficiale?In che modo questo è motivo di “sviluppo” per il territorio? Come si misura?
Salvatore Settis (Italia S.p.A, piccola Biblioteca Einaudi 2007) traccia un punto di inizio nella nascita stessa del Ministero dei Beni Culturali nel 1974. Già dall’inizio fu reso un’ancella di altri ministeri (come quello del Lavoro) per poi nel 1998 (con Veltroni) cambiare il nome aggiungendo le “attività culturali” e iniziando l’apertura alle aziende per i servizi museali; successivamente, nel 1999, si inglobarono le competenze su sport e spettacolo. Con il trio Urbani-Tremonti-Berlusconi, poi, la svendita del patrimonio subisce un’accelerazione estrema, attraverso cessioni di gestioni di servizi e concessione dei beni stessi. Oggi, le politiche neoliberiste continuano col ministro attuale, tra cui le criticità dell’Art Bonus (2014) e la svalutazione delle soprintendenze, che ha portato tra le altre cose all’invenzione dello status di “museo autonomo” (legge 83/2014), tutto sotto la lunga ombra dell’assenza dolorosa di finanziamenti a largo spettro a scuola, cultura e ricerca (tra cui ricordiamo il taglio di un miliardo al bilancio del ministero nel 2008). Questa inquietante svalutazione della realtà culturale e dei saperi, di tutto ciò che, insomma, è conoscenza immateriale ed esigenza umana, da una parte ha causato incuria e degrado, dall’altra trova un’ingannevole via di fuga nel trasformarsi in oggetto di consumo svuotato di contenuto.
Se si vogliono stabilire dei modelli nuovi per il museo nella contemporaneità, dunque, non basta parlare di innovazione, né basta appellarsi al suo “ruolo educativo”. Serve, piuttosto, che il museo diventi istituzione politica, che criticizzi profondamente i propri contenuti e che si riconosca come bene comune (come lo sono storia e scienze). Dobbiamo infatti riflettere sulla parola “valorizzare” e capire cosa significa quando parliamo di beni culturali, materiali e immateriali. Innanzitutto, non vuol dire “dare” valore, ma semmai riconoscerlo, recuperandolo: proprio perché lo si è forse un po’ perso. In secondo luogo, cosa si deve valorizzare? Di certo non (solo) l’involucro dell’oggetto artistico, rendendo i musei dei set scenografici accattivanti. È stata infatti proprio questa strategia superficiale a far perdere quel “valore” alle opere d’arte, e a farci oggi rischiare di cadere in un circolo vizioso, in cui anche se il pubblico viene stimolato a breve termine, viene poi perso completamente a lungo termine. È ben altro ciò che rende il pubblico attivo e interessato al proprio patrimonio. E questo proviene senz’altro da una relazione lunga, silenziosa, ma ricca che le istituzioni culturali (per prima la scuola) devono iniziare ad instaurare con le persone.
Dunque, cosa c’è da valorizzare? Prima di tutto, anche prendendoci il rischio di essere un po’ astratti, la conoscenza. Si deve riconoscere la conoscenza come esigenza umana, quello spazio “comune” di cui parla l’antropologo François Jullien che genera la speranza per un confronto aperto tra le diverse soggettività culturali, in quanto “se l’universale dipende dalla logica e l’uniforme appartiene all’ambito dell’economia, il comune, invece, ha una dimensione politica: il comune è ciò che si condivide” (L’identita culturale non esiste, Torino, Einaudi, 2018, p. 9).
In secondo luogo, la trasmissione di questa conoscenza, che deve avvenire non solo tra collezione e visitatore, matra patrimonio e comunità. Come fare? È ovvio che non esiste un protocollo o uno standard museale valido per tutte le realtà (molti museologi e studiosi del patrimonio sono critici riguardo il concetto di standard, da Giovanni Pinna a Salvatore Settis). Se si ha come unico obiettivo quello di far “incontrare” pubblico e opera si creerà da una parte la solita separazione tra cultura “alta” e “bassa”, che conduce inevitabilmente all’esclusività (e quindi all’esclusione), dall’altra una cultura della superficie che tutto appiattisce. Bisogna che i musei e le politiche culturali in generale allarghino il loro spettro visivo e il loro campo d’azione. Bisogna che (torniamo sul punto) si riapproprino di una funzione sociale e di una funzione politica.
La missione del museo d’arte, a lungo privata di sostegno economico, ha forse smarrito il concetto di qualità pedagogica, culturale e umanizzante delle visite. Non si entra in contatto solo con degli artefatti ma con la loro storia e la loro natura di proposizione di un pensiero, di una reazione più o meno creativa a ciò che viviamo ogni giorno. Il museo deve occuparsi di raccontare opere e collezioni promuovendo una ricerca di qualità (sulla quale non si è mai investito a lungo termine in Italia) e attraverso la promozione del dibattito. Ed è per questo che, in quanto istituzione, il museo deve garantire certezze scientifiche sul patrimonio che conserva e iniziare a discuterne dopo aver messo a disposizione tutte le forme possibili di conoscenza sulla sua collezione. Tante storie, tutte accomunate da un linguaggio creativo solo umano. Ecco che quindi scompare il paradosso secondo cui i musei non debbano farsi portatori di un’“identità culturale”, ma incarnare a tutti gli effetti quella possibilità di trasformazione e ibridazione come atto politico. Politico in quanto propone un coesistere che è un vivere insieme tra diversi.
Quando troppo spesso si parla di “identità culturale” sia tra museologi nostrani sia come precetto per identificare un bene culturale o paesaggistico (Codice dei Beni Culturali Dlgs 42/2004) come un insieme di “valori culturali”, sia significando un rapporto reazionario di identificazione e di appartenenza ad una cultura localistica, non si dà il giusto valore al territorio. Il territorio è sempre stato, e lo sarà sempre, lo spazio della coesistenza tra diversi, della capacità di trasformazione, e dell’arte come manifestazione storica, civica e umana. Se però gli scopi educativi e gli investimenti sulla formazione (fuori e dentro il museo) rimangono in secondo piano, o peggio un peso, come si può sperare di diventare un punto di riferimento per il dibattito culturale?
Il museo d’arte deve politicizzarsi, non ideologizzarsi: proporre più che l’astrattezza di un concetto, l’intimità di un suggerimento. Tornare ad essere una musa. Un principio ispiratore che ci dice di scorgere l’universalità del linguaggio dell’arte, di comprendere come la bellezza e la storia non siano canoni estetici ma esigenze e ricerche umane. Se non riconosciamo questa forma di universalismo non potremo iniziare alcun discorso pedagogico né tantomeno parlare di potere emancipatore della cultura, perché finiremo con l’accettare un “pluralismo” che non vede l’invisibile, che non vede immagini, ma “figure” diverse da catalogare. Ciò che invece il museo deve diventare, come suggeriva il museologo Peter Vergo, avrà più a che fare con una sinfonia, in cui i vari linguaggi, codici (parole, colori, suoni e testi) e momenti (contemplazione, studio) si alternano e si lasciano spazio a vicenda. Il museo deve essere lo spazio in cui si inizia una ricerca, in cui si scopre la diversità non solo tra culture, ma tra individui, e in cui si comprende che la creatività attraverso le arti visive è solo una delle possibilità ed è capacità trasformativa. I risvolti sociali sono enormi. Dare un contenuto alle immagini. Questo è il fine che le nuove politiche culturali devono impegnarsi a perseguire.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Giulia Carletti
Storica dell'arte, specializzata in curatela e museologia critica a Milano (con tesi When will we come clean about our purposes?), insegna storia dell'arte nelle scuole secondarie a Roma. Interessata alle politiche culturali e ai loro strumenti di attivazione e trasformazione di una comunità, porta avanti i suoi studi sui beni culturali come beni comuni, collaborando con associazioni attive sul territorio e curando mostre con artisti emergenti a Roma e a Milano, come Ho fissato uno sguardo che stava per scomparire (2017) e Studio. Before but Around (2018).